Voci e storie dell’India tribale in memoria dell’attivista gesuita Stan Swamy
Oggi, 5 luglio, l’India dei movimenti sociali ricorda il secondo anniversario della morte (in detenzione!) dell’attivista gesuita Stan Swamy. E la buona notizia è che per onorarne non solo la memoria, ma il quotidiano impegno di ascolto, condivisione di saperi, attiva mobilitazione in favore delle popolazioni Adivasi del Jharkhand, nel cuore dell’India tribale dove da tempo viveva, è stato inaugurato in suo nome su You Tube un canale di storie orali, in continuo aggiornamento e liberamente consultabile alla voce appunto Stan Swamy Archive of Adivasi Narratives.
L’idea è venuta al video maker, poeta, impresario, Ranjan J. Kamath, tornato a vivere a Ranchi (capitale dello stato del Jharkhand, India Centrale) dopo una vita trascorsa per lo più a Londra, dopo le giovanili esperienze in campo teatrale a Calcutta. Diploma alla London Film School, autore di servizi e reportage per BBC, Channel Four, National Geographic, Discovery Channel, un curriculum che avrebbe potuto sfociare in chissà quale ambizioso progetto autoriale, e invece ha optato per questa full immersion in un mondo lontanissimo dai riflettori – e che sta velocissimamente scomparendo.
“Il fatto che con la scomparsa di una persona cara, scompare un intero mondo di storie, mi è diventato chiaro quando ho perso mia madre” ha spiegato Ranjan Kamath in occasione di una recente intervista. “Avendo scelto di vivere e lavorare a Londra, e solo ogni tanto in visita alla casa dei miei, mi sono trovato a constatare la perdita di un vissuto che potevo solo cercare di ricostruire da quanto era rimasto nei cassetti: le foto, qualche lettera o pagina di diario…
Nel caso delle popolazioni Adivasi questo processo di disparizione è ancora più doloroso, perché riguarda intere collettività e territori, caratterizzati da precise culture, miti di creazione, narrazioni. Che ogni giorno vengono proprio spazzati via da ciò che noi chiamiamo sviluppo e che (per chi lo subisce) significa l’espulsione dalle terre in cui si è nati, lo sfollamento chissà dove e (quel che è più crudele) l’impossibilità di tornare in quei villaggi in cui si è stati bambini, perché ormai rasi al suolo. E ciò che resterà, se resterà qualcosa, sarà il ricordo della voce dei nonni, o dei vicini, all’ombra di qualche albero… Una perdita immensa, per loro e anche per noi.”
Ed ecco in estrema sintesi spiegato l’indubbio valore di questo progetto, che sarebbe piaciuto così tanto al gesuita/attivista Stan Swamy: perché precisamente sull’esperienza dell’ascolto, di una vita vissuta in totale prossimità con le comunità Adivasi alle quali aveva dedicato tutte le sue competenze ed energie, aveva promosso quella mirabile iniziativa di accoglienza alle porte di Ranchi chiamata Bagaicha, ovvero ‘giardino’. Per suggerire che ogni problematica, anche la più apparentemente insolubile poteva diventare un seme, l’inizio di qualcosa; e che anche dall’ingiustizia più mortificante poteva scaturire un processo di consapevolezza sul fronte dei diritti, a volte vincente.
I guai erano cominciati per Stan Swamy con la pubblicazione di un’inchiesta che evidenziava l’arbitrarietà dei sempre più frequenti casi di giovani Adivasi arrestati per supposti legami con il Movimento Naxalita. Era il 2010 e le aree tribali dell’India centrale (che purtroppo coincidono con una ricchezza mineraria immensa e in gran parte ancora non sfruttata) erano il teatro di una vera e propria guerra civile, tra le milizie dei vigilantes reclutati dal Governo e i militanti naxaliti che, sebbene scarsamente equipaggiati, vedevano nella lotta armata l’unico modo di difendere le loro terre dalla brutalità dell’estrattivismo.
In quella prima inchiesta, padre Swamy denunciava che nel 97% dei casi le famiglie dei giovani detenuti erano così povere da non potersi permettere alcun supporto legale. E una successiva inchiesta nel 2014 rivelò la presenza di ben 6000 adivasi in attesa di giudizio nelle prigioni del Jharkhand, con motivazioni debolissime – e conseguenze devastanti per le famiglie, oggetto di continue vessazioni, di fatto condannate insieme ai loro congiunti. E nel 98% dei casi senza alcune prova: intere comunità “colpevoli a meno di non essere dichiarate innocenti” come lo stesso Stan Swamy avrebbe documentato con un lungo articolo per il web site Sabragindia.in, e come qualche tempo dopo avrebbe denunciato anche l’eminente avvocato Virginius Xaxa (che anche la nostra testata ha intervistato qui).
Ciò che Padre Swamy cercava di difendere, al di là dei tanti casi di arbitraria detenzione, era un preciso allegato della Costituzione indiana che sancisce il dovere di consultazione del Consiglio Direttivo Tribale per qualsiasi progetto riguardante le aree di pertinenza – nonché il diritto dello stesso CDR di opporsi, in caso di impatti negativi sul territorio. Allegato regolarmente ignorato, insieme a una legge del 1996 (noto come PESA Act) e alla ancor più importante Legge per il Diritto delle Foreste (2006), che riconoscono la ricchezza del patrimonio di cultura e tradizioni delle comunità Adivasi, e il dovere/necessità da parte del Governo Indiano di contribuire alla loro preservazione.
Nell’ottobre del 2018 ecco una prima incursione della NIA (National Investigation Agency) nel quartierino che Stan Swamy occupava a Bagaicha. E lunghi interrogatori anche nei mesi successivi. L’accusa è semplicemente assurda: connivenza nei disordini scoppiati il 1 gennaio dello stesso anno a Bhima Koregaon, nel Maharashtra (una storia che da sola richiederebbe ben più di un articolo e che per il momento ci limitiamo a menzionare) e legami con il movimento maoista, nell’ambito di un ipotetico complotto per uccidere il Primo Ministro Narendra Modi.
Con gli stessi capi di imputazione le manette stavano già scattando per una quantità di attivisti, avvocati, intellettuali, responsabili di varie ONG in tutta l’India – e le manette scatteranno anche per Stan Swamy esattamente due anni dopo quel primo raid, 8 ottobre 2020 (ne abbiamo scritto qui).
A nulla servirono le catene umane e i sit in di protesta per giorni e giorni, in tutta l’India e anche in Canada, America, UK – e neppure la considerazione per le precarie condizioni di salute di un anziano 83enne, malato di Parkinson al punto da non riuscire a tenere una tazzina in mano. Persino la richiesta di una cannuccia, per agevolarlo in qualche modo nell’assunzione di bevande e cibi il più possibile liquidi, richiese una Petizione Internazionale.
Ci pensò il Covid-19, a liberarlo da una detenzione divenuta intollerabile, ingestibile persino per i suoi carcerieri: nella prigione di Taloja poco fuori Mumbai, sovraffollata oltre ogni umana immaginazione persino durante l’epidemia – e con i compagni di cella che si avvicendavano durante i pasti per imboccarlo.
Un’importante indagine, effettuata dalla società americana Arsenal Consulting (specializzata in analisi forensiche di apparecchiature digitali) ha appurato nel dicembre dell’anno scorso che le prove che motivarono l’arresto dell’anziano padre gesuita, erano frutto dell’intervento di un hacker che era riuscito ad inserire nel suo computer decine di files compromettenti – una rivelazione che i media indiani non mancarono di registrare con una certa attenzione, che avrebbe dovuto motivare la riapertura dell’inchiesta (e senz’altro scagionare l’imputato, almeno post mortem). E invece macché: Stan Swamy come tutti gli altri quindici imputati nello stesso caso, restano imputati, anche se provatamente vittime di hackeraggio.
Tutto questo è stato di nuovo ricordato qualche giorno fa, 26 giugno, in occasione del Memoriale che gli attivisti di PUCL (acronimo che sta per Unione Popolare per le Libertà Civili) hanno organizzato al XISS (Xavier Institute for Social Studies) di Ranchi. A presiedere l’affollato incontro c’era P. Sainath, giornalista pluripremiato e fondatore del sito web PARI da cui spesso abbiamo attinto anche per questa testata. “L’istituzionalizzazione dell’ingiustizia è diventata una triste consuetudine” ha esordito, sottolineando una volta di più il nefasto ruolo del fondamentalismo non solo nella sfera religiosa, ma nella concezione stessa di uno sviluppo unicamente orientato alla massimizzazione del profitto per pochi, a fronte dell’infelicità dei molti e mediante la vera e propria criminalizzazione di ogni espressione di dissenso.
“Non tutto è perduto” ha aggiunto. “Tra l’ottimismo a tutti i costi, che guarda solo alla crescita del PIL, e il cinismo del pessimismo che di fatto replica il mantra del TINA, dell’assenza di possibili alternative, c’è ancora qualche speranza, a patto che anche i media e la società civile svolgano il loro ruolo, e si impegnino almeno un po’ lunga la strada tracciata (tra gli altri) da un Stan Swamy: nella difesa della giustizia non in astratto, ma come espressione di umana empatia, di massimo ascolto per il prossimo in difficoltà, di fondamentale moralità.”
Un ascolto e una mission che, senza bisogno di grandi budget, armato unicamente della sua telecamera, essenzialmente animato da un sentito desiderio di restituzione per le zone più martoriate della sua natìa India, dopo anni passati a viaggiare e documentare in giro per il mondo, il videomaker Ranjan J. Kamath sta a suo modo portando avanti con questo Stan Swamy Archive of Adivasi Narratives su You Tube. Con le storie di coloro che vennero displaced, espropriati negli anni ’50 dalla HEC (Heavy Engineering Corporation), oltre 32 villaggi e relative terre agricole cancellati in cambio di promesse mai mantenute.
Con il vissuto di un certo Devendranath Champia, che da umile Adivasi si è dato alla politica sperando di riuscire a cambiare qualcosa. E con l’incredibile progetto di Sushma Asur, che benché proveniente da un gruppo tribale tra i più ostracizzati dell’India ha creato dal nulla insieme ad altr* del suo villaggio un emittente radio che si chiama appunto Asur Radio. E poi ci sono i tanti e bellissimi festival, per esempio il Sarhul, che inaugura il nuovo ciclo di vita ad ogni primavera e che possiamo seguire in tutti i dettagli di preparazione come se fossimo lì… in Jharkhand!
Unica pecca: se non sai almeno un po’ di Hindi puoi solo guardare, ma ti perdi tutto il parlato – che è davvero un peccato, specialmente se l’intervistato è un certo Bhudan Singh Deogam che racconta dei miti di creazione dell’etnia in cui è nato, i tribali Ho, nel sud della regione. Ma giustamente Ramjan J. Kamath fa notare che si tratta di un work in progress totalmente autofinanziato – chissà che proseguendo nel percorso non gli arrivi qualche contributo per aggiungere i sottotitoli, almeno in inglese…
“Ma anche così questo materiale è prezioso” fa giustamente notare. “Prezioso innanzitutto per le comunità Adivasi che finalmente si vedono rappresentate: stiamo parlando di oltre cento milioni, la popolazione indigena più numerosa del pianeta, da sempre tenuta ai margini. Ed è prezioso anche per le centinaia di milioni di indiani che non essendo Adivasi non si sono mai preoccupati di saperne qualcosa, della loro esistenza, dei loro bellissimi villaggi, delle loro foreste e montagne, tra l’altro culla di tutte le possibili mitologie di cui nel corso del tempo si è nutrito anche l’induismo. Per cui, si vedrà: il mio è un progetto di Enciclopedia Dinamica ed Esperienziale, massimamente aperto al contributo di chi vorrà affiancarmi lungo il cammino.”










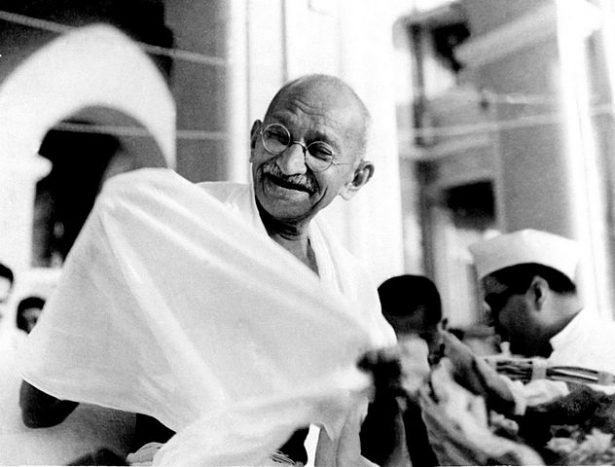





















Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!