Uscire dal falso dilemma “lavoro o ambiente” | Lorenzo Feltrin
L’ambientalismo operaistico del gruppo italiano Porto Marghera ricongiunge il mondo del lavoro e la comunità nella lotta contro la “nocività” capitalista.

Nel pieno di un rinnovato aumento delle disuguaglianze, un’ondata di proteste sta attraversando tutta l’Italia, da Nord a Sud. Da un lato, la pandemia ha generato un’impennata delle controversie relative alla salute sul posto di lavoro e delle manifestazioni per proteggere il reddito dei lavoratori colpiti dalle restrizioni sanitarie. Dall’altro lato, abbiamo anche assistito a interventi di successo, guidati dalla destra e infusi con una serie sconcertante di teorie del complotto in risposta a tali misure.
Diversamente dallo slogan delle proteste che hanno avuto luogo a Napoli, il 23 ottobre 2020 – “Se ci richiudete, pagate!” – la destra non chiede forme di prevenzione più collettive e ugualitarie. Chiede piuttosto che “l’economia” possa funzionare senza intoppi. Eppure, questo discorso sembra attirare l’attenzione di molti lavoratori, – giustamente preoccupati per l’impatto che mesi e mesi di isolamento avranno sulle loro condizioni di vita – molti dei quali trovano una risposta nel negare la gravità della pandemia e, più in generale, della crisi ambientale.
Fin da subito, gli analisti marxisti avevano sottolineato che lo studio della crisi sanitaria globale non può prescindere da quello del sistema economico, che plasma costantemente la nostra quotidianità. Non si tratta solo di sistemi sanitari inadeguati: la diffusione del nuovo virus dall’animale all’uomo è stata causata dall’imperativo capitalista di sfruttamento delle “risorse” naturali, al fine di salvaguardare i margini di profitto che guidano l’economia.
In un certo senso, la pandemia è una manifestazione globale del dilemma “lavoro o ambiente” e del relativo “ricatto del lavoro”, una situazione in cui i lavoratori si trovano a dover scegliere tra la difesa della salute e dell’ambiente e mantenere il proprio posto di lavoro. Non esiste una soluzione semplice a questo dilemma.
Tuttavia, le riflessioni sviluppate circa 50 anni fa da un collettivo operaio, composto principalmente da lavoratori impiegati nel complesso industriale a tossicità elevata di Porto Marghera, a Venezia, potrebbero ancora essere una fonte di ispirazione.
AMBIENTALISMO OPERAISTA
L’operaismo è una corrente della nuova sinistra, emersa con lotte degli operai italiani negli anni ’60 e diffusasi principalmente attraverso le riviste Quaderni Rossi e Classe Operaia. Questa tendenza teorica ha determinato l’ascesa di diverse organizzazioni radicali tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, come Potere Operaio, Lotta Femminista e Autonomia Operaia.
L’operaismo non sembra avere molto a che fare con le questioni relative all’ambiente e alla salute, ma questa impressione trascura le elaborazioni teoriche sulla nocività condotte da parte del gruppo operaio di Porto Marghera. Il gruppo era attivo con nomi diversi, tra i primi anni ’60 e il 1980, nel grande polo industriale situato nell’area comunale di Venezia. Ha avuto origine dall’incontro tra operai attivisti, studenti e intellettuali, tutti ugualmente scontenti della linea del Partito Comunista Italiano e del suo sindacato associato, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro.
Le loro elaborazioni sono poco conosciute – conseguenza del fatto che i protagonisti di questa esperienza sono stati operai e tecnici di fabbrica, e non “intellettuali a tempo pieno”. Tali riflessioni sono sparse tra una miriade di volantini di fabbrica e articoli di giornale pubblicati su Potere Operaio e dopo sulle riviste locali del gruppo, Lavoro Zero e Controlavoro.
La parola nocività fa riferimento alla capacità di causare un danno. Utilizzato dal movimento operaio, questo termine ha iniziato ad avere più sfaccettature, comprendendo sia i “danni alla salute” (danni umani) sia la “degradazione ambientale” (danni non-umani). Il gruppo di Porto Marghera sosteneva che questa nocività fosse inerente al sistema capitalista. Un’idea che si diffuse verso la fine degli anni ’60, un momento storico in cui l’operaismo iniziava ad avere una notevole influenza nelle lotte di classe di Porto Marghera, a causa dell’estrema tossicità a cui i lavoratori erano esposti nelle fabbriche locali, in particolare, nella gigantesca Petrolchimica Montedison. Questo caso di ambientalismo operaio è straordinariamente previgente. Fin dal 1968, ha coinvolto i lavoratori impiegati in industrie altamente inquinanti, i quali denunciavano la degradazione ambientale – oltre a quella relativa alla salute umana – causata dalle stesse aziende per cui lavoravano.

Il gruppo che aveva teorizzato la nocività era guidato da un tecnico del Petrolchimico, Augusto Finzi. Nato nel 1941 da una famiglia di ebrei, Finzi aveva vissuto parte della sua infanzia in un campo profughi in Svizzera per sopravvivere all’Olocausto, durante il quale l’industria chimica tedesca aveva giocato un ruolo determinante e terribile. Dopo il diploma in chimica nel 1960, Finzi ha iniziato subito a lavorare nell’unità petrolchimica VCM-PVC. Nel 2004, morì di cancro. Una morte prematura era infatti molto diffusa tra i suoi collaboratori al Petrolchimico.
Il gruppo di Porto Marghera aveva trovato un nesso tra la nocività e la “strategia operaista del rifiuto”. In quest’ottica, il lavoro capitalista consiste nella produzione di valore e, quindi, nella riproduzione di una società basata sullo sfruttamento. La lotta di classe non è dunque un’affermazione del lavoro come valore positivo, bensì la sua negazione. Come ha affermato Mario Tronti: «Lotta operaia contro il lavoro, lotta del lavoratore contro se stesso – in quanto lavoratore,- il rifiuto della forza-lavoro di diventare lavoro».
La combinazione tra il rifiuto del lavoro e le pietose condizioni di salute e di sicurezza a cui erano sottoposti gli operai, ha portato il gruppo di Porto Marghera alla consapevolezza che il lavoro capitalista fosse intrinsecamente nocivo:
I lavoratori non entrano nelle fabbriche per indagare ma sono costretti a farlo. Il lavoro non è uno stile di vita, è l’obbligo di vendere se stessi per sopravvivere. È lottando contro il lavoro, contro la vendita coercitiva di se stessi, che i lavoratori si scontrano con tutte le norme della società. È lottando per lavorare meno, per non morire avvelenati dal lavoro, che combattono anche contro la nocività. Perché è nocivo svegliarsi ogni giorno per andare a lavoro, è nocivo accettare condizioni e ritmi di produttività, è nocivo abituarsi al sistema dei turni, è nocivo tornare a casa con un salario che ti costringe a tornare in fabbrica il giorno dopo.
volantino di fabbrica Assemblea Autonoma, 26 febbraio 1973
Una versione più recente di tali riflessioni fu parzialmente sistematizzata nell’articolo “Contro la nocività”. I suoi assunti principali sono ancora oggi molto utili:
[…] è necessario distinguere immediatamente tra una forma di nocività – nella sua accezione tradizionale – legata all’ambiente di lavoro (sostanze tossiche, fumi e vapori, materiali polverosi, rumori, etc.), e quella connessa, più in generale, all’organizzazione capitalistica del lavoro. Non ci sono dubbi sul fatto che il secondo tipo di nocività abbia un impatto più profondo sull’equilibrio psicofisico del lavoratore. Lo rende un’entità alienata, un pezzo della macchina produttivista, completamente distaccato dal risultato finale del suo lavoro e soggetto alla costante usura che comporta un uso disumano della sua forza-lavoro. Un’usura capitalista, guidata esclusivamente dai profitti della classe dirigente.
Comitato Politico, 28 febbraio 1971
Secondo questa prospettiva, le battaglie rivolte esclusivamente alla nocività tradizionale – quella proposta dai sindacati locali per modificare l’ambiente di lavoro – non bastano, perché sarebbero sfruttate solo per soddisfare le esigenze del processo di ristrutturazione capitalista, ignorando il nocciolo della questione – ad esempio, la priorità della produzione di valore rispetto alla vita stessa: «Nella nuova industria, caratterizzata da una riduzione molto modesta delle sostanze tossiche e, di conseguenza, delle tipiche malattie professionali, ci sarà un forte aumento dei disturbi psicologici». Il gruppo, al contrario, aveva elogiato la tattica della riduzione del tempo di lavoro senza tagli ai salari, al fine di trasformare la lotta per la sopravvivenza nelle fabbriche in un movimento per la liberazione dal lavoro capitalista.
Seguendo le orme del pioniere dell’operaismo italiano, Raniero Panzieri, una critica alla tecnologia capitalista iniziava a comparire nell’equazione del gruppo di Porto Marghera (vedi il “Manifesto del Rifiuto del Lavoro”). Non bastavano macchinari più sicuri, «ma forse era necessaria anche una nuova stirpe di ingegneri, per costruire macchine che non rovinino la salute e, al contempo, aumentino notevolmente i profitti».
Il gruppo si distaccò dalla linea d’azione dei sindacati, i quali richiedevano maggiori investimenti per proteggere i livelli occupazionali – invece che un minor numero di ore di lavoro –, in quanto tali investimenti si sarebbero tradotti in automazione e licenziamenti, siccome «i capi utilizzano ancora l’automazione in funzione anti-operaia. L’introduzione di nuove macchine e computer non porta a una riduzione delle ore di lavoro ma a una crescita dei profitti». In condizioni simili, l’automazione non dovrebbe essere implementata. Il gruppo, quindi, adottò un approccio trasformativo, in antagonismo con la tecnologia capitalista, che evitava sia la visione strumentista – secondo la quale le macchine capitaliste sono mezzi neutrali che possono essere riutilizzate senza problemi per finalità non capitaliste – sia il rifiuto categorico della tecnologia in quanto tale.

Negli anni ’70, il gruppo di Porto Marghera integrò il suo approccio quantitativo del “più soldi, meno lavoro” con una riflessione qualitativa sul “cosa, come e quanto produrre”. Una riflessione connessa al concetto di “auto-valorizzazione proletaria”, o emancipazione della classe operaia, attraverso la produzione, riappropriazione e condivisione dei valori d’uso per il raggiungimento di un adeguato livello di soddisfazione collettiva. Il gruppo ha quindi aggiunto l’auto-valorizzazione alla lotta contro la nocività, proponendo l’elaborazione di un contro-potere e ricongiungendo le battaglie sul posto di lavoro e quelle della comunità, per orientare una transizione verso un sistema basato sui bisogni collettivi che comporta un rapporto di reciproco sostegno tra la salute umana e l’ambiente.
In questo contesto, è stato ritenuto “più importante modificare il contenuto della produzione piuttosto che prendere [semplicemente] il controllo dell’apparato produttivo.” Ma tutte queste idee cosa ci dicono della crisi che stiamo attualmente vivendo?
“NOCIVITÀ” DURANTE UNA PANDEMIA
In un sistema capitalistico, i modi in cui la nocività si palesa dipendono dalla legge del valore e dalle pressioni competitive sul processo di lavoro. Le pandemie sono avvenute anche nelle società pre-capitaliste. Ma in società del genere, il lavoro ha lo scopo principale di produrre beni d’uso. Questo poteva avvenire in diversi modi, ad esempio con la forzatura da parte di un feudatario, il quale si appropriava di una parte della produzione; ma anche sulla base di una pianificazione democratica in cui si stabiliva cosa e quanto produrre, e a quali condizioni.
In un sistema di produzione capitalistico, invece, i lavoratori devono assicurare ai loro datori un certo livello di redditività. Allo stato attuale della pandemia, la nocività dei milioni di contagi e decessi è stata determinata e modellata dalle pressioni competitive, che portano alla distruzione dell’ambiente e legano a essa la sopravvivenza dei lavoratori stessi.

In Italia, la risposta del governo alla pandemia ha incluso un blocco dei licenziamenti per lavoratori con contratto a tempo indeterminato, l’indennità di sostegno collegata al reddito per i lavoratori autonomi e l’ampliamento della capacità degli ospedali pubblici. Dato che le entrate dello Stato dipendono dall’accumulazione di capitale, è certo che queste tecniche di mitigazione sono analogamente subordinate alla conservazione della modalità di produzione. In quest’ottica, i costi delle protezioni parziali in ambito sanitario e di sussistenza, recentemente concesse ai lavori in diversi paesi, saranno alla fine scaricati sulla classe operaia attraverso cicli di austerità e ristrutturazione proporzionali all’enorme gravità della crisi.
Così come la sussistenza della classe operaia dipende dal lavoro capitalista, i lavoratori hanno bisogno di lavoro e, quindi, di una infinita crescita economica, per sopravvivere… indipendentemente dalle conseguenze sulla salute e sull’ambiente. Questa sorta di “ricatto del lavoro” non esiste solo su larga scala, nei complessi industriali con livelli di tossicità preoccupanti. In realtà, influenza tutta la società capitalista ed è intrinseca in essa. Se i bisogni riproduttivi – come un’ecologia sana – sono alla base dell’ambientalismo operaista, il legame tra la riproduzione dei lavoratori e il lavoro capitalista è alla base del negazionismo della classe operaia, e deve essere spezzato.
Nell’attuale ciclo di lotte contro il capitalismo, gli interventi dovrebbero costruirsi sulla richiesta di soddisfare nel lungo termine i bisogni riproduttivi dei lavoratori, così da rendere l’ambientalismo operaista l’alternativa vincente al negazionismo operaio. Nelle proteste contro le misure adottate dal governo italiano per fronteggiare il COVID-19, lo slogan “Reddito e salute per tutti” va nella stessa direzione dell’ambientalismo operaista, mentre “Lasciateci liberi di lavorare” tende verso il polo del negazionismo, poiché fa riferimento anche a posti di lavoro in cui il rischio di diffusione del virus è molto elevato.
Quindi, se i lavoratori dipendono dalla nocività del lavoro capitalista per vivere, in che modo possono lottare per sconfiggerlo? La proposta iniziale del gruppo di Porto Maghera, in linea con la strategia operaia del tempo, era una richiesta egualitaria per “più soldi, meno lavoro”, con l’obiettivo di rompere la catena salario-produttività, gettando il capitalismo in una crisi terminale – o almeno, così si sperava. Questo ha portato alla richiesta di un “salario garantito per tutti”, simile alle attuali proposte radicali per un reddito universale. Più avanti, a questo piano quantitativo il gruppo ne aggiunse uno qualitativo che, attraverso un approccio trasformativo, in antagonismo con le tecnologie capitaliste, ha posto le basi per la costruzione di un contro-potere in grado di cambiare il “cosa, come e quanto produrre”.
Se applicata oggi, questa strategia per risolvere il dilemma “lavoro o ambiente” potrebbe apparire come un binario caratterizzato da un numero ridotto di ore di lavoro e da una radicale redistribuzione della ricchezza, diretto verso una produzione più sostenibile e non mercificata, nonché verso la trascendenza del capitalismo, articolata con gli aspetti anti-razzisti, femministi e anti-imperialisti della lotta.
Un tentativo è stato fatto dal Climate Camp di Porto Marghera, organizzato da Rivolta Social Center, uno spazio autonomo che riprende il filo dell’ambientalismo operaista iniziato dal gruppo di Porto Marghera e portato avanti dai sindacati di base e dagli ambientalisti di sinistra, negli anni ’80 e ’90.
Con la partecipazione attiva dei sindacati radicali, il Climate Camp ha approvato una versione ambientalista del reddito universale – di cui una parte è in denaro e l’altra in beni e servizi demonetizzati – che si distingue notevolmente da quella accelerazionista, nella misura in cui tale reddito sarebbe finanziato attraverso la degenerazione e la radicale ridistribuzione della ricchezza, invece che con un’ulteriore automatizzazione capitalista. Allo stesso tempo, devono cambiare anche il “cosa” e il “come” della produzione.
Le organizzazioni che hanno partecipato al Climate Camp si stanno mobilitando per richiedere che la sussistenza non derivi dal lavoro a ogni costo – considerando anche il grave rischio di contagio del virus – ma da salari più alti e da tassazioni progressive.
La soluzione al dilemma “lavoro o ambiente” può essere costruita attraverso la rottura del legame tra riproduzione dei lavoratori e produttività capitalista, ricongiungendo le battaglie sul posto di lavoro con quelle della comunità. Unite contro la nocività capitalista.
Lorenzo Feltrin

Lorenzo Feltrin è un ricercatore italiano interessato alle aree del lavoro, dei movimenti sociali e dell’ecologia politica. Attualmente sta lavorando sul settore petrolchimico, con un focus sulla zona industriale di Porto Marghera, Venezia.
Fonte: Roar Magazine, 16 novembre 2020
Traduzione di Benedetta Pisani per il Centro Studi Sereno Regis




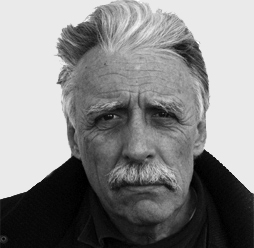

![serviziocivile_2764_588[1]](https://serenoregis.org/wp-content/uploads/2010/08/20100826serviziocivile_2764_5881.jpg)






















Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!