La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare 1914-18
Marco Mondini, La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare 1914-18, il Mulino, Bologna 2014, pp. 458, euro 28.
L’Italia in guerra
 È il suo stesso autore, Marco Mondini, a precisare che La guerra italiana (il Mulino 2014) è un libro nel quale non si cerca di «ricostruire integralmente ciò che la guerra fu nei suoi aspetti militari, politici o economici», quanto di far emergere le specifiche caratteristiche che ebbe l’intervento italiano nella prima guerra mondiale. E cerca di farlo attraverso l’analisi culturale di tre momenti chiave dell’esperienza bellica: la partenza, il racconto della guerra e il ritorno a casa.
È il suo stesso autore, Marco Mondini, a precisare che La guerra italiana (il Mulino 2014) è un libro nel quale non si cerca di «ricostruire integralmente ciò che la guerra fu nei suoi aspetti militari, politici o economici», quanto di far emergere le specifiche caratteristiche che ebbe l’intervento italiano nella prima guerra mondiale. E cerca di farlo attraverso l’analisi culturale di tre momenti chiave dell’esperienza bellica: la partenza, il racconto della guerra e il ritorno a casa.
L’entrata dell’Italia nel primo conflitto mondiale si caratterizzò per un lungo e aspro dibattito tra interventisti e neutralisti, che ebbe quasi i modi di una guerra civile “fredda” (nella quale peraltro non mancarono morti e violenti scontri di piazza) e lasciò nel paese una profonda frattura, che si sarebbe riverberata nella storia successiva. Alla fine, pur minoritaria, la fazione interventista prevalse grazie principalmente alla pervasività della propaganda mediatica e alla maggiore capacità di mobilitazione nei centri urbani. L’Italia fece così il suo ingresso nella Grande Guerra, combattuta da circa cinque milioni di soldati italiani e costata la vita a 650 mila uomini, oltre a un milione di feriti, tra cui 500 mila mutilati.
Molto significative le pagine del libro dedicate al momento del raccontare, dove si esplicita innanzitutto una polarità tra la testimonianza del combattente, che prova a dar corpo nella scrittura all’esperienza di trincea vissuta in prima persona e la prosa del giornalista che a fini propagandistici ricrea, senza averla vissuta, una guerra edificante e rassicurante ad uso dei lettori di quotidiani e riviste: «in tutti i paesi belligeranti la stampa svolse infatti una propria “missione patriottica” la cui priorità non era certo un’informazione corretta».
Si trattava infatti di contribuire alla costruzione del consenso oscurando tutto il dramma quotidiano, il disagio fisico e le intollerabili sofferenze che si pativano in prima linea, in nome di una guerra estetizzata e quasi ridotta a episodio di folklore e di cimento agonistico. Anche il cinema italiano per decenni divulgherà un’immagine della guerra glorificante e la meno traumatica possibile, in cui la brutalità della morte concreta si lascia ai margini della rappresentazione. Bisognerà attendere una quarantina d’anni per arrivare a «una svolta nel linguaggio della messa in scena filmografica della guerra», con La grande guerra (1959) di Mario Monicelli l’Italia uscirà infatti «per la prima volta dall’orizzonte convenzionale degli stereotipi eroici e celebrativi».
Nelle vicende del ritorno colpiscono le pagine dedicate a un fatto uscito, anzi verosimilmente mai entrato nella memoria collettiva degli italiani, vale a dire i campi di detenzione che il governo istituì per i soldati reduci dalle prigioni di guerra nemiche, per sottoporli a una sorta di quarantena morale. In questi campi trovarono la morte, in genere per infezioni mal curate o influenza spagnola, molte centinaia di soldati italiani.
Il tema del ritorno è quindi indissolubilmente intrecciato alla sorte di coloro che non hanno più fatto ritorno e alla necessità, che riguardò tutte le nazioni europee, di trovare una giustificazione accettabile alle immense perdite umane subite. Da qui la capillare diffusione di un culto dei caduti, in genere improntato a una sorta di «semantica del sacrificio»: la morte in guerra va considerata un nobile dono offerto alla patria, ai vivi il compito di tenere desta la memoria di un tale sacrificio e la necessità di mostrarsi all’altezza dei morti nel caso in cui questo compito militare dovesse ripresentarsi.
Questo culto dei caduti toccò la sua enfasi celebrativa negli anni Trenta, quando il regime fascista avocò a sé la gestione della memoria con la costruzione dei grandi sacrari militari e portò così a compimento quella strumentalizzazione della Grande Guerra che aveva avviato sin dalle sue origini, facendo di essa la prima guerra fascista, infatti «i nuovi santuari divennero teatri di pedagogia collettiva: le forme funerarie dovevano stimolare non il compianto ma l’esaltazione per il trionfo e la vittoria, collocando al centro della devozione degli italiani l’idea della nuova potenza imperiale, di una nazione perennemente in armi e del suo duce naturale, pronto a guidarla ai più alti destini». In questo contesto sparuti e solo in centri minori furono, prima dell’avvento del fascismo, i tentativi di promuovere una contromemoria fatta di lapidi che evocavano una «guerra non trionfale compimento del Risorgimento, bensì orrenda carneficina e immane flagello».




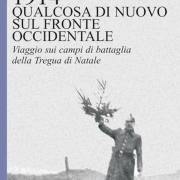























Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!