Terra mobile: confini, differenze, geografie
Enzo Ferrara intervista Paolo Giaccaria
“L’Europa è cambiata – scriveva Laura Conti nell’incipit di La condizione sperimentale, ritornando al tempo dell’occupazione nazi-fascista. – La sua geografia stessa è scomparsa; o modificata; comunque non conta più. Fiumi o valli non importano a nessuno; a nessuno le catene o i massicci montani. Una geografia lineare è emersa dalle viscere della terra, come uno scheletro; o le si è sovrapposta, come una rete che la imprigiona”. È lugubre un’idea del mondo come spazio uniforme e liscio, con i fiumi simili a canali, le montagne come ostacoli (perforabili), i mari come zone prive d’interesse ingegneristico salvo sulle coste o dov’è possibile porre argini a conflitti dati come avanzi del passato che allontana l’incombente futuro, magnifico e progressivo. Almeno in apparenza, questa è l’idea che si fa strada con la globalizzazione: un mondo piatto, netcentrico, una ragnatela ai cui nodi “sempre lo stesso paese si ripete, con poche varianti – così continuava Laura Conti – sempre lo stesso villaggio con la stessa rigorosa geometria e le stesse mura”. In realtà, a guardar bene più che un immobilismo si osserva un continuo divenire. Frontiere geopolitiche e culturali un tempo poderose continuano a cadere, ma altrettante ne risorgono e nuove barriere più sottili e selettive si pongono in difesa di vecchie diseguaglianze mentre le stesse recinzioni poste contro la libera circolazione di uomini e donne si aprono a merci e capitali, come fosse in corso una metamorfosi di limiti e confini.
Le bussole della modernità sono instabili, è difficile costruire mappe affidabili per il mare aperto della globalizzazione. Fortunatamente esistono portolani che possono guidare almeno la navigazione sottocosta, tracciando i tanti varchi culturali della crisi in corso. Uno di questi è Terra mobile.Atlante della società globale (Einaudi, Torino 2014) curato da Paolo Perulli, docente di Sociologia economica ad Alessandria, in collaborazione con studiosi accomunati da un’allergia verso le categorie convenzionali e da un interesse epistemologico per la dimensione locale della geografia economica. Perulli, già autore di Visioni di città. Le forme del mondo spaziale (Einaudi, Torino 2009), ha provato a mettere in discussione con ottica interdisciplinare e intergenerazionale un repertorio di definizioni di filosofia, diritto, economia, urbanistica, che esaltano la centralità degli spazi antropizzati con metafore della trigonometria, della fisica e delle scienze pure. Con interventi di antropologi, sociologi, geografi, filosofi – anche i confini di questi ambiti disciplinari sono in discussione, – Terra mobile è costruito attorno a coppie di termini concettuali posti in contrapposizione: Recinto/Spazio globale, Terra Mare/Aria, Confine/Soglia, Separazione/Relazione, Sovraordinazione/Subordinazione, Scala geografica/Spazialità urbana, Funzionalismo/Reticolarità, Privato pubblico/Comune, Polis/Cosmopolis, Labirinto/Passaggio. I diversi contributi spiegano come sia in corso una trasmigrazione di significati da un termine all’altro: così come accade ai perimetri dei confini nazionali, questi concetti non svaniscono ma sono immessi in uno spazio globale che, anziché cancellarli, li riqualifica cognitivamente. Lo stato-nazione, per esempio – atteso fra le vittime della globalizzazione – non scompare ma assume una nuova funzione nel ruolo di guardiano di un ordine mondiale sempre in divenire (Benedetto Vecchi, Terra mobile, geografia sociale con confini esasperati e differenze esaltate, Il Manifesto, 19 aprile 2014).
Con Paolo Giaccaria, autore in Terra Mobile del capitolo Confine/Soglia, docente di Geografia politica ed economica a Torino e studioso di Bio-geo-politica e Sviluppo economico locale, abbiamo discusso del significato attuale dei confini bio-geo-fisico-politici che le specializzazioni moderne hanno generato. mentre appare chiaro che nei labirinti del terzo millennio l’infinito s’intende meglio secondo l’etimologia greca, apeiron, che è semplicemente l’assenza di confine, piuttosto che un estendersi del mondo a dismisura.
Enzo: Dalla lettura di Terra mobile, del tuo contributo in particolare si comprende che i confini geopolitici non scompaiono mai. Anzi, quando non funzionano più come barriere fisiche, possono ancora svolgere una funzione regolativa essenziale per i flussi di capitali, persone, merci. Un tempo, la cartografia tentava di fossilizzare l’immagine del mondo entro modelli che piegavano i contorni geografici in chiave ideologica. La mappa di Isidoro, per esempio, schematizzava il mondo antico come una T, formata dal Mediterraneo e dai grandi fiumi – il Nilo, il Volta –, inscritta in un cerchio, con i continenti separati dalle acque e circondati dagli oceani. A una visione limitata dello spazio corrispondeva un’idea ristretta anche del tempo, con la storia tutta riassunta nel succedersi di poche generazioni. Possiamo dire che le rappresentazioni cartografiche sono uno specchio della coscienza storica e che ogni superamento di confini preesistenti corrisponde a un’evoluzione culturale?
Paolo: Partire da una carta amplia profondamente il ragionamento sul mondo. In questo io seguo rigorosamente l’ortodossia di Franco Farinelli, che è probabilmente il geografo italiano contemporaneo più autorevole. Farinelli ha scritto diversi libri su questi argomenti: Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo (Einaudi, Torino 2003); L’invenzione della Terra (Sellerio, Palermo 2007); La crisi della ragione cartografica (Einaudi, Torino 2009). Uno dei suoi cavalli di battaglia è la tensione fra Eratostene, il primo cartografo, e Strabone, geografo e viaggiatore alessandrino. Farinelli vede nel centro della geografia quest’ambiguità: il significato del termine grafia è sia disegno, sia scrittura. Come scrittura presuppone un autore, un viaggiatore, un osservatore, quindi una visione esplicitamente soggettiva, autoriale. Invece, come disegno del mondo ci rimanda a un equivoco sostanziale sull’oggettività del sapere geografico.
La tensione non è però di tipo temporale, tra un prima e un dopo. Tra un mondo semplice e cartografabile, come nelle carte medievali dove era tripartito, con Europa, Africa e Asia separate dalle acque, – quella tripartizione dei mari corrispondeva poi alla croce greca, era la tau che secondo la teologia cristiana incarnava letteralmente la croce del Cristo nel mondo – e un mondo complesso, che sfugge, si dilata e non è chiaro cosa ci sia dentro, cosa resti fuori dal confine. Non è questione di prima e dopo, ma di modelli spaziali che si usano a seconda che si voglia o no lasciarsi sedurre dalla tentazione di considerare il sapere geografico come oggettivo. Questa è, appunto, l’illusione della carta.
La dimensione cronologica ha un ruolo, ma usualmente è quello di far saltare il banco, non di mutare l’ontologia delle cose. La globalizzazione oggi rimette in discussione la cartografia perché con le vecchie rappresentazioni non gli si sta più dietro. Quelle rappresentazioni, però, avevano in nuce il peccato originale della cartografia, che consiste nel confondere oggettività e soggettività occultando l’autore. Da questo punto di vista la globalizzazione non cambia niente, fa solo una volta di più saltare il banco.
Enzo: Il tuo contributo, come altri del libro, confuta i paradigmi della globalizzazione secondo cui il superamento dei confini nazionali comporta un abbattimento del potere a essi correlato: fondamentalmente lo stato-nazione. Ma se i luoghi per l’esercizio del potere rimangono immutati, come cambiano i loro confini?
Paolo: Non esistono forse più i luoghi del potere come li abbiamo immaginati e conosciuti – che non è sempre la stessa cosa, – ma questo non significa che l’occupazione di uno spazio non sia più correlata con il potere, né che il controllo materiale dello spazio non abbia più un’attinenza stretta, strettissima, con il potere. Condivido le premesse di Carl Schmitt (Terra e mare, 1942) e la sua visione per cui un ordine spaziale è sempre politico e un ordinamento politico implica sempre un ordine spaziale. Dopo di che, cambiano gli strumenti con cui si realizza il rapporto fra spazio e potere. Si potrebbe discutere della fine della territorialità o meglio della sua trasformazione, che è quello che cerco di fare parlando dei confini.
L’associazione misura-territorio-confine come l’abbiamo conosciuta nella modernità è una delle possibili forme di correlazione fra ordinamento politico e ordine spaziale. Sostanzialmente, è l’associazione geo-politica dello stato post–westfaliano, una visione che ha preso corpo nel XVII secolo per porre fine in Europa alle guerre di religione.
Ora, per un verso osservo che indubbiamente questa territorialità si trasforma. Non significa però che sia in atto la scomparsa dello stato-nazione – che mi sembra continui a controllare lo spazio, anche troppo – ma che si trasformano gli strumenti di quella che Michel Foucault chiamava governabilità. In questa micro-fondazione su base geografica della governabilità sta l’essenza della connessione fra potere e spazio. Occorre non tanto immaginare delle strutture, dei Golem, come appunto il triangolo misura-territorio-confine che definisce la sovranità nazionale come immobile, quanto capire con Michel Foucault quali sono le micro-fondazioni socio-culturali di questo tipo di rapporto fra spazio e potere.
Per un altro verso, va osservato che, paradossalmente, proprio in un’epoca di globalizzazione nella geografia politica i cosiddetti border studies, – gli studi sui processi di costruzione dei confini, – sono rifioriti e c’è una riflessione raffinatissima, sia sullo storico sia sul contemporaneo, attorno al concetto di confine. L’altra idea che si accende proprio ora è quella del topological turn, cioè di una dismissione della spazialità cartografica basata sulla misura dello spazio cartesiano. Tutto questo non significa però che la globalizzazione abbia reciso il rapporto fra spazio e potere politico.
Enzo: È possibile definire spazi variabili, separando il controllo sulle persone dal controllo sulle cose, con una distinzione anche fra beni materiali e immateriali? Questi ultimi – penso alla finanza, all’informazione, al commercio delle tecnologie di accesso al mondo globale – appartengono ormai a non-luoghi che non hanno più nulla a che fare con il territorio in cui vengono elaborati, dove il tempo è quello di un presente continuo e velocissimo.
Paolo: Quel che dici sull’importanza del tempo è vero. Per me la definizione migliore della globalizzazione è quella che ne ha data il geografo e sociologo David Harvey (La crisi della modernità, Il Saggiatore, Milano 1993), ormai più di vent’anni fa, dicendo che è una compressione spazio temporale. Esplicitamente, Harvey non faceva che riprendere un’affermazione che era già di Karl Marx, cioè che il capitalismo opera una compressione dello spazio anche attraverso il tempo. Questo è indubbiamente vero, con l’aggiunta che uomini, beni e informazioni sono strettamente interconnessi fra di loro e il tempo regola le interconnessioni.
Tuttavia, uno degli elementi assolutamente chiari nei border studies è la geometria variabile dei confini, che sono permeabili e impermeabili allo stesso tempo. La frontera fra Messico e Stati Uniti è un caso tipico di confine in cui è assolutamente evidente la compenetrazione di permeabilità e impermeabilità: c’è una barriera che si presume impenetrabile per le persone e i beni irregolari, poi a New York – dove mi trovo adesso – negli uffici pubblici, nelle stazioni, tutta la segnaletica è bilingue, in inglese e spagnolo. È un’illusione quella della tenuta del confine, sia sulle merci sia sulle persone. La frontera, come molti altri confini, è in realtà una chiusura selettiva.
Faccio un esempio: una cosa su cui abbiamo ragionato recentemente è la dimensione bio-politica del commercio di animali. Sulla trasmissibilità delle malattie fra uomo e animale cadono addirittura i confini fra le specie. Tutto un filone molto interessante del dibattito ormai parla di post-umano. C’è chi dice che fra cinquant’anni metà della popolazione mondiale sarà post-umana. Chi ha anche solo una valvola cardiaca, in effetti, è post-umano. L’orizzonte è di poter fare trapianti di organi fra specie diverse, integrando in maniera crescente componenti non umane negli esseri umani. Chiaramente, anche nei corpi i confini si modificano, ma non si abbattono mai. L’abbiamo imparato e studiato con le pestilenze trans-specie degli ultimi decenni e con questo ritorno improvviso, violento, delle barriere doganali che di nuovo però poi è giocato in chiave bio-politica, cercando di muovere il mercato verso un’ulteriore liberalizzazione. Tutta la questione dell’aviaria fu costruita ad hoc, oltre che per vendere i vaccini, sull’idea della promiscuità fra uomini e animali – tipica del mondo orientale, dove bambini, pulcini, maiali e galline vivono nella stessa abitazione – come elemento di pericolo. Questa idea è stata usata localmente e su scala internazionale per colpire l’allevamento familiare a favore di quello industriale, quando era proprio quest’ultimo a creare le condizioni per la diffusione dell’aviaria. Si tratta di confini che sono sempre rinegoziati, ma nel caso dell’aviaria l’immaginario bio-politico evocato era esattamente quello coloniale fondato sulla promiscuità, sulla mancanza d’igiene delle popolazioni colonizzate.
Non si tratta di negare questi elementi, ma di ricordarsi che non sono mai divisibili in mobile versus immobile, permeabile versus impermeabile. C’è sempre un gioco di confini morbidi e confini duri. Basta pensare alle mappe dell’immigrazione europea: c’è uno spazio ben definito, Schengen, che sembra avere un confine duro e chiaro. Infatti, è ben chiaro dove comincia e dove finisce lo spazio Schengen. Però, nel momento in cui lo si è messo in pratica attraverso una politica di contenimento dei flussi migratori, questo spazio è diventato estremamente ambiguo e mutevole, con confini che si spostano seguendo il decentramento del pattugliamento anti clandestini e con il coinvolgimento dei governi dei paesi terzi – molti dei quali non rispettano i minimi diritti umani. C’è tutta una serie di spazialità molto più complesse della vecchia concezione geografica che stabiliva dove fosse il confine con il doganiere, la guardia di frontiera e quali fossero le condizioni per il passaggio. Il punto è non la scomparsa del confine ma la sua maggiore complessità.
Enzo: Arriviamo alla definizione di soglia come interfaccia tra mondi diversi, che si dilata al crescere della complessità mentre i processi di sviluppo economico e sociale ridisegnano le identità personali e la geografia politica mondiale. Cosa resta, allora, dentro i confini geopolitici convenzionali? Cosa potremmo trovarci ancora se davvero il concetto di soglia può estendersi a spazi grandi come l’Europa?
Paolo: Questa è una bella domanda. Immagino che troveremmo un vuoto, lo spazio vuoto dove si definisce la sovranità, quello che tradizionalmente tutti i rivoluzionari di ogni specie vogliono occupare: i marxisti leninisti come i nazisti ambiscono a occupare lo spazio della decisione, quello che si crea nel cambiamento, nella soglia. Walter Benjamin in questo è assolutamente geniale, perché dà una risposta messianica affermando che quello spazio va tenuto vuoto, va conservato vuoto perché quando il messia arriverà potrebbe averne bisogno – qui c’è un’idea di messianesimo come preparazione e attesa. Questa è una visione assolutamente laica, anche se Benjamin è totalmente localizzabile nella cultura ebraica tedesca del ‘900.
Quest’idea del tenere lo spazio della soglia vuoto per chi ne ha bisogno, per Jacques Derrida diviene il fondamento dell’ospitalità: rimanere aperti alla diversità. Alla fine penso sia questo il discorso più utile per ripensare i confini del mondo. La soglia per me è prima di tutto un rifiuto della misura, una rinuncia a definire, un rifiuto di attribuire identità certe. In questo momento il problema è che questo deve anche essere il rifiuto di attribuirsi e attribuire identità confuse. C’è tutta una riflessione sul postmoderno come supermercato dell’identità, per cui uno si serve dai diversi scaffali da cui prende e paga – perché si paga sempre e comunque, qualunque scelta si faccia – i pezzi d’identità in cui si riconosce. È un’idea molto legata al pensiero debole, quella delle appartenenze multiple.
In questo senso, mi torna in mente una citazione a proposito di Derrida e del suo essere un ebreo del Nord Africa, di fatto un marrano: uno degli ebrei di Spagna e Portogallo che dovettero convertirsi al cristianesimo. Per Derrida il marranesimo non era rappresentato da queste banalità sulla doppia o multipla appartenenza – essere sia, sia – ma sulla molteplice esclusione: né cristiano, né gentile, né ebreo, né mediterraneo, né francese. È lo stesso concetto di un altro pensatore, Edgar Morin espressa nel suo bellissimo libro sul marranesimo (Il mondo moderno e la questione ebraica, Cortina, Milano 2007), in cui sostanzialmente prevale l’idea di non definirsi, non perché si può essere quello che si preferisce, ma perché non si può essere nulla di compiuto.
Questa è la sorpresa che vorrei trovare nella definizione di soglia: un rifiuto a definirsi, più che un definirsi in senso molteplice che è purtroppo l’opposto di quello a cui stiamo andando incontro. Basta vedere cosa succede alle elezioni europee, soprattutto in Ungheria, dove metà della popolazione sostiene movimenti politici che, secondo i casi, possiamo definire fascisti o direttamente nazisti. La crescita delle destre di vario tipo e natura si può leggere come una ricerca consolatoria di quanto sosteneva Schmitt: un tentativo di tornare a far coincidere l’ordine spaziale e l’ordinamento politico.




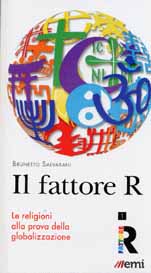























Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!