La pedagogia del coraggio – Recensione di Cinzia Picchioni
Cristiana Voglino, Giovanna Corni, Maria Varano, La pedagogia del coraggio, Claudiana, Torino 2012, pp. 208, € 14,90
Partendo dalla famosa frase de I promessi sposi, di Alessandro Manzoni: «[…] uno il coraggio non se lo può dare», ma per confutarla (il titolo del libro ci dice che invece si può imparare), le tre autrici riflettono sulla morte e sulla malattia (di figli, di pazienti, di cari amici…), ciascuna di loro (professioniste nel mondo educativo e madri) portando nel libro la sua esperienza diretta (anche). Con uno stratagemma grafico (un «segno» che identifica le parole dell’una o dell’altra*) testimoniano, anche con deliziosa ironia sdrammatizzante, la loro vita, i loro pensieri, le loro azioni e re-azioni nei momenti bui del prendersi cura, del «”supportare” e “sopportare” la sofferenza […]» (nella quarta di copertina). «Questo libro non è un saggio sulla resilienza. Abbiamo incontrato riflessioni di autori più competenti di noi (vedi Bibliografia): è il tentativo di dare gambe alla promozione della salute nei nostri normali percorsi di vita. Tradurre le parole teoriche, quelle che abbiamo convalidato nell’esperienza, in proposte di formazione per genitori, educatori, insegnanti e caregiver impegnati nelle relazioni d’aiuto» (p. 14). Ecco appunto «caregiver»… che vorrà mai dire?
*«Per Cristiana abbiamo scelto le maschere del teatro, per Giovanna il libro e per Maria il fiore».
Caregiver?
La parola deriva dal verbo inglese «to care» (prendersi cura, avere a cuore). Il verbo «to care» è diventato «famoso» anche in Italia (tanto che ora, appunto, si usa «caregiver» per definire «colui che dà aiuto») grazie a don Lorenzo Milani. Sul portone del suo famoso doposcuola, a Barbiana, c’era proprio la scritta «I CARE» «cioè “mi importa” al posto del “me ne frego” fascista» (p. 155, chi volesse maggiori informazioni sulla figura di don Lorenzo Milani visiti www.barbiana.it).
Epilogo
Ma come, l’Epilogo dopo poche righe dall’inizio della recensione? Sì, perché a p. 197, c’è una specie di «riassunto», chi voglia risparmiare tempo per sapere che tipo di libro sia La pedagogia del coraggio può leggere direttamente quello: «[…]Sparsi nel libro si trovano appunti teorici, pezzi di programmazione, proposte di esercizio tratte dai nostri materiali di lavoro nei contesti formativi. […] Il filo rosso che ha legato i capitoli ha attraversato […] il racconto di un so-stare vicino alla “Grande Paura” nel ruolo di figlio, genitore, moglie, amico, caregiver professionale».
Vi prego di notare ancora un volta il riferimento alla figura del «caregiver» e la scelta di scrivere «so-stare vicino alla Grande Paura», nel senso di «sostare» (stare fermi), ma anche, grazie alla scelta grafica del trattino, «so stare», cioè sono capace, ci so stare, vicino alla morte…
ArTerapia
Siccome una delle autrici fa anche l’attrice, nel libro sono indicati alcuni esercizi pratici (9 laboratori) che pescano nelle tecniche del Teatro dell’Oppresso, o di Jacques Lecoq, ma c’è anche un capitolo intero sulla risata (Patch Adams e compagni), uno sul gioco, sulla scrittura che consola, sull’arte che cura, sulla fiaba che conforta (p. 134). Intorno a queste stesse pagine scopriamo che esiste la «Carta di EACH (European Association Children in Hospital», cioè una «carta dei diritti dei bambini ospedalizzati» (il testo completo è in fondo al libro); scopriamo anche che nella libreria di chi si occupa di educazione e formazione non dovrebbe mai mancare un libro intitolato «Homo ludens», di Johan Huizinga; e che possiamo fare riferimento a un sito dal nome significativo: www.aiutamianonaverepaura.it; e infine che proprio a Torino – da cui scrivo – esiste TIC, che non è una caramella, ma l’acronimo di Teatro In Corsia, gruppo di appassionati di teatro con esperienza di corsia che propone spettacolini nei reparti di lungodegenza dell’ospedale per bambini della città. Mezzi e stratagemmi anche artistici per allenare il coraggio a stare di fronte alla malattia e alla morte.
Resilienza
In proposito si potrebbe poi dire che il libro tratta della «resilienza»: «la parola deriva dal latino re-salio» (re-Salio? Nel senso del sovrano Nanni? Ih ih ih! Scusate non ho saputo trattenermi, ma questa è pur sempre il «sito» del Centro Studi Sereno Regis!). Torniamo seri e riprendiamo le virgolette: «che significa “rimbalzo, saltello, ballonzolo [ma anche] l’operazione militare di risalire su una barca capovolta per cercare di “ri-girarla”, tentativo difficile che ben si collega metaforicamente al tema della pedagogia del coraggio: cercare di ri-girare la nostra vita che s’è capovolta […] (p. 54, ma non perdetevi l’intero capitolo, con la «casita», la salutogenesi, il modello anglosassone di resilienza: «I have, I am, I can») e il laboratorio teatrale alla fine «Resilienza dei materiali… e degli umani». Piuttosto importante poi, per «rigirare la vita che s’è capovolta», è il capitolo sul «ritorno a casa». Come si fa quando, dopo un intervento o una lunga cura, si torna a casa? Come ri-organizzare la propria vita? Come prendersi cura del malato? Il capitolo ci fa capire, ancora una volta, che il libro è scritto da chi «ci è passato» e sa «di che cosa si tratta».
Per chi?
Per dei genitori che si trovino ad affrontare la malattia di un figlio, o di un compagno del figlio; per gli operatori (insegnanti, educatori, assistenti sociali…); per i professionisti dell’educazione; per il personale infermieristico, per i medici, per gli adulti che incappano in prima persona nella malattia… è il mio caso (per fortuna ho avuto io il cancro e non mio figlio!) e per questo consiglio vivamente la lettura di questo libro. Ben scritto perché non solo «teorico» (ma non autobiografico), sdrammatizzante (anche nei momenti drammatici), ironico (quanto basta; imperdibile il «racconto» – ma è vita vera! – della padella cancerogena. alle pp. 162-3).
Per ché?
«Una cosa è certa. Coloro che l’hanno scritto, di coraggio ne hanno avuto senz’altro.[…] qui non si parla di un coraggio qualsiasi: di saper affrontare (che so?) una paura, un esame o una prova difficile, le incognite dell’esistenza, la crisi economica, una delusione d’amore. Qui la “protagonista” […] è la più sgradita […] Perché la morte, con le sue legittime paure e con terrore al solo pensarla, che si affronta in queste pagine, ci sfida ogni giorno[…] Le autricici domandano spesso […] se sappiamo reagire alla morte come adulti […] Ci offrono qualche idea per come un simile evento lo si possa “spiegare” ai più piccoli […]» (dalla «Prefazione» di Duccio Denetrio, pp. 5-10).
«Educare e educarsi al coraggio è una chimera, se si tratta del coraggio di veder morire, di presentire la propria morte, di andarle incontro impavidi. […]»; il libro è ricco di «indicazioni pratiche circa le modalità adottabili con cautela per spiegare, raccontare, condividere insieme soffenrenze e vie per tornare a guardare alla vita “quasi” come se nulla fosse accaduto o mai dovesse accadere. Queste pagine ci offrono senz’altro dei suggerimenti per superare i momenti più spaesanti e bui, per decifrarne l’arcano, per sentirsi vicini a chi soffre trovando le parole del conforto» (dalla Prefazione di Duccio Demetrio, p. 9).
Per crisi…
Nel libro ogni tanto ci sono dei disegnini, e uno (a p. 29) ha attirato in particolare la mia attenzione. Si tratta dell’ideogramma in cinese antico per «crisi»: in realtà gli ideogrammi erano due, uno che significava «pericolo», «precario», «paura», ma un altro significava «occasione», «punto cruciale», «possibilità di svolta». Le autrici hanno inserito la riflessione sul duplice significato della «crisi» (siamo quasi stufi eh?) nel paragrafo «Riconoscerre la vulnerabilità» (p. 27), concludendo che «Il pericolo mette in mostra la nostra vulnerabilità, quella che siamo soliti celare. […] contagia […] anche il modo in cui gli altri percepiscono […] la loro vulnerabilità. Perché la grande paura è con-vissuta con gli altri intorno a noi. È un intreccio di paure. La morte, come ogni sacramento, memoria del sacro, è un’esperienza sociale» (p. 29).
Per «ridere»
O meglio, per riflettere sul «dare alle cose il loro nome», c’è un intero capitolo, il secondo, che si intitola «La grande ferita», e a p. 32 e riporta «divertenti» reazioni all’uso non «corretto» dei termini per definire certe situazioni, e soprattutto con i bambini. Giovanna, una delle tre autrici, racconta di quando ha «perso» la «fratellina» (termine coniato dall’altro suo figlio per indicare il nuovo, futuro, membro della famiglia) per un aborto spontaneo. Quando tornò a casa dall’ospedale spiegò mestamente ai famigliari – compreso il bimbo di sette anni: «Abbiamo perso il bambino». A quell’affermazione il bambino replicò, allarmato e preoccupato: «Dove?». Fa un po’ ridere vero? Nonostante il dramma questo ci fa capire che a volte sarebbe meglio chiamare le cose col loro nome. Cristiana Voglino, un’altra delle tre autrici, aveva già trattato il tema «Come dire le cose» e in particolare ai bambini, con un libro, Aiutami a non avere paura (sempre di Claudiana). E i consigli riguardano la necessità dei riti e del funerale, il bisogno di lasciar passare del tempo per «elaborare» il lutto, e riporta – tramite il libro di Massimo Gramellini, Fai bei sogni – il pericolo di informazioni ambigue (come il bambino che rispose «Ma papà era un bambino come me! Non può essere diventato una stella!», a sua mamma che aveva tentato così di spiegare la morte del padre). A proposito delle parole da dire è veramente «carina» la riflessione che ci offre Cristiana Voglino**, dopo la morte di suo marito (per cancro): «Se vogliono sapere come sta mio merito? Sarebbe solo giusto rispondere: “È morto”. Beh, non credo che tutti sopporterebbero la verità: nessuno usa più una frase così. llora, forse, potrei dire: “Mio marito mi ha lasciata”. Eh già, così pensano che sia scappato con un’altra. […] E se provassi con: “Ho perso mio marito”? Ma che razza di frase è? Va bene per chi non trova più il suo gatto[…] “Mio marito non c’è più”? E dov’è andato?. Meglio la verità. Mi dispiace per voi […] ho imparato a usare la frase “ha il cancro” al posto di dire “lo ha colpito un brutto male”. Se usi questa seconda frase in Piemonte, alcune persone usano ancora domandare: “E cos’ha visto?”. Perché il cancro ti viene se guardi qualcosa di brutto? La parola giusta al posto giusto è la soluzione migliiore» (p. 35)
**Cristiana (p. 29): «ho perso mia madre per tumore quando avevo 17 anni; poi rischio di perdere mia figlia che ne ha sette e dopo tre anni tocca a mio marito».
Per chiudere
Se non si fosse capito, il libro mi è piaciuto, e molto. Vorrei davvero consigliarlo a chi si trovi, direttamente (come me) o tramite e con altri, ad affrontare una «Grande Paura». Per affrontare una grande paura ci vuole un grande coraggio, e qui dentro se ne trova un po’.
Altri libri e gli scout
Mi ha fatto piacere trovare, citato in Bibliografia (pp. 205-6) il bellissimo e poetico Così è la vita di Concita De Gregorio (Einaudi), che consiglio – giacché siamo in una recensione… – vivamente a tutti/e di leggere. Mi ha ri-fatto piacere trovare, citata a p. 29, la famosa di Baden-Powell (il fondatore dello scoutismo), e mi sono ricordata di averla sentita dire da mio figlio, quando frequentava gli scout e non si preoccupava – e tuttora è così – del tempo atmosferico: «Non esiste il cattivo tempo, esiste il cattivo equipaggiamento». Una delle autrici, anche lei, a suo tempo, girl-scout, usa la frase di Baden-Powell per chiedersi, nelle pagine del lilbro, quale sia l’equipaggiamento per «affrontare le tempeste della vita? Che cosa rende adeguati i nostri “bagagli” di “coraggio” e “forza d’animo”? Che osa rende alcune persone più capaci di altre a “reggere”, a “non soccombere” di fronte alla grande paura della morte e della malattia invalidante? […]». Poco più avanti (p. 30) c’è una «risposta» parziale: «Rendere dicibile la nostra vulnerabilità, facilitare e accogliere le ferite dei bambini, impedire la stagnazione sono i primi passi della pedagogia del coraggio».







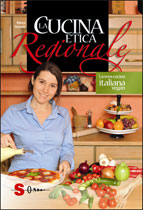





















Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!