Dialogo interiore. Perché non posso farti del male?
1- Perché non posso fare qualcosa che per te è un dispiacere, un danno, un male?
2- Ma è perché mi sei amico, mi vuoi bene.
1- D’accordo, ovvio. Ma se tu fossi per me uno sconosciuto, un estraneo, perché non potrei fare un’azione che per me è un vantaggio e per te è un male? Lasciamo da parte i casi estremi, di necessità, di impossibilità: siamo due naufraghi, c’è una sola tavola, l’afferro io prima di te, io mi salvo, tu no. Siamo in un locale incendiato: io arrivo all’uscita prima di te, perché cammino meglio, non torno indietro ad aiutarti, mi salvo io e tu no. In questi casi non voglio farti del male, soltanto non sono abbastanza coraggioso, eroico, salvando me non voglio la tua rovina. Ma la domanda è un’altra: se posso fare una cosa per me utile, vantaggiosa, piacevole, o anche banale, indifferente, ma per te dannosa e dolorosa, perché non posso farla? Niente mi lega a te se non la comune vita umana, un legame molto molto largo, a volte insensibile. Perché non posso farla?
2- Ma perché ci sono delle leggi, c’è un’etica civile.
1- Certo, ma supponiamo che io riesca a non essere scoperto e punito, supponiamo che io dica alla mia coscienza: “è un bene per me, io posso, e basta”.
2- Se sei religioso, credente, sai che Dio ti vede, e prima o poi ti chiede conto del male che fai.
1- Va bene, siamo intesi, ma supponiamo che io non creda in alcun essere più grande e giusto di noi. Non c’è un giudice, né umano né divino, delle mie azioni. Le decido solo io. Ora, in quello che faccio c’è un bene mio con l’effetto diretto di un male tuo. E non un effetto involontario: il mio bene è frutto del tuo male. Noi due pensiamo entrambi che non posso farlo. Ma perché? Per quale ragione?
2- Perché, a parte le leggi, la religione, la morale, abbiamo fatto un patto, almeno implicito, di convivenza umana, di non danneggiarci a vicenda, almeno nelle cose più importanti e gravi.
1- Infatti, c’è questo patto implicito, anche con lo sconosciuto, lo straniero, l’estraneo. «Pacta sunt servanda»: bisogna rispettare i patti. Bene. Ma se io ritengo che, per un mio vantaggio, posso violare i patti, anche se ciò porta direttamente a te un danno considerevole, e io non rischio nessuna sanzione, perché non posso farlo? Guarda, non parliamo di bazzecole, p. es. attraversare col rosso quando non arriva assolutamente nessuno: violo una regola, ma non faccio male a nessuno. Parlo invece di cose grosse, gravi. Perché non posso? Perché?
2- Forse perché il male che fai a me è anche, in qualche modo seppure invisibile un male che viene anche a te, su di te.
1- Sì, questo è il principio che il pensiero morale, praticamente in tutte le civiltà umane, ha formulato nella “regola d’oro”, o anche ha espresso nel detto che “siamo nati gli uni per gli altri”, “siamo membra gli uni degli altri”. Ma se io decido di superare questa regola per una mia utilità, e ti faccio un male, perché non posso? Perché, se io posso farlo fisicamente, non accettiamo che possa farlo anche moralmente? Perché non accettiamo che quel principio di reciprocità sia superabile dalla mia volontà? Perché non accettiamo che quel che posso fisicamente, e mi serve, io lo faccio e basta? Accettiamo forse che non c’è un problema morale? Perché invece sentiamo o diciamo che c’è un limite alla mia volontà? Ma c’è davvero questo limite?
2- Lo mettiamo noi, questo limite, anche se non sempre lo rispettiamo, per poter vivere un po’ meglio, con più tranquillità, minor pericolo e paura, in pace con gli altri umani, e chiamiamo umanità questo limite e direzione delle nostre azioni.
1- Va bene, ma così non usciamo dal problema. Se io voglio rischiare sfidando questo equilibrio, se voglio prendere una utilità per me anche togliendo ad altri, a te, e se ci riesco, posso o non posso? Il problema è questo: posso di fatto, perché sono forte e impunibile; ma posso anche moralmente? Che cosa è la morale? È una regola pratica, di prudenza, come il semaforo, che posso superare quando non fa male a nessuno? Oppure è una regola che mi ferma, mi chiede di fermarmi, quando faccio male a qualcuno? Ma ha un fondamento questa regola? Ha una ragione? Ha un valore? Ha una permanenza? Oppure si può spegnere o ignorare come il semaforo? Perché non posso farti del male, quando potrei? La regola di rispettarti, se non me la impongo da me stesso, per mia sola volontà, non esiste?
2- Non lo so. Cerchiamolo insieme.
1- Dunque, non può essere Dio perché non siamo tutti convinti che esista, che ci veda e ci giudichi, ci guidi. Può esserlo per i credenti, ma non può essere la regola comune: io posso dire che per me non esiste. Non può essere la legge posta dall’autorità nella società, perché posso eluderla. Né Dio né la legge mi fermano, se sono forte, se posso. Non può essere la regola della reciprocità, dell’uguaglianza di valore, perché se io non do all’altro il valore che do a me, posso fare di lui ciò che mi pare, ciò che mi serve. Può essere forse solo il bisogno che io ho degli altri, prima o poi, dunque la convenienza a non offenderli affinché non mi offendano.
2- Questa è già una regola pratica. Ma vale solo relativamente. Se io sono davvero forte e impunibile, e posso anche imporre agli altri ciò che voglio che facciano per me, io non devo nulla a loro.
1- Però questa è una situazione astratta, perché anche il tiranno dorme, e ha bisogno della protezione di guardie fedeli, obbedienti e servili, per essere davvero forte. La sua forza non è tutta sua, ha bisogno degli altri. Anche il violento è vulnerabile. Vedi nella storia la fine di tanti tiranni. Ma vedi anche quanti di loro hanno regnato e sono morti ricchi e sicuri nel loro letto. Eppure, parlando in generale, vediamo che l’unica regola pratica che resiste alle obiezioni è questo bisogno che ognuno ha degli altri. Una regola molto debole, però, perché lascia molto spazio al prepotente violento. Avendo come regola principe la propria volontà, e non la convenienza comune, il violento può fare all’altro il male che gli fa comodo. La regola della violenza, nonostante le sue falle che abbiamo visto, permette di fare il male, lascia tutti gli altri esposti al male. La regola della reciproca convenienza non regge davanti al violento fornito di forza.
2- Ci vuole un principio superiore alla forza usata come violenza.
1- E quale principio, se non basta Dio, non basta la legge, quasi non basta neppure la convenienza? Chiediamoci che cosa è un principio.
2- Direi che è qualcosa che ci precede: un inizio, e noi sappiamo di non essere l’inizio, ma iniziati, derivati, nati da altri, fisicamente e culturalmente. Un principio è qualcosa che non è derivato da una dimostrazione, da un ragionamento, e semmai imposta un ragionamento. Un principio è qualcosa che non pongo io, perché allora sarebbe un prodotto nostro: nel caso, sarebbe quella convenzione, alleanza, che abbiamo visto non garantisce appieno dalla forza prepotente.
1- E cosa può essere quel principio? Dio non basta, perché non è principio riconosciuto da tutti. Non basta la legge, perché si può eluderla. Neppure la convenienza, che è semmai un derivato, non un principio: siamo qui, vogliamo vivere, mettiamoci d’accordo su quel che ci conviene, riconosciamolo insieme, dunque non facciamoci del male. Ma poi, nel caso, la mia convenienza può essere nel danno tuo. La convenienza è ballerina. Sì, ci vuole un “principio”, un dato precedente alle nostre volontà, buone o cattive, egoiste o altruiste, moderate dalla convenienza o scatenate dall’interesse.
2- E cosa c’è di precedente? Andiamo nella metafisica? Siamo creati, nel senso che siamo fatti in quel modo, da cui non si esce, che un dio ha voluto e stabilito per noi?
1- Nel recensire il mio libretto Il bene della pace (apparso in una collana di etica della editrice Cittadella) Massimiliano Fortuna, amico severo, scrive che io riterrei la verità (qui si tratta della verità morale) una “scoperta”, quindi data nella realtà esterna all’essere umano, e non una “costruzione”, dunque fondata su delle convenzioni, interna al linguaggio e alle culture degli uomini, come ritengono vari filosofi oggi. In quel libretto io sarei convinto dell’esistenza di «valori inscritti, per così dire, nella natura, che rappresentano dei binari imboccando i quali l’umanità si muove in direzione di un progressivo aumento del bene della pace nella storia». Così sottovaluterei «la storicità delle culture umane«» e adopererei «in termini assoluti, e dunque astorici, un concetto come “coscienza”». Abbiamo ripreso in altri momenti una riflessione non così rigida sulla “natura umana”, anche a proposito del linguaggio e del significato della Pacem in terris.
2- Dobbiamo proprio opporre così tanto natura stabile e convenzione storica?
1- Merita pensarci un po’ di più. La pura convenzione, se non sbaglio, non difende dal male che possiamo farci. Infatti, leggi, diritto umanitario, accordi internazionali, non evitano del tutto delinquenza, corruzione, violenza, guerre, perciò dolori tanti e vari. Rafforziamo la cultura della parità di valore, il valore delle convenzioni, e certamente sarà un bene per la buona convivenza. Ma l’obiezione, anche filosofica, non è superata: perché, potendo, non posso violare l’accordo? Se non devo rispondere ad altri, ma solo a me stesso, perché non potrei? Hans Küng, citato in quel libretto, scrive: «Perché un delinquente (nel caso che non corra alcun rischio) non deve uccidere i suoi ostaggi? Perché un dittatore non deve fare violenza a un popolo? Perché un gruppo economico non deve sfruttare il proprio paese?». È la stessa nostra domanda. Küng risponde: «L’incondizionatezza del dovere non può essere giustificata dall’uomo, in molti modi condizionato, ma soltanto da qualcosa di incondizionato».
2- Allora, dobbiamo ricorrere ad un concetto di natura umana fissa, non evolutiva? Alla volontà di Dio? Ad un principio categorico della ragione? Solo un’idea metafisico-religiosa della nostra umanità ci può salvare dalla nostra disumanità?
1- Mi viene in mente un paragone: la nostra Costituzione (come altre) ha dei principi fondamentali sottratti, secondo gli studiosi, alla revisione prevista per gli altri articoli. Nonostante le pressioni politiche, che vediamo anche oggi, quegli articoli non possono essere stravolti. Si tratta di una trascendenza metafisica della Repubblica? No, direi. Si tratta di una consistente trascendenza storica: fin quando la Repubblica è questa Repubblica, quei fondamenti non si toccano. Non sono più soggetti alla regola di maggioranze e minoranze, ad alternanze di governo, perché sono l’impostazione su cui poggiano le regole del gioco: sono le regole per fare le regole, che non si cambiano con le regole.
2- E la natura umana, va pensata così?
1- Non so. Vedo però che, per esempio, nel linguaggio di Giovanni XXIII nella Pacem in terris, il riferimento alla natura umana, ben più che un’affermazione teorica anti-evoluzionismo, è un appello a ciò che accomuna gli esseri umani. Così si può interpretare, al di là del linguaggio: vuol dire l’unità umana necessaria alla pace. Ha una funzione analoga al convenzionalismo, ma più forte, più impegnativa, più rassicurante contro violenze e guerre: siamo tutti esseri umani, tutti uguali per dignità naturale. Questo concetto di dignità è molto ricco: non è un puro dato di fatto, non è una convenzione, ma una dinamica, un movimento; è un obiettivo che ha una vera base di realtà eppure va continuamente cercato e raggiunto. Essere degni implica sia un fatto reale, sia un diritto da realizzare. È un concetto e un linguaggio dinamico, evolutivo. La dignità si ha già, e non si ha ancora nei fatti se non viene onorata. Eppure, se viene offesa, non è distrutta, permane al di là dell’offesa. Tu sei degno del mio rispetto, ma se ti offendo, sei degno come prima. La dignità è una inviolabilità morale, anche nell’ucciso. La violenza è inutile contro la dignità.
2- Vedo che, nella sua recensione, Massimiliano Fortuna cita (per tenere aperto il dibattito) Telmo Pievani per il quale la specie umana è un frammento di natura che all’interno dell’evoluzione ha elaborato, o meglio sta provando a elaborare, un esperimento di fratellanza democratica e di giustizia sociale, del quale non trova una matrice preformata in una “natura” originaria che lo precede. Secondo Pievani «autentico è l’uomo che in questa condizione di consapevolezza [la radicale contingenza della nostra presenza] vive per la giustizia, per l’uguaglianza nei diritti, per il bene e la solidarietà, e proprio nel fare unilateralmente questa scelta rinuncia all’idea che l’essere naturale presupponga in quanto tale l’etica».
1- È bene che il ventaglio del dibattito sia aperto, e muova l’aria a tutti i venti, sicché ognuno possa trovare quello che lo fa meglio respirare. E possa anche proporlo agli altri, se convince, se (più mitemente) persuade. Proporre, in libertà di pensiero, non è predicare dall’alto, anche se Massimiliano Fortuna ritiene di trovare nel libretto recensito un tono «parenetico e omiletico, vale a dire di esortazione alla rettitudine e di ammonimento morale». Ora, se in un pensiero come quello di Pievani «l’essere umano naturale non presuppone l’etica», cioè se l’uomo vivente non riconosce un principio di dovere e non-dovere, a lui precedente, da seguire, realizzare, e anche affinare, correggere, sviluppare (l’etica di Aristotele è stata corretta senza rinnegarne il nocciolo), e se l’etica invece è tutta costruita successivamente e mutevolmente, allora (è questo il mio timore, vedete se è giusto) un principio così debole del nostro cammino morale avvicina la fine del cammino morale stesso. Senza un principio non derivato, un postulato all’origine delle conseguenze, non ci sarebbe alcuna morale, alcuna regola comune di comportamento. Ci sarebbero dei comportamenti soggettivi, con regole soggettive, non valutabili. Se quel mio comportamento ti fa male, non hai una ragione comune a noi due per denunciarlo. Si può chiedere: perché, per Pievani, sarebbe «autentico» l’uomo che, nel corso dell’esperimento morale, «vive per la giustizia, l’uguaglianza, il bene, la solidarietà?». Sono più che d’accordo con lui (col quale feci anni fa un sereno dibattito nel Palazzo Ducale di Genova), ma devo chiedere: e non sarebbe «autentico» uomo anche quello che fa scelte del tutto opposte, se non c’è un criterio previo per dire autentica una scelta? «Autentico» è l’uomo che realizza più veramente, nel modo migliore, un modo di essere con gli altri? Ma se non c’è un modo più vero, misurato su un metro non improvvisato a posteriori, allora non è «autentico» anche l’ingiusto, chi disconosce l’uguaglianza e la solidarietà? Mi torna martellante la domanda: perché non posso farti del male? Perché non posso essere ingiusto con te, durante questo esperimento morale tutto aperto? Oppure hai già dei criteri di «autenticità» (almeno alcuni, essenziali)?
2- Gandhi diceva che non può essere nonviolento chi non crede in Dio. Quindi si poneva in quella morale tutta oggettivistica, esterna, non costruita storicamente dall’uomo, negata da certo pensiero morale contemporaneo?
1- Traduciamo questo pensiero di Gandhi. Per lui “Dio” significava l’unità profonda di tutti gli esseri. Diceva che non si può essere nonviolenti se non si coglie e non si rispetta la sacralità inviolabile di tutto ciò che è, almeno di tutto ciò che vive. Poi sappiamo che Gandhi non era un assolutista: riconosceva il caso sciagurato in cui per evitare un male peggiore può essere doveroso, fino ad uccidere, fare un male più limitato. Muller corregge Gandhi: non si tratta di un dovere ma di una tragica necessità: «la necessità di uccidere non sopprime affatto il comandamento di non uccidere».
2- Allora, l’unità tra noi, impegnativa e obbligante, vera difesa e vera sicurezza, è riconosciuta come un “principio” che precede e regola le nostre azioni, oppure è “costruita” nel nostro progressivo civilizzarci, nel farci “cittadini” gli uni degli altri? Un altro autore citato da M. Fortuna è Rorty, secondo il quale «l’obiettivo primario della solidarietà fra uomini – il non infliggersi vicendevolmente dolore – non può sperare di fondarsi su un “dover essere” intrinseco a una supposta essenza umana, ma semmai su un consenso intersoggettivo che si crea nel “gioco” delle circostanze storiche».
1- Intanto, possiamo osservare che farci concittadini pacifici è già un bel passo, è il passo degli stati democratici (in quanto sono anche eticamente universalisti, e non negano al di fuori dei confini i diritti umani che affermano all’interno), eppure è qualcosa di meno del riconoscerci “membra gli uni degli altri” in tutta intera la famiglia umana (come insiste l’antica sapienza richiamata dalla Pacem in terris). La democrazia nonviolenta non si limita al “decidere contando le teste invece di tagliarle”: è molto di più! Ora, se la regola del non offenderci è tutta e solamente “costruita” dobbiamo temere che possa essere allo stesso modo “decostruita”, smontata, distrutta! Una democrazia, relativamente buona, come la Repubblica di Weimar si suicidò con l’uso forzato degli stessi mezzi democratici, e distrusse il patto di cittadinanza “costruendo” l’ideologia delle due specie: i super-ruomini e i sotto-uomini, la razza con diritto e la razza senza diritto. Contro questa ideologia della “costruzione etica limitata e selettiva” reagì, dopo il 1945, la stagione storica dei “diritti umani”, non costruiti, ma riconosciuti e affermati come spettanti a tutti per nascita, cioè per natura: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti» (Dichiarazione Universale dei diritti umani, 1948).
2- Allora, una buona volta, perché non possiamo farci del male?
1- Perché, direi, entriamo nell’esistenza con una finalità identificata con l’esistenza stessa, non ad essa sovrapposta: esistiamo col fine di favorire in tutti i suoi valori e sviluppi ciascuno l’esistenza dell’altro, degli altri. Siamo «autentici» tanto quanto cerchiamo e perseguiamo questo scopo. Così direi io.
2- Albert Schweitzer sintetizzava l’etica nel “rispetto per la vita” (venerazione, nell’originale tedesco).
1- Mi pare poco intelligente l’obiezione di Christoph Türcke, che sono vita anche quei batteri patogeni all’annientamento dei quali Schweitzer ha dedicato gran parte della sua esistenza. La difesa di una vita umana a più ricche dimensioni può dovere, per necessità, eliminare altre vite: è il problema (comunque non tranquillo) già visto in Gandhi.
2- Perché dici poco intelligente?
1- L’intelligenza grande è sapienza: è assai più che analisi, argomentazione, dimostrazione. Questo è lavoro minuto e prezioso dell’intelletto (che rischia di “trapanare” la realtà, ridurla a concetto univoco, più che abbracciarla e lasciarsi abbracciare, dice Panikkar) , ma l’intelligenza legge intimamente la realtà plurale quando si fa sapienza, quando raccoglie tesori essenziali, riconducibili ad un nucleo di luce, da tutto il pensiero, da tutta l’intuizione umana, e da tutte le attese e le domande umane. Ho visto da ultimo un maestro di questa “sapienza alunna di sapienze”, in Pier Cesare Bori, dopo gli altri più noti sapienti della storia umana.
2- Perché, dunque, chiediamocelo sempre di nuovo, perché non posso fare il male, e neppure restituire male per male?
1- Arriverei a questa che mi pare una traccia verso una possibile risposta: perché siamo costituiti dal Bene per il Bene. Lo scrivo maiuscolo perché è il barlume di ciò che non sappiamo dire, ma possiamo cogliere come qualità, tensione, compimento essenziale e profetico dell’esistenza. Noi, più che pensarlo, respiriamo il Bene, senza il quale soffocheremmo rapidamente. E lo respiriamo anche solo come ricerca e desiderio costitutivo, nonostante tutte le cadute, le contraddizioni, le smentite, le falsità, i tradimenti, le malvagità che ci sono nel mondo e di cui tutti portiamo qualche responsabilità.
2- Appunto: il male. Il male non inficia questa prospettiva dell’essere nati dal Bene per il Bene?
1- Il male è la grande domanda, legata a quella postaci qui, su cui ci stiamo arrabattando. Supponendo che io abbia un po’ capito perché non posso farti del male, rimane il male oggettivo: quello (come insisteva Bobbio) patito da Giobbe il giusto, non quello compiuto da Caino fratricida per invidia; quello della natura, non quello fatto da noi. Tutta la fatica umana, di mente e di vita, non riuscirà a rispondere alla domanda sul male. Forse una giusta strategia, nel vivere e nel pensare, è non farsi risucchiare nelle sue spire, sia pratiche sia teoriche. Non opporsi al male col male, non entrare nel suo gioco: in questo senso il «non resistere al malvagio (o al male)» era per Tolstoj il cuore del vangelo. Non bloccare il pensiero su questa domanda, ma aggirarla come un nemico da vincere con l’astuzia: capire il male senza capirlo; scavalcarlo col patirlo senza accettarlo; non subirlo ma non combatterlo a modo suo; resistergli con un altro linguaggio di lotta che lui non sa capire. Questa è, appunto, la lotta e la forza della nonviolenza, come pensiero e come azione. E intanto, nella vita vissuta, mettere bene dove c’è male. Seppellire il male nella misericordia e nel perdono, anche politico. Non solo non posso farti del male, ma devo, quanto mi è possibile, darti bene senza attendere restituzione. Più che capirlo, il male è da vincere col bene. Il bene è favorire e sostenere la tua libera vita, la libera vita di tutti. Qui comincio a intravvedere perché non posso farti del male, anche quando mi sarebbe possibile e utile: la ragione è che sono occupato a fare il tuo bene, che è pure il mio, e tu altrettanto a me, che è pure il tuo bene.





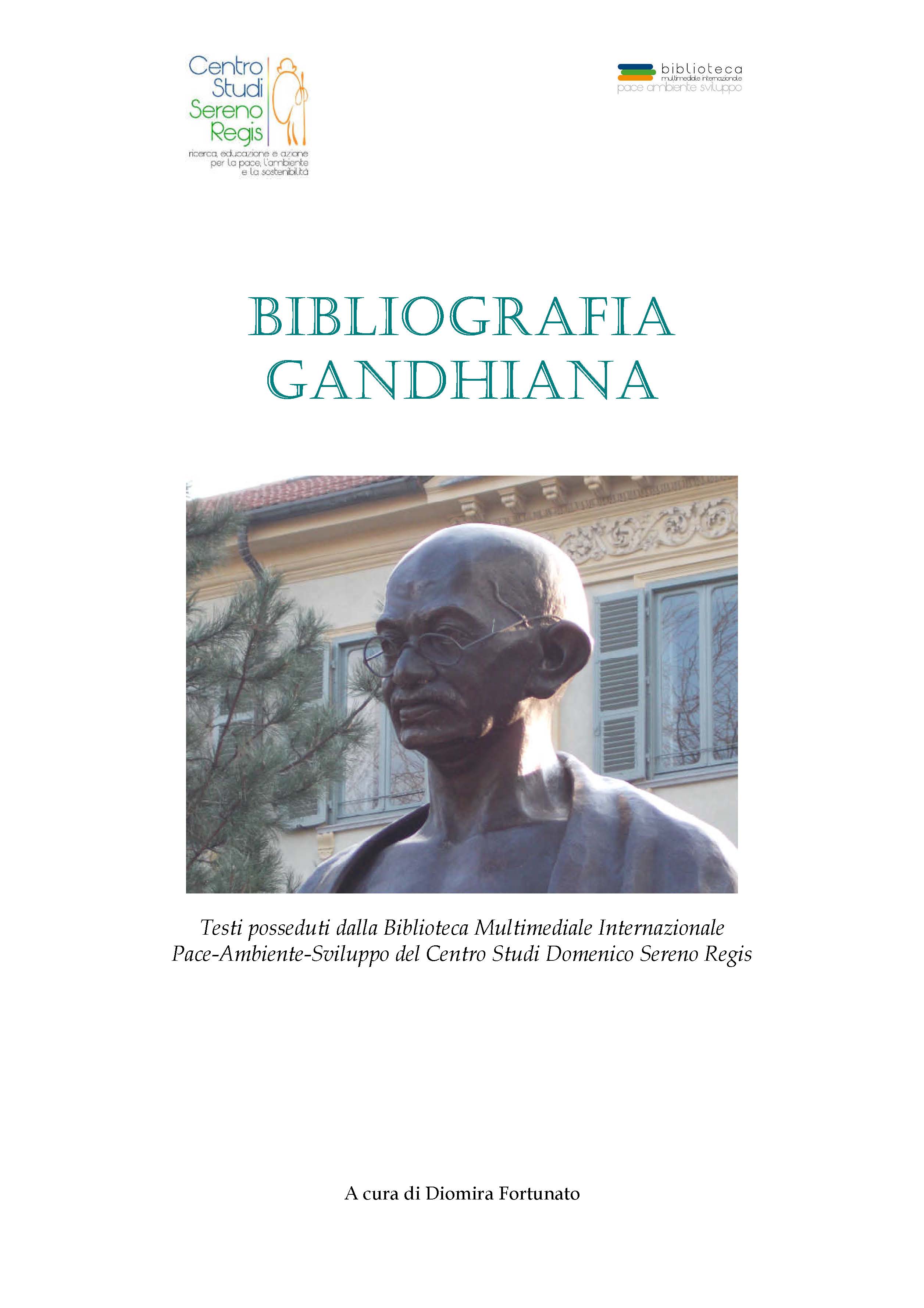























Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!