Diario della crisi da Covid-19. Il caso italiano: una visione epidemiologica complessa
Visto da Torino
A un mese e mezzo dai primi casi di coronavirus in Italia – una coppia di turisti cinesi arrivati il 23 gennaio e ricoverati per malori all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma il 29 gennaio – ho incrociato una signora con il carrello della spesa in attesa dell’autobus davanti ai resti dell’ex Fonderia Caratteri Nebiolo di via Bologna. Aveva la mascherina come la maggioranza dei passanti ma dalla sua spuntava verso l’alto, surreale, una sigaretta spenta.
“Ci aspettavamo dei casi anche in Italia”, ha dichiarato il 30 gennaio il ministro della salute Roberto Speranza annunciando misure di prevenzione oltre alla sospensione dei voli in Italia da e per la Cina. Il virus SARS-Cov-2 si è manifestato ufficialmente all’inizio di dicembre 2019 a Wuhan nella provincia cinese meridionale dell’Hubei anche se ora le autorità cinesi, che hanno ammesso il contagio da uomo a uomo solo il 21 gennaio 2020, ne retrodatano la comparsa al 17 novembre 2019.
Da noi il primo caso di trasmissione locale si è reso noto a Codogno in provincia di Lodi il 18 febbraio. Il 26 febbraio, quando i due turisti cinesi provenienti proprio da Wuhan sono guariti, il governo italiano aveva già emanato il Decreto Legge (23 febbraio 2020) per contrastare il contagio da sindrome di Coronavirus (Covid-19). A questo sono seguiti (finora) cinque Decreti attuativi: DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 1 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020.
L’11 marzo, lo stesso giorno in cui l’OMS contando più di 118mila casi di Covid-19 in 114 paesi e 4.291 decessi ha ufficializzato il passaggio del contagio da epidemia a pandemia, l’Italia ha sorpassato la Corea del Sud – secondo paese focolaio in ordine cronologico dopo la Cina, ora superata anche dall’Iran – per numero di casi conclamati. L’ultimo bollettino della John Hopkins University di Baltimora (16 marzo) conta ormai quasi 200.000 casi di contagio (7000 morti) nel mondo: 81.000 (3200) in Cina, quasi 30.000 (2200) in Italia, 15000 in Iran (900), 8300 (75) in Corea del Sud.
Mentre il focolaio epidemico è in rapidissima diffusione in tutta Europa, il caso e l’esperienza italiani sono usati come monito contro l’inazione e come riferimento dai governi del mondo, ma restano aperte le domande sul perché in Italia il Covid-19 abbia avuto una tale virulenza, soprattutto in Lombardia (13300 casi, 2011 morti) – la regione più ricca e che vanta il miglior Sistema Sanitario del Paese, ma che ha un tasso di letalità da coronavirus dell’8 % rispetto al 3 % atteso. La cosa più allarmante per i paesi che vivono ora la fase di innesco del contagio è che l’Italia non sembra aver commesso errori gravi nella gestione dell’emergenza. Già il 23 febbraio, dopo il primo diffondersi del contagio e i primi decessi le autorità hanno posto in quarantena i 50mila abitanti di Codogno e altre dieci città in provincia di Lodi, imponendo misure restrittive per la circolazione e ordinando la chiusura delle scuole e dei locali pubblici. Il Sistema Sanitario Nazionale italiano ha reagito molto velocemente anche se ha avuto la sfortuna di essere il primo paese europeo a dover contrastare il virus. Per chiarire se si sarebbe potuto fare altro per prevenire un così rapido sviluppo dell’epidemia, occorre prima spiegare il motivo dell’alto numero di vittime italiane e lombarde e rispetto ai casi positivi in confronto con tutti gli altri paesi che subiscono gli effetti della pandemia. Non abbiamo ancora abbastanza informazioni sull’arrivo e la diffusione del virus nel nostro paese per poter capire cosa sia accaduto e trarne lezione per gli altri stati, tuttavia, ci sono alcuni fattori sociali, economici e ambientali che potrebbero essersi sommati rendendo l’Italia una vittima perfetta.
Il caso italiano e l’uso dei tamponi
Stanislao Loria, docente di sanità pubblica all’Università Federico II di Napoli, interlocutore principale di questo contributo, suggerisce di guardare ai numeri come una guida e non come un dogma: “La modalità di esecuzione dei tamponi per identificare i casi positivi non è uniforme né tra i Paesi citati, né nell’ambito di uno stesso Paese. Pare che, in situazione di emergenza, oltre a un diverso protocollo operativo (a chi fare il tampone: solo ai sintomatici o anche a tutti i loro contatti, compresi gli asintomatici…) siano state anche usate modalità e strumenti differenti con affidabilità del test stimata attorno al 70%, non proprio sicurissima. In Italia si era iniziato facendo tamponi sulle persone venute a contatto dei casi positivi, anche se asintomatici; poi, constatata l’alta percentuale di falsi positivi, quando i tamponi hanno iniziato a scarseggiare si è deciso di farlo solo ai sintomatici”.
Infatti, dal 27 febbraio le strutture sanitarie italiane fanno i test solo su persone con i sintomi di malattia, per cui i dati ufficiali individuano una frazione ridotta delle persone infette escludendo moltissimi asintomatici. “La definizione in Italia di ogni caso di Covid-19, secondo le indicazioni fornite dalla Circolare 9 marzo 2020 del Ministero della Salute – precisa ancora Loria – poggia ora su questi elementi: il rilievo clinico di una sintomatologia a carico dell’apparato respiratorio, il rilievo anamnestico di un pregresso contatto con soggetto positivo o proveniente da focolai epidemici e infine dal rilievo del test di laboratorio positivo. Così però non abbiamo dati certi sulla effettiva circolazione del virus e, di conseguenza, è difficile calcolare la letalità con accuratezza e addirittura fare raffronti con altri Paesi”.
Quando leggiamo i bollettini quotidiani osserviamo quindi solo la punta dell’iceberg. Se potessimo contare tutti i casi positivi il tasso di letalità si abbasserebbe anche per l’Italia. Questo significa però che la diffusione del virus è enormemente più ampia di quanto non dicano le statistiche ufficiali, quindi non 30000 casi ma decine di migliaia in più. Lo stesso si potrebbe dire per gli altri paesi europei che stanno percorrendo la stessa curva di contagio: nel giro di una settimana ci sarà un’esplosione in tutta Europa.
L’efficienza del Sistema Sanitario
Altre considerazioni per spiegare i dati di incidenza e letalità del virus in Lombardia possono essere legate ai finanziamenti cronicamente insufficienti stanziati per il Servizio Sanitario Nazionale, che potrebbero rivelarsi come uno dei fattori di peggioramento della crisi. Un confronto è possibile con l’apparente efficienza del Sistema Sanitario in Corea del Sud, paese simile al nostro per popolazione e superficie dove lo stesso virus ha manifestato una ben diversa e decisamente inferiore letalità.
Grazie all’esperienza di Stanislao Loria possiamo aggiungere che come ogni altro servizio, dalla distribuzione di energia all’erogazione di potenza di un motore, il Sistema Sanitario dovrebbe operare in condizioni ordinarie all’80 % o al massimo al 90 % delle proprie capacità lasciando un margine per la gestione di emergenze e i picchi di domande di servizio. Il SSN Italiano sta invece lavorando da decenni ad almeno il 95 % delle proprie capacità in condizioni di stress ordinario, già quasi al collasso, quindi, quando il coronavirus è arrivato. Anche in Corea del Sud si sono trovati impreparati davanti al numero di malati con un numero perfino inferiore di posti in terapia intensiva per abitante rispetto all’Italia, ma invece di creare una zona rossa, la Nord Corea ha puntato sulla rigida applicazione di quarantene, sul controllo capillare dei contatti dei pazienti positivi e sulla capacità diagnostica. Andrea Capocci sottolineando la discrepanza fra i dati ha spiegato che un “fattore decisivo è la capacità diagnostica. Sulla carta, i criteri con cui le autorità sanitarie sud-coreane scelgono quali persone devono sottoporsi al test per il coronavirus non sono diversi da quelli usati da noi. Ma la disponibilità di test è più elevata, si arriva a farne fino a 20mila al giorno, più ancora degli 11mila tamponi effettuati in Italia. Anche in Corea del Sud serve una prescrizione medica per il test, ma pagando circa 130 euro lo si può fare anche senza. Decine di centri diagnostici sono stati allestiti direttamente in strada e il tampone si può fare senza scendere dalla macchina. Così diminuisce il rischio di infezioni per medici e altri pazienti. I laboratori autorizzati per il test sono 96, il doppio rispetto ai nostri” (“Il Manifesto”, 14 marzo 2020, Alta diagnostica e controllo sociale, il modello Corea del sud ribalta i numeri). Questo ha permesso di rintracciare rapidamente un numero in proporzione molto più grande di persone infette e asintomatiche il cui numero è molto più frequente del previsto. Grazie a questa strategia il profilo dei casi positivi in corea del Sud risulta diverso da quello italiano: “le persone positive sono più giovani (meno di cinquant’anni contro oltre sessanta da noi) e hanno meno sintomi. Le donne (…) sono il 62% delle persone contagiate e hanno fattori di rischio minori: solo il 6 % delle coreane fuma, contro il 38 % dei maschi” conclude Capocci.
L’inizio del contagio
Anche se su questo non vi è certezza, un’altra possibile considerazione è che i casi anche fatali di coronavirus non si sono diffusi in Italia solo nelle ultimissime settimane. È altamente probabile che il virus fosse già in circolazione non riconosciuto nel nostro paese almeno da metà gennaio e rigogliosamente perché molti dei pazienti infettati non hanno avuto sintomi o soltanto lievi, come tosse, mal di gola e una lieve febbre. Il virus SARS-cov-2 può infatti essere diffuso anche da persone che non manifestano alcun sintomo – sta anzi inaspettatamente emergendo che è proprio questo il canale più probabile – o i cui sintomi sono stati attribuiti a polmoniti virali ma senza verifica della presenza del coronavirus. Per esempio, pare che negli ospedali italiani del Nord era già stato notato un eccesso di polmoniti un mese prima dell’epidemia conclamata, anche se non è confermato che fossero dovute al coronavirus. La gravità dei sintomi nei casi più difficoltosi si è manifestata anch’essa in forma progressiva, sottostimata all’inizio a causa dello scarso livello di attenzione che in quel momento ancora si poneva alla prevenzione del Covid-19. L’evento chiave si è avuto il 19 febbraio scorso quando il paziente uno, tuttora ricoverato a Pavia, di 38 anni si è recato per la seconda volta in ospedale a Codogno in condizioni di polmonite già grave e apparentemente incurabile dopo una prima visita il 18 febbraio, quando gli fu permesso di ritornare a casa senza idea di fare alcun test nonostante due giorni di febbre alta, perché il suo profilo sanitario non autorizzava un ricovero coatto. Nel tentativo di comprendere quali cure applicare e dopo aver scoperto che aveva partecipato a una cena con un collega che era stato in Cina, poi risultato negativo, si sono finalmente rotti i protocolli e, richiesta l’autorizzazione all’azienda sanitaria, si è proceduto con il tampone. È stato cioè solo per l’aggravarsi dei sintomi che è stato possibile riconoscere questo come primo caso conclamato di trasmissione del Covid-19 in Italia che fino a quel momento ne contava solo quattro, tutti importati. In questo breve lasso di tempo senza precauzioni, il paziente uno potrebbe aver permesso al virus di diffondersi addirittura dentro l’ospedale, infettando gli operatori sanitari e pazienti che già avevano una salute fragile.
L’eccesso di letalità
Secondo Loria per il calcolo della letalità in Italia “il problema non riguarda solo il denominatore, cioè il numero dei pazienti positivi al test, ma anche il numeratore, cioè il numero dei decessi da coronavirus. È difficile attribuire la causa di morte per polmonite a un solo virus in un periodo in cui circolano assieme tanti altri virus di norma e storicamente non testati. La diagnosi di morte è diversa dalla causa di morte, bastando a stabilire la prima l’arresto cardio-respiratorio, non bastando a stabilire la seconda talvolta nemmeno l’esame anatomopatologico. Il caso dei tumori professionali, indistinguibili dagli altri tipi di tumori, è il caso più clamoroso ma quasi mai le diagnosi di morte forniscono informazioni circa il ruolo avuto nel decesso della coesistenza accanto alla causa principale di malattie non letali anche se gravi e invalidanti o delle condizioni socio economiche e ambientali che comunque hanno un ruolo. La diagnosi di morte degli anziani, in particolare, è collegata con una molteplicità di cause che si accumulano e si potenziano a vicenda. È per questo che ricondurla al solo isolamento del virus può essere molto riduttivo.
La diagnosi di morte insomma dovrebbe riflettere più il passato che il presente, essendo il decesso solo l’ultimo passaggio biologico di un processo morboso in cui rientrano esposizioni a fattori di rischio pregressi, lontani misconosciuti”.
“Emerge in questa situazione – precisa ancora Loria – la mancanza, o forse l’incapacità ancora, di un ragionamento complessivo sulle sinergie causali delle malattie moderne trasmissibili e non trasmissibili, sul reciproco potenziamento tra cause naturali e antropiche, approccio che sarebbe ancor più necessario se come qualcuno adombra il coronavirus che ha colpito l’Italia ha davvero un’origine autoctona. Tutto ciò induce a riflettere sulla necessità di rivedere in maniera definitiva l’ipotesi di causa unica anche per le malattie a genesi infettiva e per spiegare i fenomeni epidemiologici che stiamo confrontando”. Insomma, i postulati di Henle Kock[1] che hanno consentito nel passato di associare numerosi microrganismi alle rispettive malattie potrebbero non essere applicabili in questo caso, così come non bastano virologi, infettivologi, epidemiologi, sociologi e antropologi per spiegare, e risolvere, un fenomeno di tale complessità e portata. “In realtà, – conclude Loria – di fronte a una tale complessità del quadro epidemiologico, la comprensione del problema (soprattutto la sua dimensione) potrebbe essere semplificata se potessimo comparare la situazione attuale con i dati del recente passato”.
L’inquinamento atmosferico
Occorre per esempio ragionare sul fatto che le polmoniti possono essere favorite, o addirittura causate, anche da altre circostanze come gli sbalzi di temperatura, anche giornalieri, cui stiamo assistendo ultimamente. E poi c’è l’inquinamento atmosferico. Per quanto riguarda le prime tre nazioni focolaio in ordine cronologico Cina, Corea del Sud e Italia, i primi casi positivi si sono concentrati in zone altamente industriali e con un elevato livello di inquinamento atmosferico: Wuhan nella provincia dell’Hubei in Cina, Daegu e Gyeongsang in Corea del Sud, la Lombardia e la Pianura Padana in Italia. Restando al nostro territorio, i dati diffusi dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) il 13 marzo e ripresi da numerose agenzie di stampa sono eloquenti: la sonda satellitare Copernicus Sentinel-5P con i suoi sensori spettrofotometrici ha mostrato un netto declino dell’inquinamento atmosferico correlato con le emissioni di biossido d’azoto nelle stesse zone del Nord Italia in cui sono state prese misure contro il contagio da coronavirus. L’animazione visibile sul sito dell’ESA[2] mostra le variazioni del biossido d’azoto in atmosfera su tutta l’Europa fotografate ogni dieci giorni dal 1 gennaio all’11 marzo, mentre una voce fa notare che la riduzione è particolarmente evidente lungo l’intero corso del Po. Anche se potrebbero esserci disturbi dovuti alla presenza di nubi o alle variazioni di temperatura, gli scienziati sono concordi nel ritenere attendibili queste osservazioni correlandole con il blocco del traffico e della produzione industriale nelle stesse aree. Come già osservato, per quanto benefico, questo effetto è poco consolante e con buona probabilità destinato a perdurare giusto fino a risoluzione della crisi epidemiologica. Ma questo è quanto osserviamo oggi: basta riprendere i giornali dello scorso gennaio per ritrovare gli allarmi legati all’inquinamento atmosferico in quelle stesse regioni mentre si superavano i limiti ammissibili di polveri sottili e a Torino addirittura scattava l’allarme viola. “La pianura padana è notoriamente interessata da fenomeni di inversione termica, condizione che rende stagnante l’aria negli strati bassi dell’atmosfera e scarsi i relativi ricambi d’aria – aggiunge Loria –. Quindi i numerosi casi di polmonite osservati finora dovuti o meno al coronavirus devono essere collegati anche con l’esposizione a contaminanti ambientali, circostanza confermata continuamente dagli studi epidemiologici svolti sulle popolazioni che abitano in zone così inquinate”.
Così, mentre purtroppo aumentano i decessi, diventa assai opinabile l’individuazione di una causa unica, non essendo sufficiente la presenza del coronavirus a spiegare l’eccesso di morti in Italia in generale e in Lombardia in particolare. Il collegamento con l’inquinamento atmosferico come possibile concausa e vettore della malattia attraverso la stagnazione temporanea del virus sulle particelle di polveri sottili, soprattutto in condizioni ambientali umide, potrà forse essere verificato per il caso italiano osservando le differenze di incidenza del virus tra Nord e Sud, zone intimamente collegate ma con problematiche ben diverse: la prima prevalente sede delle industrie con un grave inquinamento atmosferico e la seconda prevalente sede dei lavoratori con problemi di strutture sanitarie e anche di inquinamento ma, a parte alcune aree come Taranto, Napoli e Palermo, non di tipo atmosferico.
“In questi giorni – aggiunge Loria – molti studiosi fanno riferimento ad algoritmi, modelli matematici basati soprattutto sul comportamento dei virus, sottovalutando le circostanze antropiche che favoriscono il contagio e le eventuali sinergie. Dati più semplici da leggere, nei quali probabilmente è concentrata tutta l’informazione che ci serve, dovrebbero essere quelli sulla mortalità generale nel nostro paese per confrontare i dati di questo periodo anche solo in numero assoluto con quelli degli ultimi anni, suddividendoli per residenza, fasce di età e, magari, frammentando l’analisi per periodi brevi, per esempio settimanali. La fonte per fare questo sono le anagrafi comunali che registrano i decessi in tempo reale oltre a tenere il conto dei residenti. Bisognerebbe mettere subito in rete questi dati per consentire una raccolta e una elaborazione immediata dei dati della mortalità generale. Questo confronto ci darebbe interessanti notizie anche ai fini della programmazione dell’assistenza”.
Un confronto sui dati di mortalità sarebbe oltremodo necessario perché un ulteriore fattore che si somma ai precedenti per tentare di spiegare la diversa virulenza del Covid-19 è l’elevata età media degli Italiani; le persone anziane presentano mediamente più patologie preesistenti e quasi un quarto (22.6 %) della popolazione italiana ha più di 65 anni: la più elevata in Europa e fra le più alte del mondo.
La vera prevenzione
Telmo Pievani in un editoriale per l’Università di Padova (Coronavirus: uno sguardo evoluzionistico, 9 marzo 2020) ha spiegato che “noi (umani) non soltanto siamo un ospite perfetto per i virus, ma abbiamo dei comportamenti che li favoriscono. Depredare, perturbare gli ecosistemi, soprattutto le foreste primarie, è una pessima idea se vogliamo difenderci da questi virus, perché alcuni di loro, i più pericolosi, sono quelli che hanno fatto il salto di specie. (…) Alcune di queste epidemie sono ancora in corso, come ebola, e mietono tantissime vittime, soprattutto in Africa ma non solo”. In emergenza le misure di sorveglianza del contagio, rintracciabilità dei contatti dei soggetti positivi, il mantenimento delle distanze di sicurezza, le restrizioni alla mobilità, l’invito all’igiene, le vaccinazioni antiinfluenzali per le persone deboli e immunodepresse, così come il rinvio di servizi e operazioni non-essenziali svolgono ognuna un ruolo nel ritardare la diffusione delle infezioni e ridurre la pressione sulle strutture sanitarie.
Il virus SARS-CoV-2 avrà infatti impatti differenti a seconda soprattutto del livello di assistenza sanitaria delle popolazioni su cui si accanirà. Pochissimi commentatori ricordano che l’Iran, il terzo principale focolaio al mondo in questo momento, con 13000 casi e più di 600 morti è un paese sotto embargo anche dei generi di prima necessità. A Baghdad, dove vivono 7,5 milioni di iracheni (110 casi, 10 decessi) le infrastrutture sanitarie e fognarie già precarie hanno subito bombardamenti dal 2003 al 2018. In altri paesi già provati da difficili condizioni sanitarie, come in Nigeria (2 casi confermati) o nella maggior parte dell’Africa sub-Sahariana e in molte nazioni dell’America Latina e del Medio Oriente, non ci sono le condizioni per far fronte al coronavirus. Questi paesi possono affrontare casi sanitari anche gravi individuali ma un’epidemia potrà facilmente sopraffare i loro servizi sanitari con conseguenze non prevedibili. Probabilmente i bilanci del passaggio di Covid-19 in queste regioni non li potrà fare mai nessuno. Nessuno ne saprà nulla così come non sappiamo quante persone muoiono per gli uragani nelle zone povere del mondo, così accadde nel 2005 per l’uragano Katrina a New Orleans (ancora nessun caso di coronavirus) e lo scorso agosto per l’uragano Dorian alle Bahamas (un caso). Non lo sapremo mai. Va però precisato che la vera prevenzione si può anche fare diversamente e senza bisogno di ridursi a contabili del fallimento calcolando i danni e le vittime a ritroso. “I virus hanno degli avversari – ha aggiunto Pievani – che noi possiamo scatenare contro di loro indipendentemente dall’urgenza: la ricerca scientifica, l’igiene, il progresso sociale (ricordiamo che la povertà, la diseguaglianza, le carestie, le guerre sono tutti alleati dei virus) e poi naturalmente anche la protezione ambientale; può sembrare strano, ma c’è un legame molto stretto fra tutte queste vicende”.
Ringraziamo la rivista Gli Asini (http://gliasinirivista.org/) per aver concesso la riproduzione di questo articolo
[1] I postulati di Henle Kock sono validi per assegnare ogni malattia a un singolo agente e viceversa senza tenere in conto altri fattori (es. malattia a eziologia multipla, fattori ambientali etc.): il microorganismo patogeno deve essere presente in tutti i casi di malattia osservati. Non deve essere presente in casi di altre malattie né in individui sani. Non deve essere isolato dai tessuti in coltura pura. Deve essere capace di riprodurre la malattia attraverso infezione sperimentale.
[2] http://youtu.be/ARpxtAKsORw, ultimo accesso 16/3/2020.


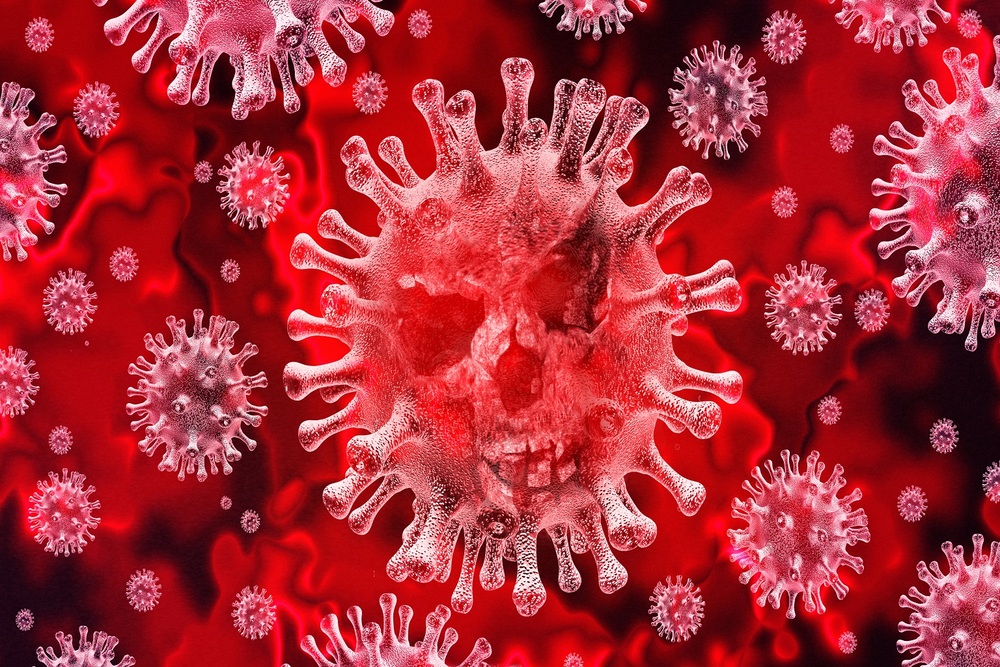























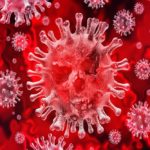

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!