Il dovere di non collaborare. Pragmatici e persuasi
Libri – Pietro Polito, Il dovere di non collaborare. Storie e idee dalla Resistenza alla nonviolenza, Edizioni SEB 27, Torino 2017, pp. 180, euro 15 (dalla discussione nella Sala Poli, Centro Studi Sereno Regis, 12 dicembre 2017)
Questo di Pietro Polito è un libro bello, ricco di letture, di pensieri raccolti, di esperienze narrate, di belle vivide figure storiche. L’Autore dice che è un libro storico, descrittivo, non a tesi. Io però ci vedo tracce di un cammino, una evoluzione, dalla Resistenza alla nonviolenza.
E subito mi viene in mente don Primo Mazzolari (1890-1959) che, nel 1952, a soli sette anni dalla fine della guerra, scriveva: “Se facessimo la resistenza come l’abbiamo fatta ieri, con l’animo di oggi, saremmo in peccato” (p. 149 dell’edizione critica, a cura di Paolo Trionfini, di Tu non uccidere, EDB, Bologna 2015). Le prime edizioni di questo libro, dal 1955, uscirono senza il nome dell’autore Mazzolari, a cui la gerarchia aveva proibito di scrivere e predicare: nel clima della guerra fredda, parlare di pace era visto come favorire il nemico. Solo nel 1965, sei anni dopo la morte di Mazzolari, il libretto uscì col suo nome. Mazzolari si avvicinava al concetto di resistenza di Aldo Capitini.
E mi ricordo che Norberto Bobbio, in una piccola cerchia di conversazione, al Centro Gobetti, una volta ci disse: “A volte mi sono pentito di non avere sparato ad un soldato tedesco, ma so che se l’avessi fatto sarei pentito di averlo fatto”. È l’intelligente pensiero bipolare di Bobbio.
C’è un uccidere giusto, giustificabile? Il caso estremo lo ipotizza anche Beccaria (qui a p. 10), e anche Gandhi parla di casi tragici estremi in cui “uccidere può essere un dovere” (Teoria e pratica della nonviolenza, Einaudi 1996, p. 69), anche se sembra più esatto parlare di necessità che di dovere.
Il “non uccidere” nella Bibbia è subito delimitato da circostanze: non uccidere l’innocente (Esodo 23) e chi uccide sarà ucciso (Esodo 21). La Bibbia ammette la vendetta privata, ma limitata dalla proporzione: “occhio per occhio”, ma non di più. Ed anche questo sarà superato. In tutto c’è movimento, evoluzione, anche nelle cose sacre: “La Scrittura cresce con chi la legge” diceva Gregorio Magno nel VI secolo. Anche papa Ratzinger ha ammesso una evoluzione del dogma, il quale non significa fissità, ma una tappa della comprensione.
Ogni principio morale richiede discernimento nella situazione. Per applicare questo metodo, papa Francesco (p. es. in Amoris Laetitia, cap. 8) viene attaccato dai moralisti assoluti.
Ma le azioni umane hanno un orientamento fondamentale, di principio. Ho raccontato molte volte la mia esperienza infantile dell’aver visto uccidere, a guerra finita, tre soldati tedeschi che avevano perso il contatto coi loro in ritirata, da parte di partigiani, senza alcun motivo, per puro trascinamento della svalutazione della vita nemica. Nel bimbo di nove anni che ero io si stampa il valore: non si deve uccidere. La Resistenza è stata giusta, il mezzo armato comprensibile, ma l’uccidere esseri umani degrada l’umanità. Antonio Giolitti (p. 40) non esclude la violenza, ma è consapevole dei guasti che produce. Il problema non è “tutto bene o tutto male”, ma evoluzione: perciò sottolineo “dalla Resistenza alla nonviolenza”.
La “tensione” della ricerca morale è superiore alla regola formulata, e alla “necessità” della situazione: se la guerra poteva essere in altri tempi giustificata come necessaria, oggi diventa impossibile sia per l’evoluzione morale, sia per la distruttività estrema: Giovanni XXIII dichiarò “alienum a ratione”, fuori da ogni ragionevolezza, il giustificarla. La Resistenza non è stata solo armata, conteneva già ampie forme di lotta nonviolenta, allora non teorizzata come è oggi.
Due resistenze in una sola
Il 25 maggio 2015, ci trovammo all’Istoreto, studiosi maturi ed anziani, giovani ricercatori, per conversare con storici di classe come Anna Bravo e Giovanni De Luna, autori entrambi di recenti importanti libri, sulla Resistenza armata, non armata e nonviolenta, detta anche civile.
De Luna, nel suo libro La Resistenza perfetta (Feltrinelli 2015), afferma che senza la Resistenza armata, quella civile non avrebbe avuto ragione di essere. Anna Bravo, come altri autori, da Semelin in qua, afferma che, in tutta Europa, la Resistenza civile al dominio nazista e fascista, ha avuto una sua autonomia di mezzi e di azione rispetto alla forma armata, pur convergenti entrambe allo stesso fine di difesa e liberazione, e nel rispetto e riconoscimento da parte dei resistenti civili della dedizione e sacrificio dei partigiani combattenti.
È venuta in discussione la presunta gerarchizzazione delle due forme di lotta, che secondo gli interpreti dell’immagine armata della Resistenza verrebbe compiuta dai ricercatori della nonviolenza nella storia e nella politica. Questi però ribadiscono: riconosciamo non solo la scelta delle armi in quel momento da parte dei partigiani, anche per la non conoscenza di esperienze nonviolente, ma riconosciamo pure che esistono tragiche situazioni estreme in cui uccidere diventa una brutta necessità. Eppure non ci si può acquietare in ciò, e bisogna cercare, nelle esperienze storiche come nei progetti politici, lo sviluppo di mezzi di lotte giuste, libere dall’uso della morte artificiale aggiunta alla nostra mortalità naturale. Ciò sarebbe una evoluzione umana, una emancipazione dalla necessità ripetitiva violenta. Il non uccidere è un obiettivo irrinunciabile di umanizzazione, non è un di più per anime belle.
De Luna ha ritenuto che gli storici della Resistenza civile, negli ultimi venti anni, abbiano posto come un anatema sulla lotta armata. A me pare proprio di no. Il punto non è solo la coraggiosa decisione personale-esistenziale di passare la soglia oltre la quale c’è il morire e far morire (la soglia tracciata da Barbato ben illustrata nel libro di De Luna), ma è soprattutto lottare, anche a rischio di morire, con la forza e la volontà umana di giustizia, senza affidare il giudizio alla capacità distruttiva delle armi, giudizio che per sua natura sfugge al criterio umano e facilmente si ritorce anche in effetti di disumanizzazione di chi usa le armi, pur con giuste ragioni.
Resistenza guerra giusta?
La Resistenza è stata (come dice Borgna, a p. 10-11 del libro di Polito) una guerra giusta? Non la includerei del tutto nella “guerra”, ma nella “rivolta” di coscienza (armata o non armata): nelle bande partigiane non vigeva il comando di uccidere, come negli eserciti, secondo quella affermazione del generale Carlo Jean, che ho citato tante volte: “Nell’esercito occorre l’obbedienza automatica, perché si tratta di uccidere”. Ma un’obbedienza automatica non è umana.
La vittoria della forza non è mai la pace giusta. È un puro caso che la forza vincente, perché è maggiore, sia quella che difende il diritto e non il sopruso. Il confronto tra due violenze non c’entra nulla col confronto tra due ragioni o diritti. Bobbio ha ripetuto: “La guerra è l’antitesi del diritto”. C’è una irrazionalità radicale della guerra, prima di ogni giudizio morale.
Si deve resistere al potere ingiusto, anzitutto non collaborando con la propria obbedienza. Gene Sharp mostra che il potere consiste nell’essere obbedito, per le più varie ragioni, dalla convinzione alla convenienza. Non esiste il sangue blu dei re, che renda il potere per sua natura legittimo. Tutti abbiamo, se lo vogliamo, l’arma no, che inceppa il comando ingiusto: è l’arma che non uccide. Le condizioni per usarla sono il motivo giusto, la consapevolezza, il coraggio.
Si può togliere al prepotente il sostegno degli esecutori-collaboratori, ridurlo nudo, metterlo nella necessità di restituire parità, non occorre ucciderlo. La nonviolenza è lotta, pura dalla riproduzione della violenza. Non è sempre facile: si tratta di una tensione, movimento, avvicinamento, una evoluzione umana. Neppure Gandhi è assolutista: parla di “ridurre la violenza al minimo possibile”. Una evoluzione concreta verso la liberazione da ogni uccidere, non va accusata di utopismo fuori dal mondo, oppure di integralismo morale. La pazienza attiva e costruttiva della nonviolenza si oppone alla follia del pensiero armato, che precipita fino alla catastrofe.
Gobetti: etica, politica, religione
Mi soffermo sul capitolo “Antifascismo etico”, su Gobetti (pp. 63-67). Davanti alla presa di potere di Mussolini, bisognava collaborare (come fecero alcuni popolari, in coscienza cristiani) per moderare, ridurre il danno? Oppure, come fece Gobetti, su base morale civile, bisognava giudicare, opporre “l’opera educativa”, essere “esuli in patria”? Se si vuole comprendere e rispettare la scelta della riduzione del danno, del “minor male”, si dovrà almeno altrettanto comprendere e rispettare la scelta di Gobetti.
Polito cita una pagina di Gobetti “contro la politica come mera tattica”, pagina che “andrebbe rimeditata in questo nostro tempo” (p. 65). Quello di Gobetti “non è il realismo che viene a patti con la realtà, ma è il realismo che fa i conti con la realtà”. Scrive Gobetti: “Bisogna concepire il nostro lavoro come un esercizio spirituale, che ha la sua necessità in sé, non nel suo divulgarsi”, cioè non nel successo. E Polito: “la lotta di Gobetti al fascismo prima ancora che politica è di natura morale, ha un valore religioso, è un problema di stile” (p. 66).
E si potrebbe parlare anche dell’antifascismo “religioso” di Capitini (p. 75-88). Entrambi laici, non cattolici, sarebbero moralisti integralisti, con una idea e prassi impropriamente dettata alla politica, o invece appartengono al meglio della politica civile italiana?
La religione non è solo sudditanza dottrinaria e rituale all’istituzione cattolica in Italia (p. 76), che certo è stata anche un potere politico, ma da 50 anni si va liberando dal potere, per essere vangelo.
La “religione” in senso serio e spirituale, è vita della coscienza, è umanesimo profondo e alto, che “collega” in libertà e giustizia la persona al tutto sociale e spirituale: “Religiosus esse nefas, religentes oportet” (Aulo Gellio). Ogni diversa religione ha un suo riferimento essenziale – per i cristiani Gesù di Nazareth, come modello e maestro di uomo compiuto – ma tutte le religioni autentiche sono forme di massima socialità. Così possono ispirare la politica, la convivenza umana. La politica è essenzialmente giustizia dei rapporti umani, ben prima che tecnica del potere, e lotta spregiudicata per conquistarlo.
Il potere serve alla giustizia, e non viceversa. La politica non è una tecnica o una meccanica, ma appartiene all’etica, che cerca l’agire umano migliore. Avessimo oggi un laicismo come quello di Gobetti e Capitini, avessimo – ma sta venendo, specialmente con Francesco – un cristianesimo umano, non sacrale, non autoritario, non politico-potente, e perciò veramente “politico”, cioè servizio fraterno alla convivenza plurale di tutti. Non c’è nulla da temere se l’universalismo-pluralismo spirituale (di cui ho incontrato maestri come Panikkar, Bori, Küng) viene ad animare una politica che oggi pare senza idee e progetti, perché senza anima, ridotta a brevi calcoli interni al sistema ingiusto vigente.
Alcuni punti maggiori
Ritengo importante per me evidenziare e meditare alcuni punti del bel libro di Polito:
Pag. 34 – Oggi manca l’aver fatto l’esperienza di una scelta morale come la Resistenza, di un tale bivio morale, che anche chi allora era giovane o bambino ha respirato nell’aria. Perciò le scelte sono oggi di basso livello, di interesse, di appartenenza: non si trova in gioco la qualità umana. Non deve esserci bisogno dell’estremo, ma almeno la memoria, e almeno la coscienza che in realtà anche oggi è in gioco la qualità e il senso umano: la distruttività nucleare insensata, la rovina della natura che è vita nostra, la mercificazione della vita di persone e popoli assoggettati al potere della finanza, non sono forse un urgente motivo per resistere con forza, costruendo radicali alternative vitali?
Pag. 35-37 – Tra i condannati a morte ci sono testimonianze alte laicamente “religiose” e anche “evangeliche” (p. 36) per la loro purezza morale e dedizione all’umanità.
Pag. 56 – La Resistenza pensata da Polito, meditata, insieme a profondi testimoni, potrebbe dare a questo libro anche il titolo “Umanità della Resistenza”. Vedi Bianca Guidetti Serra dove parla (p. 54) di “protagonismo femminile senza mai impugnare un’arma”; “riconoscere anche nei nemici delle persone”; “ritrovare la dimensione umana che ci accomuna al nemico”. “La democrazia è il regime delle persone semplici”.
Pag. 57-59 – Antonicelli insegna e ammonisce: imparare è una cosa difficile. La rivoluzione non è vendetta, ma lavoro leale del contadino, però anche la tempesta potrebbe un giorno essere leale. L’accento non va più sulla Patria, ma sull’Umanità.
Pag. 75-88 – Capitini afferma che in realtà la Resistenza c’è dal 3 gennaio 1925 (p. 84), e lui l’ha fatta, a caro prezzo personale, fin dal gennaio 1933. Il conflitto armato è secondario rispetto alla solidarietà popolare, elemento vincente ( p. 85). “L’altra via” sognata da Capitini: che “gli italiani si liberassero dal fascismo da soli”, con una “eroica non-collaborazione e disobbedienza civile…. senza torcere un capello a nessuno”. Ma questa possibilità non era conosciuta, e il fascismo era appoggiato da chiesa, monarchia, esercito, intellettuali (p. 86-87)
Pag. 89-96 – La serietà di Pavone: problema della religione, non necessaria alla morale (p. 95) e problema della violenza: è contento di non avere ucciso, meglio essere ucciso (96)
Pag 105-111 – Caffi: la violenza perpetua la violenza. Egli conclude ponendo a base gruppi di amicizia: l’amicizia (fratellanza, compassione) è base di politica umana, è energia di evoluzione umanizzante.
Pag. 112-115 – Dopo un ricordo di Nanni Salio, Polito legge in Capitini (Tecniche della nonviolenza, Feltrinelli 1967) l’azione della disobbedienza civile e scrive che oggi “possiamo meglio intendere che la violenza perde anche quando vince e la nonviolenza vince anche quando perde”. Questo mi ricorda Michael N. Nagler, che, in Per un futuro nonviolento (Ponte alle grazie, 2005), dopo aver esaminato alcuni casi efficaci di resistenza nonviolenta al nazismo, conclude: «la nonviolenza ogni tanto “funziona”, ma è sempre efficace. La violenza ogni tanto “funziona”, ma non è mai efficace». Che cosa intende Nagler col termine “funzionare”, che mette tra virgolette? Vuol dire che la nonviolenza a volte, ma non sempre, ottiene del tutto ciò che vogliamo, ma ha sempre un effetto positivo sull’intero sistema. Neppure la violenza vince sempre (per il vinto in guerra la violenza è fallita), ma di certo non lascia mai un seme fecondo. Quella che Nagler chiama qui “efficacia”, non è altro che quella “fecondità” che troviamo detta da Merleau-Ponty: «La regola dell’azione non è (…) l’efficacia a ogni costo, ma anzitutto la fecondità» (Segni, Il Saggiatore 1967, p. 102).
Sulle tecniche di non-collaborazione all’ingiustizia, Polito conclude con Capitini: “Non accettare la realtà così com’è è il primo contributo alla sua liberazione” (pp. 113 e 115).
Pag. 116-119 – Calamandrei: la desistenza è pericoloso oblio; la Resistenza è memoria religiosa per “una nuova religione civile per gli italiani”. “Religione civile”, termine usato qualche anno fa dagli “atei devoti” (politici, intellettuali e giornalisti non credenti che vedevano nella chiesa uno strumento di conservazione e difesa dell’«identità occidentale» e del sistema vigente). Ma quella espressione può valere anche come patrimonio morale di una società politica . Così Calamandrei capiva l’intenzione di La Pira (che proponeva di aprire la Costituzione con le parole “In nome di Dio, il popolo italiano…”, poi ritirò la proposta “perché su Dio non si vota”) e scriveva: “qualcosa che va al di là delle nostre persone… un’idea religiosa, perché tutto è religione quello che dimostra la transitorietà dell’uomo ma la perpetuità dei suoi ideali”. Cioè, per Calamandrei, c’è della sacralità in un giusto patto di convivenza umana (p. 119).
Pag. 120-123 – Ada Gobetti auspica un rinnovamento “religioso” dell’umanità, ma non segue Capitini sulla nonviolenza, non esclude casi di necessità della violenza, però ci sono momenti Quando non si deve obbedire (così un suo articolo), ed è maturità umana sostituire il ragionamento alla violenza.
Pag. 124-127 – Massimo Mila scrive un manualetto sulla democrazia per l’istruzione dei partigiani che spesso hanno “opinioni piuttosto selvagge” e pensano di vincere la guerra per impiantare “un fascismo con segno rovesciato”, e fa l’elogio della opposizione politica in parlamento (anche se non si conquista la maggioranza) per un efficace controllo sull’operato del governo.
Pag. 128-133 – Questo bel capitolo su Danilo Dolci mostra un “nuovo modo di vivere la religione e la politica” (p. 129), una opposizione sociale ispirata a purezza morale e ad una radicale efficacia operativa, con coraggio e sacrificio personale. Dolci preferisce parlare di “azione di coscienza” meglio che “obiezione di coscienza”, e subisce 26 processi. Il suo metodo consiste in: 1) realismo, col mezzo dell’inchiesta 2) coinvolgere l’opinione pubblica 3) coltivare valori politici con una rivoluzione permanente 4) comunicare con metodo maieutico, seminare domande per l’autoanalisi popolare e formazione di coscienza.
Pag. 134-138 – Don Lorenzo Milani vuole formare il “cittadino sovrano”, responsabile di tutto, non obbediente sempre per supposta virtù, ma critico e attivo, alternativo al cittadino appagato, come al cittadino arrabbiato contro la politica.
Pag. 139-144 – Pietro Polito, nella presentazione del libro, considera centrali le sue pagine su Pier Paolo Pasolini, un’altra figura di “resistente” in senso ampio e profondo: Polito lo sente differente da sé, ma “il più attuale”. Il poeta è “profeta disarmato”, ha solo la verità della parola consapevole contro il potere, il quale è “un sistema di educazione che ci divide soggiogati e soggiogatori”. Ma l’uso della violenza ribelle non è il necessario rifiuto essenziale, e “non lascia più vedere di che segno sei”. “I pochi che hanno fatto la storia sono quelli che hanno detto no”. “Il rifiuto, per funzionare, deve essere grande, non piccolo, totale, non questo o quel punto, deve essere ‘assurdo’, non di buon senso”. Così fu il rifiuto di Claudio Baglietto, esule per rifiutare il servizio militare, ispiratore di Capitini (p. 160-166).
Il volume contiene anche un inedito di Bobbio “Fiori rossi al Martinetto” e poi sviluppa il confronto tra la nonviolenza “pragmatica” di Calogero e la nonviolenza “persuasa” di Capitini (pag. 154-159). Polito dichiara la sua persuasione: “Il ‘no’ di Baglietto rappresenta l’affermazione purissima del primato della coscienza: la mia propensione è sempre andata più verso i persuasi che verso i pragmatici, verso coloro che, quando è in gioco un valore, credono che l’etica delle intenzioni viene prima dell’etica del risultato” (p. 166).
La nonviolenza “persuasa” è l’idea e ricerca preferita anche da me, come più profonda, ma sono rimasto un po’ perplesso davanti all’affermazione di Capitini che “dal punto di vista religioso, del ‘persuaso’, il valore della nonviolenza non sta nella sua efficacia” e che “importa sommamente non ottenere una cosa o un’altra, ma il modo di ottenerla.
Perché il modo vuol dire l’ispirazione che vive in quel momento, il senso della vita, l’anima, il centro”. “L’atto religioso non vale perché è vantaggioso, ma vale in senso assoluto, per un amore che è superiore a ogni considerazione di utilità” (p. 159). Questo accento sulla pura testimonianza, o martirio, però, nel pensiero nonviolento complessivo va pure composto con la ricerca di effetti reali e positivi per la giustizia e la pace, valori che la nonviolenza vuole pure cercare e in diversi casi storici ha saputo ottenere, più fecondamente dei metodi violenti.
Leggiamo in conclusione Capitini: “Il principio della nonviolenza è mettere il bene al posto del male”. “Il male si vince accrescendo il bene” ( p. 177). Questo è lo stesso vangelo di Gesù di Nazareth, è la fiducia coraggiosa, o fede, che il Bene sia la realtà essenziale, comunque lo chiamiamo, e che sia possibile viverlo, nonostante le offese della storia.
Tutto il libro è percorso da un’idea di religione, vista nei protagonisti, nella loro ricerca, nella loro vita e azione: una religione laica, non una particolare chiesa o tradizione, non una dottrina o istituzione, ma il senso di umanità sentito in sé e riconosciuto negli altri, come un valore grande, non disponibile ai calcoli utilitari. Potrà sembrare troppo vaga una tale idea di religione, ma io l’apprezzo, perché ci unisce nella volontà di verità e giustizia del vivere. È “religione vera” (anche secondo la Bibbia) ciò che ci unisce, ci fa solidali, soccorrevoli, attivi per la pace e la giustizia.
Nella discussione sul libro, nel Sereno Regis, il 12 dicembre, qualcuno ha sottolineato la divergenza tra chi crede in Dio (chiamiamo così, con nome improprio, la realtà vivente vista come origine e meta e spirito della nostra vita profonda) e chi non crede. Oggi anche la teologia cristiana sottolinea la continuità tra fede esplicita, che accoglie segni di luce sul mistero, e la fede nel valore umano in tutti come in noi. Non c’è questo abisso di separazione, quando nel nostro vivere ci riconosciamo tutti poveri cercatori di luce e di bene, e ciò è anche quel tanto di felicità che possiamo assaggiare insieme, nella pace.
Enrico Peyretti, 13 dicembre 2017







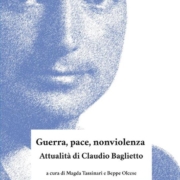



















Bravissimo Enrico: hai recensito come meglio non si poteva il libro di Polito. Grazie molte Fabrizio Truini
Approfitto per fare i più fervidi auguri natalizi e di pace ad Enrico e a tutte/i le e i torinesi.