Le nostre lacrime hanno lo stesso colore
Bushra Awad, Robi Damelin, Le nostre lacrime hanno lo stesso colore, Edizioni Terra Santa, Milano 2017, pp. 151, € 16,00
Nel bellissimo libro edito dalle Edizioni Terra Santa, la giornalista francese Anne Guion raccoglie le testimonianze dell’associazione israelo-palestinese The Parents Circle-Families Forum (PCFF), attraverso il racconto dell’esperienza di vita e dell’incontro di due donne, Robi Damelin, ebrea israeliana di origine sudafricana, che vive a Tel Aviv, e Bushra Awad, palestinese che vive in Cisgiordania.
The Parents Circle, fondata nel 1994, dopo gli accordi di Oslo, dall’ebreo israeliano Ytzhak Frankental dopo la morte del figlio Arik, è un’associazione ormai abbastanza nota, perché da allora si impegna nel portare avanti un processo di pace dal basso attraverso la reciproca conoscenza e l’incontro tra persone di entrambe le parti che, a causa del conflitto, hanno perso dei familiari e che, proprio a partire da questo lutto, si propongono di trovare strade diverse dalla violenza per affrontare in modo equo e sostenibile le questioni in campo. Dal 2003 il PCFF è binazionale, con uffici a Tel Aviv e a Beit Jala.
Ma il libro è molto di più: è un intreccio tra la piccola storia e la grande storia, nel quale le vicende personali di Robi e di Bushra, entrambe madri di ragazzi uccisi nel corso del conflitto, e di diversi altri protagonisti, sono collocate nel contesto della Cisgiordania occupata da Israele in seguito all’esito della guerra dei sei giorni del 1967. Sono così via via messe in scena le speranze e le delusioni legate al processo di Oslo; il movimento dei refusnick, soldati israeliani che si rifiutano di prestare servizio nei territori occupati; la realtà delle colonie ebraiche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est; la situazione di Hebron, divisa in due dal 1997 e per il 20% controllata da Israele; i check point e la rete di strade riservate agli israeliani che collegano le colonie tra loro e con le città, chiudendo lo spazio palestinese in enclaves separate come isole in mezzo al mare e immobilizzando la popolazione in quella che Jeff Halper ha chiamato la «matrice di controllo»… Questa politica di separazione rende estranei e ostili gli uni agli altri, favorendo processi di demonizzazione che acutizzano il conflitto anziché favorirne una trasformazione positiva.
Ma questa drammatica situazione, frutto di un conflitto pluridecennale che rischia di diventare «intrattabile», è anche contrassegnata da molteplici sacche di resistenza: non solo palestinesi, ma anche di quelle associazioni israeliane come B’Tselem (per la difesa dei diritti umani), ICAHD (Comitato israeliano contro la demolizione delle abitazioni), guidato dal già citato Jeff Halper, Breaking the silence (Infrangere il silenzio), fondata dall’ebreo ortodosso Yehuda Shaul e composta da ex-soldati israeliani; o Machson Watch, associazione di donne israeliane che denunciano e tentano di contrastare violenze e soprusi contro i civili; o gruppi misti come (oltre a PCFF) Ta’ayush, che cerca di proteggere gli abitanti palestinesi dalle aggressioni dei coloni nelle zone più calde, come Hebron; o i Combattenti per la pace, associazione di ex combattenti delle due parti, fondata nel 2005 dal palestinese Bassam Aramin e dall’israeliano Rami Elhanan (entrambi membri di PCFF per aver perso le figlie nel conflitto); tutte associazioni che hanno scelto la via del dialogo e della ricerca della pace, per citarne solo alcune.
E c’è un edificio a Beit Jala, vicino a Betlemme, l’hotel Everest, che è «l’unico luogo della Cisgiordania in cui israeliani e palestinesi possono incontrarsi senza bisogno di permessi speciali» (p. 55) dal momento che la strada che passa davanti all’hotel si trova in zona C, ed è quindi percorribile dagli israeliani, mentre i palestinesi possono raggiungere la struttura da Beit Jala. È in questo albergo che avviene l’incontro tra Robi e Bushra, nell’ambito di una iniziativa organizzata da PCFF. Un documentario, Two Sided Story, racconta le fasi, le difficoltà, la straordinarietà di questi incontri: il passaggio dalla diffidenza e dalla paura reciproca alla scoperta di condividere lo stesso dolore, alla catarsi, alle lacrime che aprono a nuove relazioni.
Ma come far dialogare l’occupante e l’occupato? Non è facile , e talvolta rischia di essere fittizio, se le due parti si incrociano senza mai incontrarsi davvero, come scrive Abu Nimer: «Accettando di sedersi insieme e di dialogare senza mai sfiorare le questioni spinose, israeliani e palestinesi sono diventati compagni di negazione» (p.77). Solo quando il dialogo riesce ad andare in profondità e a realizzare un confronto di identità che tocca nervi scoperti del conflitto può essere efficace e produttivo, come sostiene Dan-Bar-On. Su questa base si sviluppa il Narrative Project del PCFF: attraverso una serie di incontri e di avvicinamenti progressivi il gruppo misto passa dalla conoscenza interpersonale al dialogo sul conflitto, spesso doloroso, perché «Molti scelgono di raccontarsi come vittime […] Tutti si mettono ad usare argomentazioni culturali, etiche o storiche per squalificare l’altro schieramento. I palestinesi parlano delle violenze dei soldati israeliani e dei coloni nei territori occupati. Gli israeliani ribattono elencando gli attacchi palestinesi contro civili israeliani e via così» […] «i due gruppi lottano per far si che la responsabilità delle sofferenze di tutti ricada sugli oppositori, che ritengono colpevoli di aver innescato il ciclo di violenze» (p.77).
Poi, per convincere l’altro, i partecipanti finiscono quasi sempre per raccontare storie personali legate al conflitto: «La legittimità dell’esperienza personale e il tono di voce addolorato risvegliano la compassione e iniziano a infrangere il muro della negazione. Le voci si fanno più basse e spuntano le lacrime, che si sostituiscono alla cacofonia di fondo. Il fatto di passare dal racconto dei “traumi collettivi preferiti” alle storie personali genera momenti catartici durante i quali i partecipanti cominciano a esprimere gli effetti emotivi della violenza e dell’oppressione e a piangere insieme su ciò che ciascuno ha perso» (p.79). Tali momenti catartici provocano una trasformazione interiore che tocca tutti i partecipanti: «Il processo di guarigione scatta proprio perché queste storie sono condivise con l’Altro. Perché fintanto che si rimane nel proprio ambiente, è facile restare nel dolore, nella rabbia e nell’odio e abituarsi al ruolo di vittima» (p.80).
Questo viaggio alla scoperta dell’altro si accompagna ad un altro viaggio, in direzione di se stessi, per scoprirsi esseri umani, al di là delle convinzioni e delle identità storiche, culturali o religiose. Uscire dall’essere bloccati nel proprio ruolo di vittima, per gli uni e per gli altri, è possibile quando si prende coscienza, attraverso una relazione empatica con l’altro, della relatività del proprio punto di vista.. E ciò consente di rifiutare l’uso politico che viene spesso fatto, da una parte e dall’altra, dei traumi del passato (la Shoah, la Nakba), per giustificare ciò che non può essere giustificato nell’oggi.
Il testo affronta con profondità e finezza molte delle questioni cruciali che quotidianamente emergono dal conflitto israelo-palestinese. Tra queste, merita di essere citata l’accusa di «normalizzazione dell’occupazione» mossa da alcune parti a coloro che cercano di promuovere contatti tra palestinesi ed israeliani. Anche PCFF è stato accusato di ciò. Ma l’approccio con il quale questa associazione agisce non ha nulla a che vedere con l’accettazione della situazione presente, come scrive il blogger palestinese Aziz Abu Sarah:
«Scrivere della vita durante l’occupazione su una rivista online con autori israeliani non significa “normalizzare”. Raccontare alle classi la vita quotidiana delle città palestinesi non vuol dire normalizzare. Come non lo è incontrare degli israeliani in un gruppo di dialogo per discutere dei modi migliori di cambiare lo status quo» (p.123).
Un’altra questione controversa è la campagna BDS (Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni), nata nel 2005 all’interno della società palestinese con l’obiettivo di denunciare e sottrarre consenso alla politica di occupazione e colonizzazione dei territori palestinesi da parte dei governi israeliani. Secondo l’appello di alcuni intellettuali francesi comparso su «Le Monde» dell’1 novembre 2010: «Cedere all’appello di boicottaggio, impedire gli scambi, infliggere ad esempio ai ricercatori israeliani o agli scrittori non si sa quale punizione collettiva significa abbandonare ogni prospettiva di soluzione politica al conflitto e dichiarare che ormai il negoziato non è più possibile» (p.121). Coloro che sostengono il movimento di boicottaggio lo considerano, invece, «una risposta delle società civili all’impotenza della comunità internazionale. E pongono una domanda semplice: Israele si ritirerà dai territori occupati in assenza di pressioni o sanzioni? Certo che no» (p.122).
Ci sarà mai una soluzione a questo conflitto? Come si può affrontare una situazione di stallo, in cui i negoziati sono fermi e l’estensione degli insediamenti israeliani ha raggiunto il numero di circa 500.000 coloni in Cisgiordania e a Gerusalemme Est?
Sari Nusseibeh, intellettuale palestinese, riprende la proposta «2 States, 1 Homeland», basata sull’idea della creazione di due stati, Palestina e Israele, senza frontiere che li separino (p.134).
Proposte analoghe sono state fatte recentemente anche da Jeff Halper e certo non sono soluzioni facili da realizzare. In ogni caso, nessuna soluzione potrà prescindere da un processo di pace e di riconciliazione dal basso che permetta di sanare le ferite e di imparare a conoscersi e a convivere tra due realtà da troppo tempo immobilizzate in un conflitto acuto e lacerante.
Così scrive Robi ai familiari di Thaer, il giovane palestinese che ha ucciso suo figlio David: «Capisco che vostro figlio sia considerato un eroe da molti palestinesi, un combattente per la libertà che lotta per la giustizia e per uno stato palestinese indipendente e vitale, ma penso anche che se capisse che togliere la vita agli altri non può essere una soluzione, se prendesse davvero coscienza delle conseguenze del suo atto, capirebbe che, affinché i nostri due paesi possano un giorno vivere insieme in pace, la sola strada possibile è quella della non violenza. Le nostre vite sono legate così intimamente che ognuno di noi dovrà rinunciare ai suoi sogni per il bene e per il futuro dei figli che sono ancora sotto la nostra responsabilità» (p.88).
Comunque si valuti la situazione, non si può non ascoltare queste voci con rispetto e ammirazione.




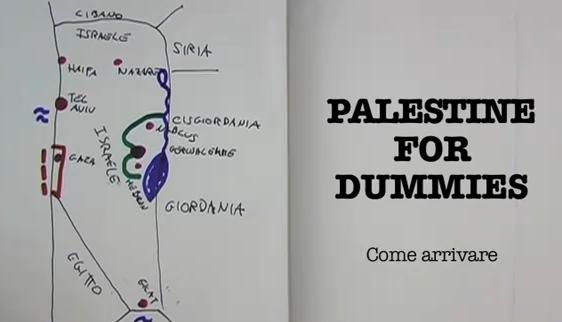























Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!