Chi sono i nuovi jihadisti? | Olivier Roy
Le biografie dei terroristi europei “allevati in casa” mostrano che si tratta di nichilisti violenti che adottano l’islam, piuttosto che fondamentalisti religiosi che si rivolgono alla violenza.
C’è qualcosa di nuovo sulla violenza terroristica del jihad degli ultimi due decenni. Sia il terrorismo che il jihad esistono da molti anni, e forme di terrorismo “globalizzato” – in cui sono presi di mira luoghi altamente simbolici o civili innocenti, senza riguardo alle frontiere nazionali – sono retrodatabili almeno fino al movimento anarchico della fine del 19^ secolo. Quello che è senza precedenti è il modo in cui i terroristi ora perseguono deliberatamente le proprie morti.
Negli ultimi 20 anni – da Khaled Kelkal, leader di un complotto per bombardare i treni di Parigi nel 1995, ai killers di Bataclan del 2015 – quasi tutti i terroristi in Francia si sono fatti esplodere o sono stati uccisi dalla polizia. Mohamed Merah, che ha ucciso un rabbino e i suoi tre figli in una scuola ebraica a Tolosa nel 2012, ha pronunciato una variante di una famosa dichiarazione attribuita a Osama bin Laden e usata abitualmente da altri jihadisti: “Noi amiamo la morte come voi amate la vita”. Adesso, la morte del terrorista non è più solo una possibilità o una conseguenza sfortunata delle sue azioni; è una parte centrale del suo piano. La stessa fascinazione per la morte si ritrova tra i jihadisti che si uniscono allo Stato islamico. Gli attacchi suicidi sono percepiti come l’obiettivo finale del loro impegno.
Questa scelta sistematica della morte è un sviluppo recente. Gli autori di attacchi terroristici in Francia negli anni ’70 e ’80, indipendentemente dal fatto che avessero una qualche connessione con il Medio oriente, pianificavano attentamente le loro fughe. La tradizione musulmana, pur riconoscendo i meriti del martire che muore in combattimento, non stima coloro che colpiscono per perseguire la propria morte, perché questo interferisce con la volontà di Dio. Quindi, perché negli ultimi 20 anni i terroristi hanno scelto di morire? Che cosa ci dice questo sul radicalismo islamico contemporaneo? E che cosa ci dice oggi sulle nostre società?
Quest’ultima domanda è tanto più rilevante in quanto questo atteggiamento verso la morte è inestricabilmente legato al fatto che il jihadismo contemporaneo, almeno in occidente – così come nel Maghreb e in Turchia – è un movimento giovanile non solo costruito indipendentemente dalla religione e dalla cultura dei genitori, ma è anche radicato in una cultura giovanile più ampia. Questo aspetto del jihadismo moderno è fondamentale.
Ovunque si verifichi tale astio generazionale, esso assume anche la forma dell’iconoclastia culturale. Non vengono distrutti solo gli esseri umani, ma anche le statue, i luoghi di culto e i libri. La memoria viene annullata. “Cominciare una nuova vita” è un obiettivo comune alle guardie rosse di Mao Zedong, ai combattenti Khmer Rossi e all’Isis. Come ha scritto un jihadista britannico in una guida di reclutamento per l’organizzazione: “Quando scenderemo per le strade di Londra, Parigi e Washington … non solo faremo spillare il vostro sangue, ma demoliremo anche le vostre statue, cancelleremo la vostra storia e, cosa per voi molto più dolorosa, convertiremo i vostri figli, i quali poi continueranno a sostenere il nostro nome e malediranno i propri antenati”.
Se è vero che tutte le rivoluzioni assorbono l’energia e lo zelo dei giovani, tuttavia la maggior parte non cerca di distruggere ciò che c’è stato prima. La rivoluzione bolscevica decise di mettere il passato nei musei piuttosto che ridurlo in rovina, e la rivoluzionaria Repubblica islamica dell’Iran non ha mai pensato di far esplodere Persepoli.
Questa dimensione autodistruttiva non ha nulla a che fare con la politica del Medio Oriente. È anche controproducente come strategia. Anche se l’Isis proclama la sua missione per ripristinare il califfato, il suo nichilismo rende impossibile raggiungere una soluzione politica, impegnarsi in qualsiasi forma di negoziazione o cercare di creare una società stabile all’interno di confini riconosciuti.
Il califfato è una fantasia. È il mito di un’entità ideologica che espande costantemente il proprio territorio. La sua impossibilità strategica spiega perché chi si identifica con essa, invece di dedicarsi agli interessi dei musulmani locali, ha scelto di entrare in un patto di morte. Non c’è nessuna prospettiva politica, nessun futuro luminoso, nemmeno un posto per pregare in pace. Ma mentre il concetto del califfato è veramente parte dell’immaginazione religiosa musulmana, lo stesso non può essere detto per il perseguimento della morte.
Inoltre, il terrorismo suicida non è nemmeno efficace dal punto di vista militare. Mentre un certo grado di razionalità può essere trovato in un terrorismo “semplice” – in cui pochi individui determinati infliggono notevoli danni a un nemico molto più potente – è assolutamente assente dagli attacchi suicidi. Il fatto che militanti addestrati siano usati solo una volta non è razionale. Gli attacchi terroristici non mettono in ginocchio le società occidentali – provocano solo una contro-reazione. E questo tipo di terrorismo oggi reclama più vite musulmane che non vite occidentali.
L’associazione sistematica con la morte è una delle chiavi per capire la radicalizzazione di oggi: la dimensione nichilista è centrale. Ciò che seduce e affascina è l’idea della rivolta pura. La violenza non è un mezzo. È una fine in sé.
Questa non è tutta la storia: è perfettamente concepibile che altre forme terroristiche più “razionali” possano presto emergere sulla scena. È anche possibile che questa forma di terrorismo sia solo temporanea.
Le ragioni per l’ascesa dell’Isis sono senza dubbio legate alla politica del Medio Oriente e la sua scomparsa non cambierà gli elementi di base della situazione. L’Isis non ha inventato il terrorismo: prende le mosse da una situazione già esistente. La genialità dell’Isis è il modo in cui offre ai giovani volontari un quadro narrativo in cui possono raggiungere le proprie aspirazioni. È tanto meglio per l’Isis se coloro che decidono volontariamente di morire – i disturbati, i vulnerabili, i ribelli senza una causa – hanno poco a che fare con il movimento, ma sono disposti a dichiarare fedeltà all’Isis in modo che i loro atti suicidi diventino parte di una narrazione globale.
Ecco perché abbiamo bisogno di un nuovo approccio al problema dell’Isis, che cerchi di comprendere la violenza islamica contemporanea insieme ad altre forme di violenza e radicalismo che le sono molto simili – quelle che danno rilievo alla rivolta generazionale, all’auto-distruzione, alla rottura radicale con la società, all’estetica della violenza, al giorno del Giudizio.
Si dimentica troppo spesso che il terrorismo suicida e le organizzazioni come Al-Qaeda e Isis sono nuove nella storia del mondo musulmano e non possono essere spiegate semplicemente dall’aumento del fondamentalismo. Dobbiamo capire che il terrorismo non sorge dalla radicalizzazione dell’Islam, ma dall’islamizzazione del radicalismo.
Lungi dall’assolvere l’Islam, la “islamizzazione del radicalismo” ci costringe a chiederci perché e come i giovani ribelli abbiano trovato nell’Islam il paradigma della loro rivolta totale. Ciò non contraddice il fatto che un Islam fondamentalista si stia sviluppando da oltre 40 anni.
Ci sono state critiche verbali a questo approccio. Uno studioso afferma che ho trascurato le cause politiche della rivolta – in sostanza, l’eredità coloniale, gli interventi militari occidentali contro i popoli del Medio Oriente e l’esclusione sociale degli immigrati e dei loro figli. Dall’altra parte, mi è stato addebitato il fatto di ignorare il legame tra la violenza terroristica e la radicalizzazione religiosa dell’Islam attraverso il salafismo, l’interpretazione ultra-conservatrice della fede. Sono pienamente consapevole di tutte queste dimensioni; sto semplicemente affermando che sono inadeguate per spiegare i fenomeni che stiamo studiando, perché nessun collegamento causale può essere trovato sulla base dei dati empirici che abbiamo a disposizione.
La mia argomentazione è che la radicalizzazione violenta non è la conseguenza di una radicalizzazione religiosa, anche se spesso prende le stesse vie e prende in prestito gli stessi paradigmi. Il fondamentalismo religioso esiste, naturalmente, e pone notevoli problemi sociali, perché respinge valori basati sulla scelta individuale e sulla libertà personale. Ma non porta necessariamente alla violenza politica.
L’obiezione che i radicali siano motivati dalla “sofferenza” vissuta dai musulmani che erano stati colonizzati, o vittime di razzismo o di qualsiasi altra discriminazione, o dei bombardamenti statunitensi, dei droni, dell’Orientalismo e così via, comporterebbe che la rivolta fosse guidata principalmente dalle vittime. Ma il rapporto tra radicali e vittime è più immaginario che reale.
Coloro che eseguono attacchi in Europa non sono abitanti della striscia di Gaza, della Libia o dell’Afghanistan. Non sono necessariamente i più poveri, i più umiliati o i meno integrati. Il fatto che il 25% dei jihadisti siano convertiti dimostra che il legame tra i radicali e la loro “gente” è anch’esso una costruzione in gran parte immaginaria.
I rivoluzionari non provengono mai dalle classi più sofferenti. Nella loro identificazione con il proletariato, con le “masse” e con i colonizzati c’è una scelta basata su qualcosa di diverso dalla loro situazione oggettiva. Ben pochi terroristi o jihadisti rendono pubbliche le proprie storie di vita. Parlano genericamente di ciò che hanno visto delle sofferenze di altri. Non erano palestinesi quelli che hanno colpito al Bataclan.
Fino alla metà degli anni ’90, la maggior parte dei jihadisti internazionali provenivano dal Medio Oriente e avevano combattuto in Afghanistan prima della caduta del regime comunista nel 1992. In seguito, sono tornati nei loro paesi d’origine per partecipare al jihad o hanno abbracciato la causa all’estero. Queste erano le persone che cavalcarono la prima ondata di attacchi “globalizzati” (il primo tentativo al World Trade Center di New York nel 1993, contro le ambasciate statunitensi nell’Africa orientale nel 1998 e contro il cacciatorpediniere americano Cole nel 2000).
Questa prima generazione di jihadisti era guidata da gente come Bin Laden, Ramzi Yousef e Khaled Sheikh Mohammed. Ma dal 1995 in poi, ha cominciato a svilupparsi una nuova progenie – nota in Occidente come “terrorista domestico”.
Chi sono questi nuovi radicali? Conosciamo molti dei loro nomi grazie all’identificazione fatta dalla polizia dei perpetratori di attacchi in Europa e negli Stati Uniti. E un numero ancora maggiore è stato identificato nelle fasi di preparazione di attacchi. Abbiamo anche tutte le informazioni biografiche raccolte dai giornalisti. Non c’è bisogno di intraprendere un faticoso lavoro sul campo per capire le traiettorie terroristiche. Tutti i dati e i profili sono disponibili.
Quando si tratta di capire le loro motivazioni, abbiamo tracce dei loro discorsi: tweet, chat in Google, conversazioni in Skype, messaggi su WhatsApp e Facebook. Chiamano i loro amici e la loro famiglia. Rilasciano dichiarazioni prima di morire e lasciano i testamenti sul video. Insomma, anche se non possiamo essere certi di averli compresi, abbiamo familiarità con loro.
Abbiamo certamente maggiori informazioni sulle vite dei terroristi che operano in Europa rispetto a quelle sui jihadisti che partono per i paesi stranieri e non tornano più. Ma, come ha dimostrato lo studio di Sciences Po sui jihadisti francesi che sono morti in Siria, esistono molte somiglianze tra questi gruppi. Qui mi concentrerò principalmente sui franco-belgi, che forniscono la maggior parte dei quadri dei jihadisti occidentali. Ma anche la Germania, il Regno Unito, la Danimarca e i Paesi Bassi hanno importanti contingenti in prima linea.
Utilizzando queste informazioni ho elaborato un database di circa 100 persone che sono state coinvolte nel terrorismo in Francia o hanno lasciato la Francia o il Belgio per partecipare al jihad globale negli ultimi 20 anni. Esso comprende gli autori di tutti gli attacchi più importanti mirati al territorio francese o belga. Non esiste un profilo terroristico standard, ma ci sono caratteristiche ricorrenti. La prima conclusione che si può trarre è che i profili non sono molto cambiati negli ultimi 20 anni. Khalal Kelkal, il primo terrorista “allevato in casa” in Francia e i fratelli Kouachi (Charlie Hebdo, Paris, 2015) condividono una serie di caratteristiche comuni: seconda generazione; abbastanza ben integrati in un primo momento; un periodo di criminalità minore; radicalizzazione in carcere; attacco e morte – armi in mano – in uno scontro con la polizia.
Un’altra caratteristica che tutti i paesi occidentali hanno in comune è che i radicali sono quasi tutti i musulmani “nati di nuovo”, che dopo aver vissuto una vita altamente secolarizzata – la frequentazione di club, le bevande alcoliche, il coinvolgimento in piccoli crimini – improvvisamente rinnovano la loro osservanza religiosa, individualmente o nel contesto di un piccolo gruppo. I fratelli Abdeslam frequentavano un bar di Bruxelles e andavano nei locali notturni nei mesi precedenti l’attacco al Bataclan. La maggior parte entra in azione nei mesi successivi alla “riconversione” o “conversione” religiosa, ma di solito hanno già mostrato segni di radicalizzazione.
Quasi in quasi ogni caso, i processi con cui si forma un gruppo radicale sono pressoché identici. L’appartenenza del gruppo è sempre la stessa: fratelli, amici di infanzia, conoscenze fatte in prigione, talvolta in un campo di addestramento. È anche degno di nota la presenza di molti fratelli.
Questa sovra-rappresentanza di fratelli non si verifica in nessun altro contesto di radicalizzazione, sia nei gruppi estremisti che nei gruppi islamici. Essa sottolinea il significato della dimensione generazionale della radicalizzazione.
Come ha scritto l’ex jihadista David Vallat, la retorica radicale dei predicatori potrebbe essere sintetizzata così: “L’Islam di tuo padre è ciò che i colonizzatori hanno lasciato dietro di loro: l’Islam di coloro che si inchinano e obbediscono. Il nostro Islam è l’Islam dei combattenti, del sangue, della resistenza “.
I radicalizzati sono infatti spesso orfani – come i fratelli Kouachi – o provengono da famiglie che non funzionano. Non sono necessariamente ribelli contro i propri genitori, ma contro ciò che essi rappresentano: umiliazioni, concessioni fatte alla società e ciò che essi considerano come loro ignoranza religiosa.
La maggior parte dei nuovi radicali sono profondamente immersi nella cultura giovanile: vanno in discoteca, agganciano ragazze, fumano e bevono. Quasi il 50% dei jihadisti in Francia, secondo la mia banca dati, ha una storia di modesti crimini – soprattutto di droga, ma anche atti di violenza e, meno frequentemente, rapine armate. Cifre simili si raccolgono in Germania e negli Stati Uniti – tra cui un numero sorprendente di arresti per guida in stato di ebbrezza. Anche le loro abitudini rispetto al modo di vestire sono conformi a quelle della gioventù odierna: marchi, berretti da baseball, cappucci, in altre parole abbigliamento di strada, e nemmeno della foggia islamica.
Anche i loro gusti musicali sono quelli dei tempi: amano la musica rap e andare nei club. Una delle figure radicalizzate più note è un rapper tedesco, Denis Cuspert – noto prima come Deso Dogg, poi come Abu Talha al-Almani – che è andato a combattere in Siria. Naturalmente, sono anche appassionati di sport ed esperti di film violenti americani.
Le loro tendenze violente possono avere esiti diversi da jihad e terrorismo – come si può vedere nelle guerre fra gang di Marsiglia. Esse possono anche essere canalizzate, sia dalle istituzioni – Mohammed Merah voleva entrare nell’esercito – sia attraverso lo sport. Un gruppo di convertiti portoghesi, la maggior parte dei quali originari dell’Angola, ha lasciato Londra per aderire all’Isis dopo avere aderito ad un club di box tailandese avviato da una ONG britannica. Le associazioni di combattimento sportivo sono più importanti delle moschee nella vita sociale del jihadista.
La lingua parlata dai radicali è sempre quella del loro paese di residenza. In Francia, quando si riconvertono spesso passano ad una versione salafizzata del gergo parlato nella banlieue francese.
I periodi di detenzione li mettono in contatto con coetanei radicalizzati e lontani da qualsiasi religione istituzionalizzata. La prigione amplifica molti dei fattori che alimentano la radicalizzazione contemporanea: la dimensione generazionale; la rivolta contro il sistema; la diffusione di un salafismo semplificato; la formazione di un gruppo compatto; la ricerca della dignità legata al rispetto della norma; e la reinterpretazione del crimine come protesta politica legittima.
Un’altra caratteristica comune è la distanza dei radicali dalla loro cerchia più immediata. Non hanno vissuto in un ambiente particolarmente religioso. Il loro rapporto con la moschea locale è stato ambivalente: o hanno partecipato episodicamente o sono stati espulsi per aver mostrato mancanza di rispetto per l’imam locale. Nessuno di loro è appartenuto alla Fratellanza musulmana, nessuno di loro ha lavorato con una associazione caritativa musulmana, nessuno di loro ha partecipato ad attività di proselitismo, nessuno di loro è stato membro di un movimento di solidarietà palestinese e infine nessuno di loro, a mia conoscenza, ha partecipato alla rivolta nei sobborghi francesi nel 2005. Non sono stati previamente radicalizzati da un movimento religioso prima di volgersi verso il terrorismo.
Se c’è stata veramente una radicalizzazione religiosa, non si verificata nel quadro delle moschee salafite, ma individualmente o all’interno del gruppo. Le uniche eccezioni sono in Gran Bretagna, che ha una rete di mosche militanti frequentate da membri di al-Muhajiroun, che hanno dato origine ad un gruppo ancora più radicale, Sharia4UK, guidato da Anjem Choudary. Quindi, la domanda è: quando e dove i jihadisti abbracciano la religione? Il fervore religioso sorge al di fuori delle strutture della comunità, tardivamente, piuttosto all’improvviso e poco prima che i terroristi si muovano all’azione.
Riassumendo: il radicale tipico è un giovane immigrato o convertito di seconda generazione, molto spesso coinvolto in episodi di criminalità minore, praticamente senza istruzione religiosa, ma con un tragitto rapido e recente di conversione / riconversione, più spesso nel contesto di un gruppo di amici o su internet piuttosto che nell’ambito di una moschea. L’abbraccio della religione è raramente tenuto segreto, anzi viene esposto, ma non corrisponde necessariamente all’immersione nella pratica religiosa. La retorica della rottura è violenta: il nemico è il kafir, quello con cui non è possibile alcun compromesso, ma comprende anche la propria famiglia, i cui membri sono accusati di osservare l’Islam in modo inadeguato o di rifiutare la conversione.
Al tempo stesso, è ovvio che la decisione dei radicali di identificarsi con il jihad e di rivendicare l’affiliazione con un gruppo islamico radicale non è solo una scelta opportunistica: il riferimento all’Islam fa tutta la differenza tra il jihad e le altre forme di violenza verso cui i giovani propendono. Il fatto di evidenziare questa cultura diffusa della violenza non significa “esonerare” l’Islam. Il fatto che questi giovani scelgano l’Islam come quadro di riferimento per pensiero ed azione è fondamentale, ed è proprio l’islamizzazione del radicalismo che dobbiamo sforzarci di comprendere.
Oltre alle caratteristiche comuni di cui sopra, non esiste un profilo sociale ed economico tipico dei radicali. C’è una spiegazione popolare e molto semplicistica che considera il terrorismo come conseguenza di un’integrazione non riuscita – e quindi come annunziatore di una guerra civile che sta per venire – senza tenere minimamente conto delle masse di musulmani che sono ben integrati e socialmente in ascesa. È un fatto incontestabile, per esempio, che in Francia molti più musulmani sono arruolati in polizia e nelle forze di sicurezza di quanti sono coinvolti nel jihad.
Inoltre, i radicali non provengono da comunità di tipo intransigente. Il bar di Bruxelles, frequentato dai fratelli Abdeslam, è situato in un quartiere che è stato descritto come “salafizzato” – che sarebbe pertanto off-limits per persone che bevono liquori e donne che non indossano il hijab. Ma questo esempio dimostra che la realtà di questi quartieri è più complessa di quanto siamo indotti a credere.
È molto comune considerare il jihadismo come estensione del salafismo. Non tutti i salafiti sono jihadisti, ma si presume che tutti i jihadisti siano Salafiti, e quindi che il salafismo sia la porta del jihadismo. In breve, la radicalizzazione religiosa è considerata la prima tappa della radicalizzazione politica. Ma le cose sono più complicate di così, come si è visto.
È chiaro, tuttavia, che questi giovani radicalizzati sono credenti sinceri: credono veramente che andranno in paradiso e il loro quadro di riferimento è profondamente islamico. Si affiliano ad organizzazioni che vogliono istituire un sistema islamico, o anche, nel caso dell’Isis, ricostituire il califfato. Ma di quale forma di Islam stiamo parlando?
Come si è visto, i jihadisti non arrivano alla violenza dopo aver attentamente esaminato i testi sacri. Essi non hanno la necessaria cultura religiosa – e, soprattutto, non importa loro di averne una. Non diventano radicali perché hanno interpretato i testi in modo errato o perché sono stati manipolati. Sono radicali perché scelgono di esserlo, perché solo il radicalismo li attrae. A prescindere dal database cui si faccia riferimento, il dato che spicca è la scarsa conoscenza religiosa tra i jihadisti. Secondo alcuni dati trapelati dalle fonti di Isis, che contengono particolari di oltre 4.000 reclute straniere, mentre la maggior parte dei combattenti sono ben educati, il 70% afferma di avere dell’Islam una conoscenza solo di base.
È importante distinguere qui tra la versione dell’Islam esposta dall’Isis stesso – che è molto più fondata sulla tradizione metodologica dell’esegesi delle parole del profeta Muhammad ed evidentemente fondata sull’opera di “studiosi” – e l’Islam dei jihadisti che dichiarano fedeltà all’Isis, che ruota anzitutto attorno a una visione dei nostri giorni di eroismo e violenza.
Le esegesi scritturistiche che riempiono le pagine di Dabiq e Dar al-Islam, le due recenti riviste di Isis scritte in inglese e francese, non sono la causa della radicalizzazione. Esse contribuiscono a fornire una razionalità teologica alla violenza dei radicali – basata non su una conoscenza reale, ma un richiamo all’autorità. Quando i giovani jihadisti parlano di “verità”, non si riferiscono mai ad una conoscenza raziocinante. Si riferiscono alla propria certezza, talvolta sostenuta da un riferimento fascinatore agli sceicchi, che però essi non hanno mai letto. Ad esempio Cédric, un francese convertito, ha affermato al suo processo: “Non sono una jihadista da tastiera, non mi sono convertito su YouTube. Ho letto gli studiosi, quelli veri.” Ma ha detto questo nonostante non sia in grado di leggere l’arabo e incontri su Internet i membri della sua rete.
Probabilmente conviene ascoltare ciò che dicono i terroristi. Per tutti loro si ripetono gli stessi temi, che si possono riassumere nella dichiarazione postuma di Mohammad Siddique Khan, leader del gruppo che ha eseguito l’attentato di Londra il 7 luglio 2005.
La prima motivazione che ha citato sono le atrocità commesse dai paesi occidentali contro il “popolo musulmano” (nella trascrizione egli dice, “il mio popolo in tutto il mondo”); la seconda è il ruolo dell’eroe vendicatore (“sono direttamente responsabile della protezione e della vendetta dei miei fratelli e sorelle musulmani”, “ora anche voi assaporerete la realtà di questa situazione”); la terza è la morte (“amiamo la morte tanto quanto voi amate la vita”), e la sua accoglienza in cielo (“Allah … mi innalzi tra quelli che amo come i profeti, i messaggeri, i martiri”).
La comunità musulmana, che tali terroristi sono ansiosi di vendicare, quasi mai è specificata. È una realtà non storica e non spaziale. Quando si scaglino contro la politica occidentale in Medio Oriente, i jihadisti usano il termine “crociati”; non si riferiscono alla colonizzazione francese dell’Algeria.
I radicali non si riferiscono mai esplicitamente al periodo coloniale. Essi rifiutano o ignorano tutti i movimenti politici e religiosi che sono venuti prima di loro. Non si allineano alle lotte dei loro padri; quasi nessuno di loro torna ai paesi di origine dei loro genitori per impegnarsi nel jihad. È degno di nota che nessuno dei jihadisti, sia nato musulmano sia convertito, abbia preso parte, a mia conoscenza, ad iniziative a fianco di un movimento pro-palestinese o sia appartenuto ad un qualche tipo di associazione per combattere l’islamofobia o anche ad una ONG islamica. Questi giovani radicali leggono testi in francese o in inglese che circolano su internet, ma non opere scritte in arabo.
Stranamente, i difensori dello Stato islamico non parlano mai della sharia e quasi mai della società islamica che sarà costruita sotto gli auspici dell’Isis. Coloro che dicono di essere andati in Siria perché volevano “vivere in una vera società islamica” sono tipicamente dei rimpatriati che negano di aver partecipato alla violenza mentre erano là – come se la volontà di impegnarsi nel jihad e il desiderio di vivere secondo la legge islamica fossero incompatibili. Ed in un certo senso questo è vero, perché ai jihadisti non interessa vivere in una società islamica: non vanno in Medio Oriente per vivere, ma per morire. Questo è il paradosso: questi giovani radicali non sono utopici, sono nichilisti.
Ciò che è più radicale nei nuovi radicali rispetto alle precedenti generazioni di rivoluzionari, islamisti e salafisti, è il loro odio per le società esistenti, sia occidentali che islamiche. Questo odio è incarnato nel perseguimento della propria morte quando commettono omicidi di massa. Essi uccidono se stessi insieme al mondo che rifiutano. Dall’11 settembre 2001, questo è il modus operandi preferito dai radicali.
L’assassino di massa che è anche suicida è purtroppo una figura contemporanea comune. L’esempio tipico è l’americano che colpisce in una scuola, che entra in essa pesantemente armato, uccide indiscriminatamente il maggior numero possibile di persone, poi si uccide o si lascia uccidere dalla polizia. Egli ha già postato online fotografie, video e dichiarazioni. In esse egli ha assunto posizioni eroiche ed è felicissimo del fatto che adesso tutti sapranno chi egli era veramente. Negli Stati Uniti ci sono stati 50 attacchi o tentativi di attacchi di questo tipo tra il 1999 e il 2016.
I confini tra un killer di massa di questo tipo che si suicida e un militante del califfato sono comprensibilmente nebulosi. Il killer di Nizza, per esempio, era stato descritto inizialmente come malato mentale e solo più tardi come un militante dell’Isis il cui crimine era stato premeditato. Ma queste idee non si escludono reciprocamente.
Il punto qui non è quello di mescolare insieme tutte queste categorie. Ognuna è specifica, ma c’è un filo conduttore che attraversa gli omicidi di massa perpetrati da giovani scontenti, nichilisti e suicidi. Ciò che organizzazioni come Al-Qaida e Isis provvedono a produrre è uno scritto.
La forza dell’Isis è di giocare sulle nostre paure. E la paura principale è la paura dell’Islam. L’unico impatto strategico degli attacchi è il loro effetto psicologico. Non incidono sulle capacità militari dell’Occidente; anzi le rafforzano, ponendo fine ai tagli delle spese militari. Essi hanno un effetto economico marginale e compromettono le nostre istituzioni democratiche solo nella misura in cui noi stessi li facciamo rientrare nel dibattito eterno sul conflitto tra sicurezza e stato di diritto. Il timore è che le nostre società possano implodere e possa esserci una guerra civile tra i musulmani e gli “altri”.
Noi ci domandiamo che cosa voglia l’Islam, che cosa sia l’Islam, senza che ci rendiamo finalmente conto che questo mondo dell’Islam non esiste; che l’ummah è, nel migliore dei casi, un pio desiderio pio e nel peggiore un’illusione; che i conflitti sono prima e soprattutto tra i musulmani stessi; che la chiave di questi conflitti è innanzitutto politica; che le questioni nazionali rimangono la chiave per il Medio Oriente e le questioni sociali sono la chiave dell’integrazione.
Sicuramente l’Isis, come al-Qaida, ha modellato un grandioso sistema immaginario in cui dipinge se stesso come conquistatore e vincitore dell’Occidente. È un’enorme fantasia, come tutte le ideologie millenariste. Ma, a differenza delle principali ideologie secolari del XX secolo, il jihadismo ha una base sociale e politica molto ristretta. Come abbiamo visto, non mobilita le masse e attrae solo coloro che si trovano ai margini.
C’è la tentazione di vedere nell’Islam un’ideologia radicale che mobilita moltitudini di persone nel mondo musulmano, proprio come il nazismo fu in grado di mobilitare grandi porzioni della popolazione tedesca. Ma la realtà è che la pretesa dell’Isis di stabilire un califfato globale è un’illusione – ed è per questo che attira giovani violenti con deliri di grandezza.
Olivier Roy – 13 aprile 2017 – The Guardian
(Estratto di Jihad e morte: attrattiva globale dello stato islamico di Olivier Roy, pubbl.to da Hurst)
(traduzione: P. P. Bastia)
(originale inglese in http://www.theguardian.com/news/2017/apr/13/who-are-the-new-jihadis, estratto da “Jihad and death: the global appeal of Islamic State”, Hurst, London 2017)








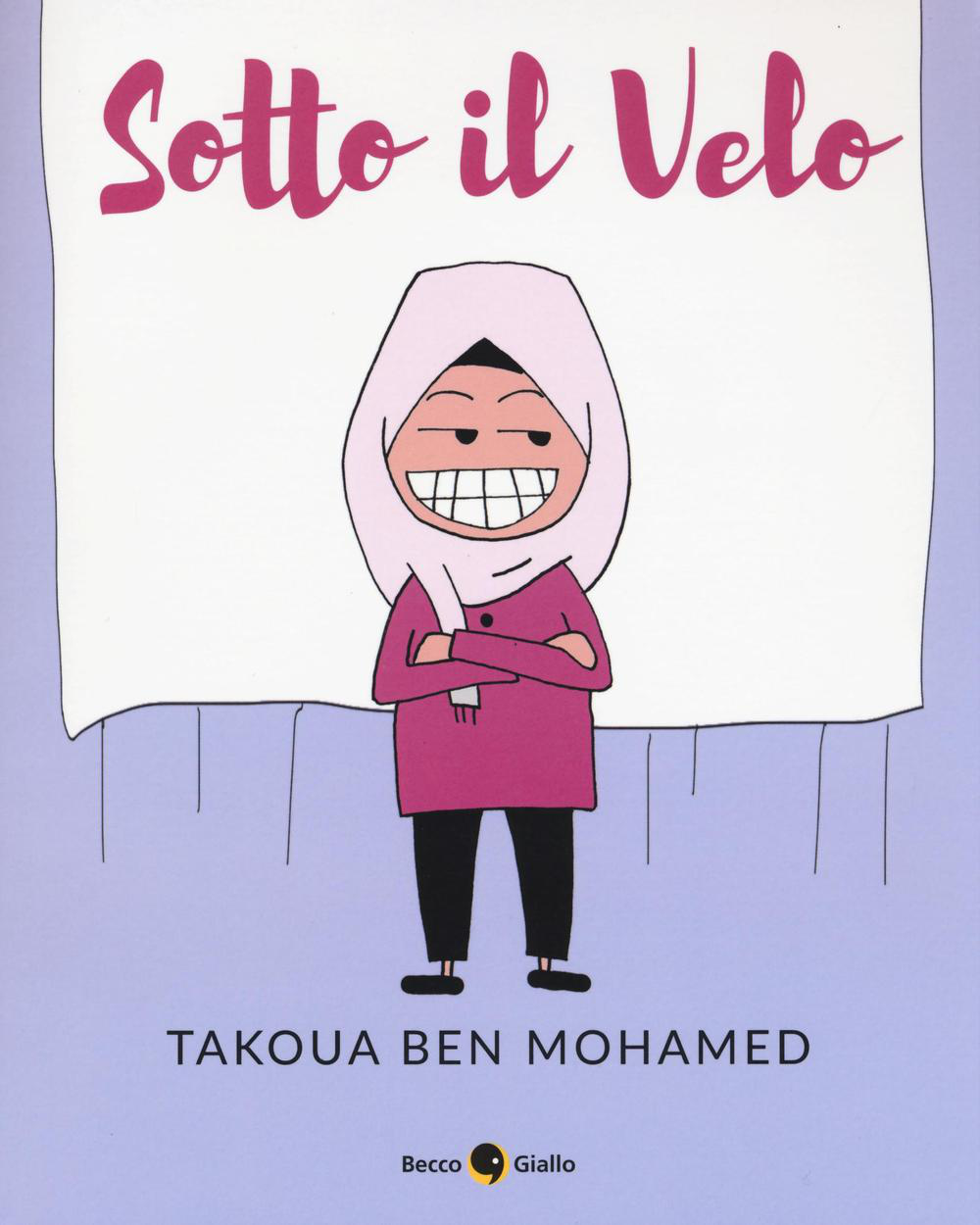




















Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!