Bozza d’autobiografia: Battendosi per le cause perse – Richard Falk
Per caso leggevo il poema di Cesar Vallejo, “Piedra negra sobre una piedra blanca”, nella traduzione di Geoffrey Brock, e mi colpì la strofa d’apertura:
Morirò a Parigi mentre fuori diluvia
un giorno del quale possiedo già il ricordo.
Morirò a Parigi – e non mi confondo
forse un giovedì, come oggi, d’autunno.
Senza essere letterale, mi sono ricordato che ho potuto valutare la mia morte in vita, e non lasciare una resa dei conti finale a qualche evento in solenne memoria in cui gli oratori si trovano sfidati a trovare aneddoti divertenti per alleggerire l’occasione, altrimenti pronunciano banalità onorifiche piuttosto estranee al nucleo di esperienze del mio essere.
E’ da un po ultimamente che penso alle cause perse. Ho recentemente tenuto, una lezione alla Columbia University su questo tema, ispirato al saggio postumo di Edward Said: “On Lost Causes” (Sulle cause perse-1997) nel quale lega insieme la ‘nobilità del fallimento’ come descritta in letteratura con la propria irremovibile dedizione agli sforzi Palestinesi per una pace giusta.
In quell’occasione, sono stato anche incentivato dall’approccio adottato -anche se perverso in qualche modo- su questo tema da Slavoj Žižek (In difesa delle cause perse, 2009), in particolare la sua insistenza sul fatto che il meglio che noi umani possiamo sperare è di scegliere il giusto tipo di fallimento, e non scoraggiarsi dalla apparente sconfitta o le distorsioni nell’ottenimento di obiettivi meritevoli.
La sua parafrasi delle elettrizzanti linee guida di Samuel Beckett sembra rilevante ai miei sogni utopici di un mondo giusto: “. ..dopo che uno fallisce, si può andare avanti e riuscire a fallire meglio, mentre l’indifferenza ci affoga sempre più in fondo alla palude dell’Essere imbecille” (p.7)
Infine, il noto scenario di Camus su Sisifo “felice” raggiunge una conclusione diversa, cioè che l’accettazione di inutilità è una sorta di illuminazione sulla natura della lotta incessante della vita per trovare un senso di redenzione che può solo finire in frustrazione. Le ultime parole del Mito di Sisifo (1942) ci dicono qualcosa al riguardo di come l’interpretazione di Camus ‘che una vita ben vissuta non è niente di più o di meno di un processo che continua, scandito dal ritmo della sconfitta: “Bisogna immaginare Sisifo felice”. Sia che una vita abbia, o dovrebbe avere un significato oltre al puramente comportamentale di continuità e persistenza, sembra essere una questione personale per Camus, ma non per me nè per la maggior parte delle religioni.
Camus sembra fare richiami meno ambiziosi di entrambi, Said e Žižek i quali parlano non soltanto di futilità come l’indole generica dell’esperienza umana, ma circa l’impegno nella ricerca di ciò che può essere chiamato il bene pubblico spirituale, un viaggio o pellegrinaggio finalizzato che immagina come possibile una giusta pace in terra. Questa premessa mi ha portato a proporre un’identità politica che io chiamo ‘il cittadino pellegrino’, la ricerca di un’obiettivo desiderato che definisca la nostra esperienza di vita pubblica come partecipante attivo nel ‘non ancora’ di un futuro sconosciuto. Naturalmente, la sete di immortalità o la vita dopo la morte è la fondamentale causa persa.
Anche se stimolato da questo tipo di riflessioni sulla condizione umana, non ho alcuna pretesa di situare me stesso su tali grandi piedistalli di celebrità. E ‘piuttosto un esercizio in auto-percezione dal punto di vista di una vita intera, che non può essere definitivamente compresa se non dopo la morte: una sorta di abbraccio dell’impossibile. Proprio perché non ancora morti, ci saranno forse momenti di ridefinizione che richiederebbero una nuova valutazione. In questo contesto, rimaniamo intrinsecamente misteriosi a noi stessi così come agli altri. Eppure se aspettiamo che il dramma della vita abbia fine abbiamo chiaramente aspettato troppo a lungo. La nostra unica impossibile possibilità è contemplare la nostra morte, come se fosse già successa, un libro di memorie futuristico, e anche se scritto in età avanzata, è solo frivolamente futuristico in quanto la maggior parte di ciò che muove il cuore e l’anima è già avvenuto o, se siete fortunati come nel mio caso, sta accadendo.
Se cerco di catturare una qualsiasi essenza provvisoria in relazione alla vita pubblica, vengo colpito dalla previa banale attrazione verso le cause perse. Potrei dire, con un po’ di autocritica, che soltanto le cause perse mi hanno mai interessato ed attratto profondamente.
Da bambino a New York City, ho scelto senza pensarci troppo di essere tifoso dei Brooklyn Dodgers (prima che diventassero una storia di successo, e molto prima che portassero il loro spettacolo verso i lidi lussureggianti di Hollywood) e ripudiato i New York Yankees, vincitori perpetui e anche piuttosto i noiosi New York Giants, geograficamente più immediati visto che vivevo a Manhattan. Eppure, anche da vacillante e imbroncciato adolescente, nè i gessati né il golf hanno mai avuto alcun fascino per me. Allo stesso tempo ho imparato dalle disgrazie di mio padre. Dopo avere divorziato da mia madre è corso dietro a irraggiungibili star del cinema e altre celebrità guadagnando calde amicizie ma mai ottenendo l’intimità duratura che cercava. Essere stato testimone delle sue delusioni nella mia infanzia, mi ha aiutato a evitare nella vita privata delle cause perse, anche se non completamente.
Successivamente, quando una sorta di maturità differita è arrivata, ho finalmente cominciato a pensare, sentire e agire politicamente. In primo luogo, ho dovuto scrollarmi di dosso l’influenza della confusa miscela di natura amorosa e politica conservatrice di mio padre: empatia e tenerezza a casa combinati con un amore astratto per Paese e Stato che sosteneva il militarismo e la belligeranza a livello internazionale e la crudeltà e la politica reazionaria a livello nazionale, per la verità un ethos dei vincitori accompagnato da un tocco di razzismo e di patriarcato, persino d’omofobia, ma fortunatamente smentiti da una accettazione senza giudizi degli altri nella concreta circostanza. Poi il liberalismo della Guerra Fredda è entrato nella mia vita. E ‘stato’ il pensiero di gruppo ‘della vita accademica durante i miei anni maturi nei ’50 e i ’60, e credendo nella superiorità morale del nostro lato capitalista e individualista mentre favorivo anche un ordine mondiale più cooperativo premesso che gli Stati Uniti facessero ciò che dovevano per ottenere i propri vantaggi di ricchezza e potere. Aallo stesso tempo che mi rendevo conto dei limiti e le carenze della mentalità liberale, non mi sono mai sentito a mio agio con delle alternative radicali, soprattutto se definite istituzionalmente e ideologicamente. Da qui, la solitudine politica.
Il mio primo incontro politico con una causa persa è stato il Vietnam. Mi sono opposto alla guerra in via prudenziale che derivava dal tipo di realismo del consenso che era il pensiero base che prevaleva tra le facoltà universitarie, in particolare nei campus d’elite. In seguito, per via degli amici e per paura di sembrare impaurito, sono andato in Vietnam del Nord, e ho visto la guerra in modo diverso, cioè, dal punto di vista delle vittime e della relativa purezza di una società contadina. Ho visto il mio paese, gli Stati Uniti, come il principale bullo globale, uccidendo e devastando a distanza, lontano dalla propria società (anche se sottoponendo i giovani combattenti americani volontari e involontari a servire in una guerra immorale e strategicamente sconcertante). Eppure sotto questa prospettiva mutata, rimasi abbastanza un fanatico realista presupponendo che il lato col maggior potere assoluto avrebbe vinto, il che alla fine in effetti mi ha fatto, tristemente, difendere una causa persa. (Ricordo da parte di Lyndon Johnson la sua arrogante archiviazione del Vietnam del Nord come ‘una potenza asiatica di quarta categoria’, non del tutto impreciso però secondo le metriche di battaglia). Ero impassibile nel dichiarare il mio impegno verso l’autodeterminazione vietnamita, ma mi aspettavo che alla fine la sofferenza e la distruzione sarebbero diventate troppo da sopportare per i vietnamiti, e si sarebbero sottomessi alla volontà di Washington. Invece, ho trascurato il lato storicamente positivo dell’impazienza americana, la mancanza di volontà di mantenere l’ottusa rota, e così è risultato essere l’America che non era disposta a sopportare ulteriori sofferenze e perdite, anche se statisticamente stava perdendo molto meno dei vietnamiti. Il vantaggio vietnamita è stato la loro perseveranza e un riconoscere che ciò che era in gioco per loro era quasi un assoluto rispetto agli Stati Uniti, per i quali è stata sempre una questione di calcolo del saldo tra guadagni e perdite.
Quando i vietnamiti hanno finalmente ottenuto la vittoria, mi ha fatto piacere il risultato della guerra, e anche se per breve tempo, ho creduto che le ondate della radicale marea anti-colonialista in tutto il mondo, stavano per ridisegnare il futuro in modo auspicabile. Allo stesso tempo, con un impegno meno attivo ero preso nella lotta all’apartheid, avendo visitato il Sudafrica nel 1968 come osservatore ufficiale a un importante processo politico alle figure di spicco della resistenza di ciò che allora era un paese de facto colonizzato, chiamato, al tempo, Sudafrica Occidentale, ribattezzato poi Namibia dopo l’indipendenza. Avevo precedentemente lavorato presso la Corte internazionale di giustizia dell’Aia per quasi un anno per conto di Etiopia e Liberia, in un caso che è stato presentato per stabilire che il ruolo amministrativo di Sudafrica in Sudafrica Occidentale era incompatibile con l’estensione dell’apartheid. Le pretese razziste del Sud Africa sono stati sorprendentemente sostenute dalla decisione del tribunale, e questo mi ha convinto che non ci si poteva fidare ne della legge ne degli avvocati, e che non ci si sarebbe liberati dall’apartheid senza i tormenti di una lunga e sanguinosa lotta. Non mi è mai venuto in mente e nemmeno a quelli con i quali discutevo di questi problemi che in Sudafrica potesse emergere un percorso relativamente pacifico verso una democrazia maggioritaria e un costituzionalismo multi-razziale. Come con il Vietnam, il risultato relativamente benigno sembrava una specie di miracolo politico, e come tale, non scosse la mia convinzione che ero irrimediabilmente destinato a essere permanente campione delle cause perse. Eppure mi ha fatto capire anche che risultati vittoriosi possano in qualche modo controllare l’esito nelle cause perse. A questo proposito, la “perdita” delle cause perse è sempre in dubbio, non razionalmente tanto quanto esistenzialmente, e ciò fa la differenza tra psicologia e storia. Questo giustifica dedicare energie per cause giuste, sia che sembrino perse oppure no.
In anni recenti il mio impegno pubblico è stato indirizzato verso la causa dei diritti dei palestinesi a pace e giustizia sotto la legge internazionale. Questa lotta sta sempre di più somigliando ad una classica causa persa, data la disparità di potere, l’impossesarsi di terra da parte degli israeliani e l’ambizione Zionista rappresentata nell’attuale leadership israeliana di controllare tutta o la maggior parte della Palestina storica. Eppure, un breve esame dei risultati dei conflitti internazionali dalla fine della seconda guerra mondiale suggerisce che il lato che generalmente vince alla fine, è quello che controlla ciò che è legge, moralità e destino storico e non il lato che domina il campo di battaglia o è più abile nel spiegare strumenti di violenza.
Come in Vietnam, dal punto di vista della ‘guerra’ l’incontro israelo-palestinese ha tutti i brutti elementi di unilateralità. I violenti scontri sono più accuratamente considerati “massacri, ” spettacoli horror,” o “atrocità” che atti di guerra. Dal mio postumo punto di vista, io non vacillerò nel sostegno alla lotta palestinese, ma mi manca la capacità vera di rappresentare uno scenario plausibile alla vittoria, quindi si tratta di un ingaggio in una causa persa insieme alla premessa che non possiamo mai essere sicuri.
Recentemente, dopo un mio intervento sulla Palestina a Dunedin, Nuova Zelanda una persona tra il pubblico ha posto una domanda provocatoria: “non bisognerebbe distinguere tra ‘una causa davvero perso’ e ‘una causa persa’. All’epoca ero d’accordo che una tale distinzione sarebbe utile considerando che la speranza è un elemento essenziale per l’impegno politico nella maggior parte delle persone, e che dare uno scopo allo smarrimento sarebbe annientare la speranza. Eppure dopo mi son chiesto se ho concesso il punto in modo sconsiderato, rendendolo pari a l’ammissione -da nostalgia cechoviana- che le cause veramente perse vanno denigrate e probabilmente abbandonate.
Ho pensato ai drammi di Pirandello che celebrano la fantasia a scapito della realtà (ad esempio ‘Così è (se vi pare)’-1917), e ho ricordato i miei amici grintosi dedicati alla legittimazione delle popolazioni indigene, come nel Movimento di sovranità hawaiano. Tale impegno sembra chiaramente qualificarsi come una causa veramente persa, e tuttavia, l’espressione stessa di questa visione è di per sé un bene intrinseco, nobilitante e liberatorio nel proprio senso Pirandelliano, e umanamente preferibile alla negazione di ingiustizia, come nella celebrazione acritica del Columbus Day o del Giorno del Ringraziamento. Le vittorie dell’immaginazione morale e spirituale possono essere più preziose e liberatorie nella nostra vita, anche se la loro incarnazione politica sembra per sempre irricuperabile.
Per gran parte della mia vita professionale mi son dedicato alla causa persa dell’eliminazione delle armi nucleari. A volte, questa causa persa è sembrata non fosse persa, altre volte sembra davvero persa. Dal momento che non siamo in grado di conoscere il futuro, le nostre valutazioni presenti sono inevitabilmente provvisorie, e rimane un imperativo morale per me restare impegnato nella lotta per la loro eliminazione.
Questo dialogo interno continua. Edward Said rende chiaro che quando si cambia marcia dalla cultura alla politica, è importante agire in modo responsabile nelle impostazioni di una lotta reale in cui delle vite sono in gioco e la sofferenza è reale. Indicava di pensare alla sua identificazione con la lotta palestinese, radicalmente diversa per questo motivo nella sua mente dal profondo apprezzamento per l’ethos che ha guidato Cervantes nel costruire la sua grande visione della causa persa della galanteria medievale. Mi sento allo stesso modo, anche se meno incentrato, abbracciando l’anti-nucleare al tempo stesso che affermo la solidarietà con la lotta palestinese.
Verso la fine della poesia di Vallejo queste righe completano quest’arco di pensiero:
Mi vedo, come mai prima, solo
César Vallejo è morto.
Tutti lo colpirono, anche se non faceva loro il minimo danno
Mi identifico con una tale immagine di sé, ma solo politicamente, non personalmente dove sono il soddisfatto destinatario di varie forme d’amorevole sostegno. E io non sono ancora coraggioso abbastanza da dire (e intendere) ‘Richard Falk è morto’. Tuttavia, contemplare la morte senza gli analgesici metafisici di un aldilà immaginario, significa essere finalmente soli. In un certo senso imparare a morire equivale a imparare a vivere da solo, e richiede coraggio e forza d’animo.
27 Novembre 2014
Traduzione di Marlene Barmann per il Centro Studi Sereno Regis
Titolo originale: Memoir Sketch: Championing Lost Causes
http://richardfalk.wordpress.com/2014/11/27/memoir-sketch-championing-lost-causes/

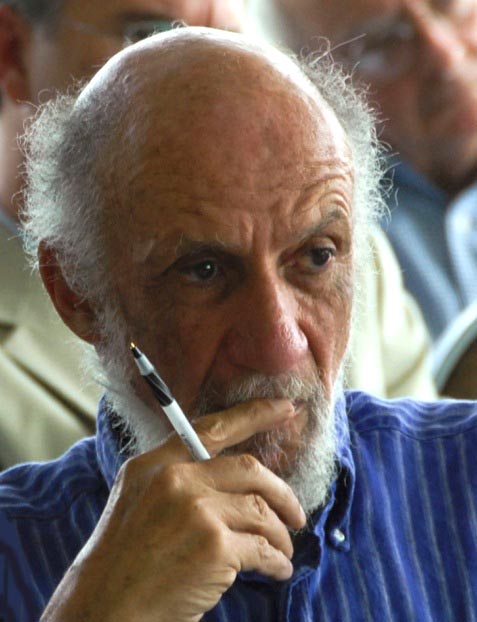

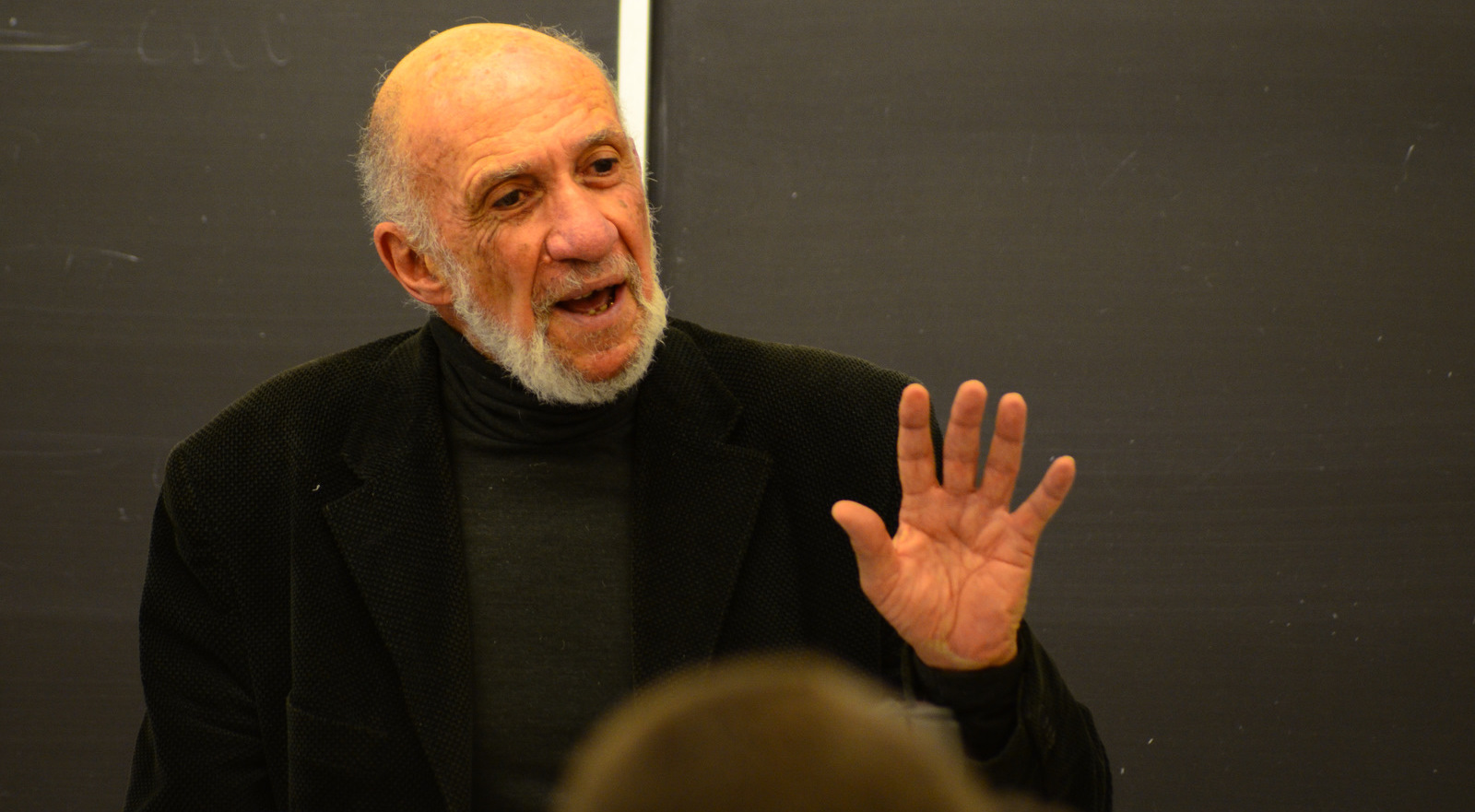




















Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!