La grammatica dei conflitti
Daniele Novara, La grammatica dei conflitti. L’arte maieutica di trasformare le contrarietà in risorse, Sonda, Casale Monferrato 2011
Partendo dall’approfondimento del colloquio maieutico di Danilo Dolci, Daniele Novara e i suoi collaboratori (tra questi Filippo Sani, Fabrizio Lertora e Paolo Ragusa) hanno elaborato una serie di riflessioni e di strumenti per lavorare sui conflitti a livello intra ed interpersonale. Ne è venuto fuori un testo ricco di spunti, di suggerimenti e di piste di ricerca che si collocano in modo originale nel panorama della ricerca per la pace e sul conflitto.
Il punto di partenza è la distinzione tra violenza e conflitto. L’identificazione, infatti, tra violenza e conflitto, prevalente nel comune sentire e la persistente presenza del mito dell’armonia come auspicabile condizione di assenza di conflitti, hanno come risultato il rifiuto del conflitto stesso, il suo occultamento o rimozione. Ma è proprio qui che nasce il problema. Non riconoscere il conflitto come normale ed inevitabile aspetto delle relazioni umane fa sì che a esso si sostituisca la violenza: un comportamento che tende a eliminare il problema anziché a riconoscerlo, a recidere le relazioni, anziché a metterle in movimento.
Saper gestire la conflittualità, infatti, consente di vivere le relazioni come vitali e significative e quindi può rappresentare l’antidoto naturale alla distruttività umana. C’è qui un importante rovesciamento di prospettiva : non solo il conflitto non è espressione di violenza, ma ne è l’antidoto, proprio in quanto appartiene all’area della competenza relazionale, mentre la violenza elimina la relazione.
Ma da dove viene la violenza? Richiamandosi a Franco Fornari, Novara afferma che essa si origina all’interno di relazioni fusionali che non lasciano spazio e possibilità al contrasto e che, proprio per questo, generano pulsioni distruttive che vengono proiettate all’esterno della relazione e rivolte verso l’altro. Questo meccanismo psichico di difesa è un processo inconscio volto a proteggere l’individuo dall’incontro con il proprio potere distruttivo, attraverso l’esportazione fuori di sé di tutto ciò che del proprio mondo interiore risulta inaccettabile (l’ombra, nella terminologia di Jung). Ma in questo modo si crea l’esigenza di un “ nemico esterno”, che diventa la concretizzazione di quanto è rifiutato dall’individuo o dal gruppo. Per spezzare questo meccanismo è necessario allora reimportare il conflitto all’interno (di sé o del gruppo) e gestirlo in modo da integrare le differenze e accogliere anche le parti oscure, che rendono difficili le relazioni.
In questa prospettiva dunque la pace non è assenza di conflitto, ma è il frutto di una competenza relazionale capace di gestire positivamente i conflitti.
Si può ben comprendere, allora , perché nel testo vi sia una forte critica alle culture educative a-conflittuali e simbiotiche, tendenti a eliminare il valore della differenza e del conflitto.
Un contesto educativo nel quale prevalgono le ragioni dell’appartenenza simbiotica si traduce a livello socio-politico in un delirio etnico. Una sana educazione al conflitto, invece, aiuta a crescere, a guarire le relazioni, a conquistare l’autonomia e anche a essere più aperti verso l’altro e verso le differenze in genere. Così la pace , dal punto di vista educativo, potrebbe anche essere vista come il risultato dell’integrazione dei codici materno (della cura e dell’attaccamento) e paterno (delle regole, del distacco). Il prevalere del codice materno oltre il primo anno di vita può portare a una bassa sostenibilità conflittuale-emotiva che spesso segna i fatti di violenza di varia natura.
Accettare invece la fatica della relazione, riconoscere i propri limiti e quelli che l’altro mi pone, saper rispettare le distanze significa imparare a so-stare nel conflitto e a gestirlo correttamente, sapendo distinguere la persona dal problema.
Per sviluppare le competenze relazionali che rendono capaci di sostare nel conflitto il testo propone alcuni strumenti di lavoro, come la lettura del conflitto, che si avvale del “quadrante dei conflitti” e che mette in luce i “tasti dolenti”, e del “diario dei conflitti”.
Quest’ultimo ben evidenzia l’impostazione esperienziale che , a differenza degli approcci prevalentemente orientati alla soluzione, prescrittivi, pragmatistici, privilegia le prospettive di lavoro interiore che il conflitto può stimolare. Così il conflitto diventa anche di per sé uno strumento di empowerment delle proprie capacità di affrontare e gestire situazioni problematiche, dalle quali si può imparare molto su di sé, sulle proprie abitudini comportamentali, sulle proprie strategie comunicative e relazionali.
Un capitolo sulla negoziazione, uno sulla mediazione e uno sull’efficacia della maieutica nei conflitti completano il volume.
Personalmente ho trovato il testo molto stimolante, anche perché alcuni punti che mi sono parsi meno convincenti mi hanno portata a riprendere aspetti fondamentali della ricerca per la pace. Uno di questi è proprio la definizione stessa di violenza, concetto tutt’altro che scontato o banale. Nelle argomentazioni sviluppate per separare nettamente violenza e conflitto nel testo si afferma: “Anche la tendenza a voler aggiungere parole di benevolenza al termine conflitto come ‘gestione nonviolenta dei conflitti, gestione positiva dei conflitti’ si dimostra anch’essa frutto di una visione ancora bipolare, dove la polarizzazione è tra il mondo dell’armonia e il mondo del conflitto. Si tratta di una visione arcaica, tipica di una società rigida, volendo anche patriarcale (pag. 26).
E ancora: “La convinzione, più o meno diffusa, che la violenza sia una sorta di ‘conflitto più intenso’ appartiene al novero dei luoghi comuni piuttosto che alle affermazioni scientificamente fondate” (pag.23).
Nel conflitto dunque non ci può mai essere violenza? Non identificare conflitto e violenza, passaggio ineludibile di ogni prospettiva nonviolenta, implica che i comportamenti conflittuali siano sempre esenti dal rischio della degenerazione violenta ? O piuttosto il problema non è il conflitto, ma il modo in cui si confligge, che va trasformato e depurato dalle possibili contaminazioni distruttive alle quali la nostra cultura, intrisa di violenza , ci espone?
Mi pare che queste osservazioni muovano da un concetto troppo ristretto di violenza, considerata prevalentemente nella forma di violenza diretta, come fatto intenzionale e irreversibile, a livello intra e interpersonale. Ma la classica tripartizione di Galtung sulle diverse forme di violenza (diretta, in genere intenzionale), indiretta o strutturale (prevalentemente non intenzionale) e culturale mi sembra più completa e convincente.
Così anche come la derubricazione a “vissuto soggettivistico” delle percezioni di violenza subita in una relazione conflittuale mi pare sottovaluti quello che sempre Galtung chiama il vertice “A” nell’articolazione di un conflitto, quello che riguarda appunto il versante soggettivo, cioè il modo in cui le parti coinvolte vedono e vivono la situazione e che è parte essenziale della dinamica conflittuale. Prendere in maggior considerazione i vissuti soggettivi in un conflitto aiuta a mettere in luce , tra l’altro, anche quelle forme di violenza non intenzionale, anzi inflitta spesso in buona fede e senza alcuna consapevolezza del danno inferto che caratterizzano purtroppo tanti rapporti . Sappiamo bene che “ la strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni”…
Ma questi rilievi nulla tolgono all’utilità del testo come strumento di lavoro personale sui conflitti. Anzi, sono proprio queste differenze che stimolano il confronto e arricchiscono la comune riflessione in un ambito tanto essenziale della nostra vita privata e collettiva.





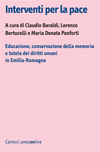
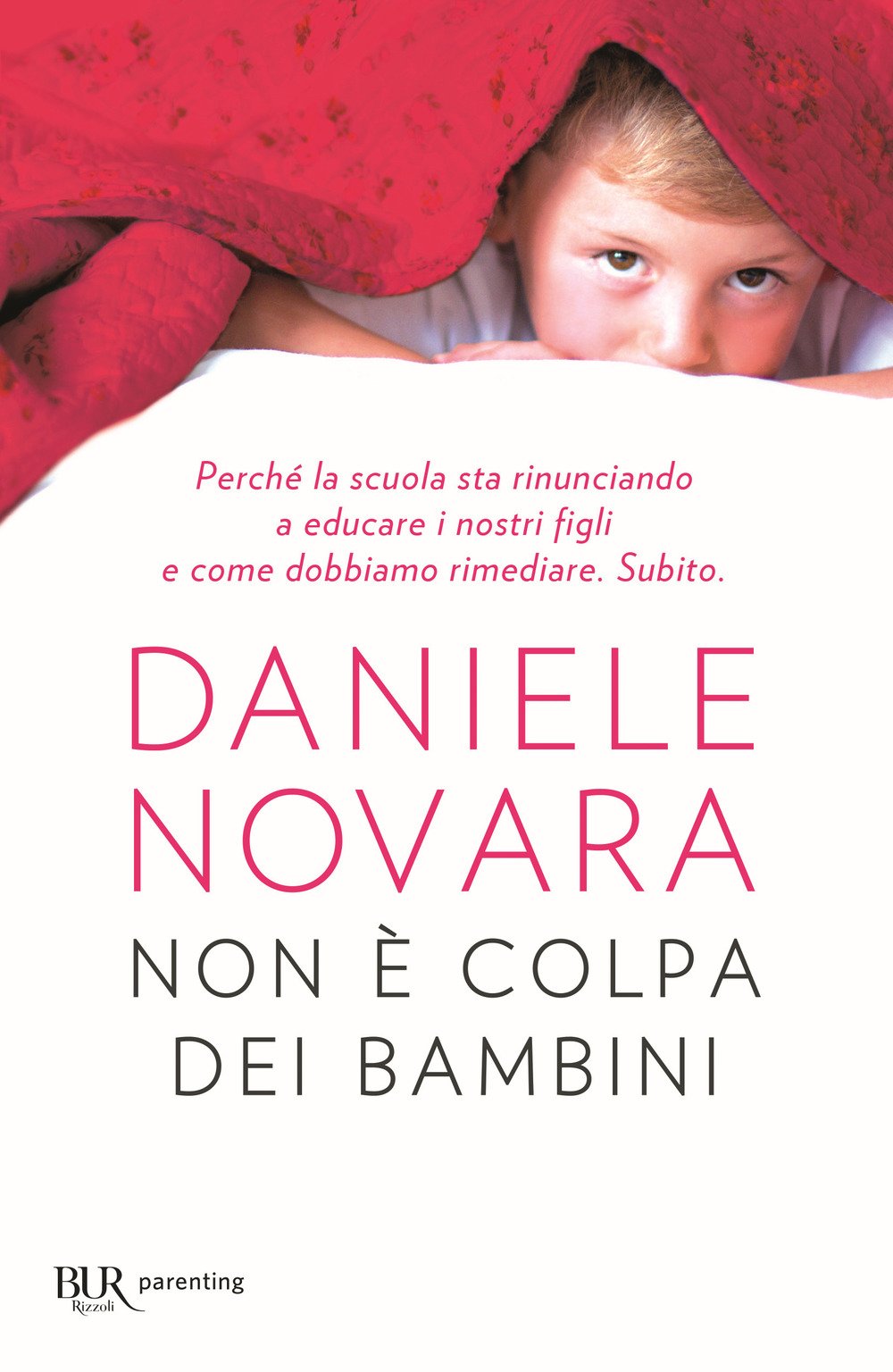





















Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!