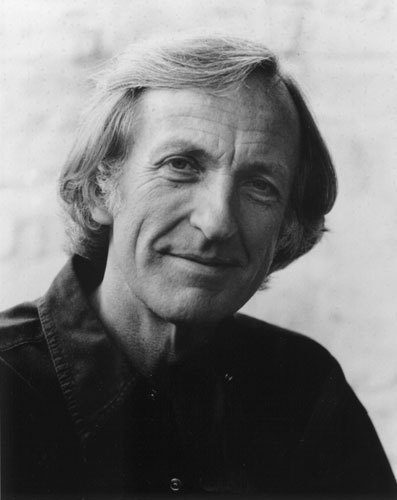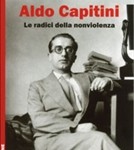Perché i governi fanno le guerre
 Uno sguardo sul fronte interno: una teoria libertaria delle relazioni internazionali
Uno sguardo sul fronte interno: una teoria libertaria delle relazioni internazionali
Perché gli Stati Uniti sono coinvolti in una guerra senza fine in tutto il mondo? Perché, in materia bellica, le nazioni o, meglio, i loro governi si comportano nel modo a cui quotidianamente assistiamo? Il numero di risposte è senza dubbio quasi uguale al numero di interlocutori. “Si tratta di economia”, dicono i marxisti (e gli hamiltoniani): l’imperialismo è la fase suprema del capitalismo. No, dicono i “realisti”, tutto verte sugli oggettivi “interessi” delle varie nazioni e sull’interazione di questi “interessi” in campo internazionale. I neoconservatori hanno una spiegazione diversa: è tutta una questione di “volontà” e “scopo nazionale” o della mancanza di queste: intrisa dell’ideale della nostra “grandezza nazionale” l’America diffonderà la democrazia in tutto il mondo, altrimenti andrà incontro a un declino vergognoso in cui la perdita spirituale precederà la perdita dello spirito guerriero.
Eppure nessuna di queste teorie apparentemente dominanti fornisce una spiegazione adeguata sul come e sul perché ci troviamo nella situazione attuale. L’America ha mandato in bancarotta se stessa per costruire un impero globale con basi, protettorati, colonie in ogni continente; eppure ci ostiniamo ancora a perseguire una politica che ci sta portando sull’orlo dell’abisso finanziario. La nostra rete di ammortizzatori sociali è in gravi condizioni e mostra molti segni di fallimento: il nostro sistema bancario è un traballante castello di carte e la crisi immobiliare nazionale – l’ultima bolla finanziaria a manifestarsi – sta trascinando il ceto medio-basso nella miseria. Eppure inviamo miliardi, anzi, migliaia di miliardi di dollari oltreoceano per puntellare un precario impero all’estero. Come è possibile questo, e perché è successo?
Nel postulare una teoria libertaria dei rapporti internazionali dobbiamo tralasciare il prescrittivo per concentrarci sul descrittivo: cioè, dobbiamo ignorare, per il momento, la questione di ciò che la politica estera ideale dovrebbe essere per concentrarci sulla descrizione di come le nostre attuali politiche sono formulate e attuate. Iniziamo quindi con la questione di chi in questo momento decide la politica estera.
Ci viene detto che nelle società “democratiche” è il popolo a prendere le decisioni, perché, in teoria, i cittadini non richiamano i politici alle loro responsabilità solo quando si recano alle urne, ma anche nelle tribune dell’opinione pubblica e qualsiasi apparato parlamentare condivide il potere con l’esecutivo. Nella pratica, invece, la politica estera è un regno completamente separato, è il dominio di “esperti” e specialisti nascosti nei think tank * e, naturalmente, nelle alte sfere del Consigli di Stato.
Inoltre, a meno che non sia in corso una guerra – evento che ha un effetto evidente sulla vita economica e politica della nazione -, la politica estera è l’ultima delle preoccupazioni dei cittadini. Ciò è particolarmente vero negli Stati Uniti, ma anche in un contesto più ampio: è naturale che le persone di solito siano interessate agli eventi loro più prossimi, perché hanno una maggiore conoscenza del relativo contesto.
Questa presa di distanza dei cittadini dal processo decisionale è accentuata, negli Stati Uniti, dall’erosione del potere del Congresso nel campo della politica estera. Negli ultimi giorni dell’impero americano, la politica è fatta quasi interamente all’interno della Casa Bianca e dalla burocrazia della sicurezza nazionale: il Congresso ha ceduto i suoi poteri in materia bellica molto tempo fa.
Il comportamento dell’America, come di qualsiasi altro paese, in materia di politica estera è quindi il campo d’azione di un gruppo molto piccolo al vertice della piramide politica: quello che potremmo chiamare, in mancanza di una migliore descrizione del gruppo, la classe dirigente, anche nota come “Establishment”. Questi sono i principali attori sulla scena mondiale, oltre a soggetti non incardinabili in schemi definiti, come i gruppi terroristici, i vari movimenti di “liberazione” e George Soros.
Per rispondere alla domanda posta all’inizio di questo articolo, è necessario chiedersi che cosa motiva l’Establishment: cosa lo induce al raggiungimento del consenso e all’azione? Per i libertari e per quelli che hanno una mentalità realistica, che non sempre coincidono con la stessa persona, la risposta è semplice: è tutta una questione di potere.
Il mantenimento e l’espansione del potere politico sono stati l’obiettivo centrale di ogni classe dirigente nel corso della storia, non importa quale fosse il declamato orientamento ideologico. Le dittature, le democrazie e tutte le forme di governo che sono configurabili in una posizione intermedia tra queste due modalità di organizzazione politica hanno questo tratto in comune: il mantenimento e l’espansione del potere politico sono il principio organizzativo alla base della macchina politica, l’idea alla base delle azioni. Le varie spiegazioni ideologiche delle proprie azioni offerte da queste élite sono sempre razionalizzazioni di azioni fatte per il proprio tornaconto e, quindi, in ultima analisi, tali spiegazioni si rivelano irrilevanti: per esempio, la vecchia élite comunista faceva finta di lavorare per la creazione del sistema comunista in tutto il mondo, ma in realtà si dedicava alla creazione del “socialismo in un paese” per accumulare indebitamente ricchezza. In Occidente i leader politici insistono nell’asserire che il loro obiettivo è la diffusione della democrazia liberale e dei relativi presunti benefici economici, ma la realtà è che sono più interessati alle loro campagne elettorali e alle relative probabilità di vittoria: i motti antichi della classe dirigente anglosassone, che ha diffuso il principio della “noblesse oblige”, sono così logori e ridotti a brandelli che nessuno si preoccupa nemmeno di invocarli più.
I politici, insomma, sono in politica per rimanervi: il loro interesse è acquisire e mantenere il potere, e questo è ciò che li motiva in tutte le questioni nazionali e straniere. L’”interesse nazionale”, la “rivoluzione mondiale”, il destino peculiare che viene offerto a noi in qualità di beneficiari canonizzati dell’”eccezionalismo americano”, tutti questi diversi marchi ideologici dalla fumosa consistenza, usati fino al completo logorio, altro non servono che a mascherare con varie tonalità di retorica senza alcun costrutto nudi interessi egoistici.
Un governatore saggio, come ad esempio Marco Aurelio, poteva pervenire alla lunga durata del suo governo (per non parlare del positivo giudizio della storia) tramite il perseguimento della pace, di politiche relativamente benefiche, mentre un folle e/o un malefico come Hitler poteva perseguire politiche che sembrassero espandere il loro potere nel breve, ma lo distruggevano nel lungo periodo. Entrambi, però, erano di fatto motivati ??dalla soverchiante ambizione di indossare l’Anello del Potere e quindi di modellare il corso degli eventi.
Nel cercare di capire perché i governi si comportano in un modo o nell’altro in politica estera, il primo compito di un osservatore intelligente è quello di guardare verso il fronte interno. Le spiegazioni “ufficiali” per le azioni belliche sono sempre legate a qualche “crisi” presente a migliaia di chilometri di distanza, di solito attribuita ai vili atti del cattivo del mese. In realtà, la vera causa di solito molto molto più prossima e ci riguarda direttamente.
Per esempio, diamo un’occhiata agli eventi in Libia, per i quali ci è stato detto che se gli Stati Uniti e la NATO non fossero intervenuti ben centomila civili sarebbero stati massacrati dalle forze fedeli a Muammar Gheddafi. Questa presunta “crisi umanitaria”, tuttavia, si è rivelata essere simile ad altre diffuse con la propaganda tipica delle guerre precedenti, alla pari dei bambini uccisi negli incubatrici in Kuwait, ma non così convincente quanto quella dei bambini belgi che si dice siano stati infilzati sulle baionette del Kaiser.
Lo stiamo facendo per “i bambini”: questo è il tipo di guerra che il Segretario di Stato Hillary Clinton può sostenere! E lei certamente lo ha fatto: infatti, è stata lei, in combutta con altre due importanti arpie “progressiste” dell’alto comando della sicurezza nazionale, a chiedere che gli Stati Uniti intervenissero in Libia, decisione che il presidente era chiaramente riluttante a prendere. Eppure ha accettato per accontentare l’ala clintoniana del suo partito, sempre più inquieta, che sta aggressivamente spingendo perché Hillary sostituisca Biden nel 2012 e per placare George Soros. La dichiarazione improvvisa di una “crisi umanitaria” è stata, lapalissianamente, un ridicolo pretesto per l’intervento, cosa che si è resa ancor più chiara a posteriori, quando una vera crisi umanitaria è stata causata dai diversi ribelli delle “milizie” nelle roccaforti lealiste come Sirte e nella Libia occidentale in genere.
La vera ragione dell’avventura libica è stata la necessità di evitare una crisi politica all’interno della coalizione dei Democratici: Obama voleva una “squadra di rivali” e questo è ciò che ha ottenuto. Dopo aver ceduto la politica estera della sua amministrazione ai Clinton, il presidente non ha avuto altra scelta che lasciare che Hillary affermasse sé stessa: quella della Libia è stata la sua guerra e Obama le ha dato spazio per ragioni puramente interne.
La nostra politica imbarazzante e vacillante sulla questione palestinese, e il conflitto israelo-palestinese in generale, è un altro esempio lampante di come le dinamiche della politica interna possano guidare il processo decisionale della politica estera. Dopo un inizio promettente, l’amministrazione Obama ha abbandonato la sua politica di “grande equilibrio”, tanto vituperata dai neoconservatori, e ha finito con il capitolare dinanzi agli israeliani, riluttanti a tale svolta politica, e alla loro politica di “insediamento”, unendosi a loro anche nel disdegnare l’offerta dell’Autorità Palestinese per il riconoscimento dinanzi alle Nazioni Unite di un obiettivo a lungo perseguito da presidenti degli Stati Uniti, tra cui Bill Clinton e George W. Bush: la creazione di uno Stato palestinese. Perché questo improvviso voltafaccia?
Come una volta sottolineò il candidato dei Democratici alla presidenza Wesley Clark, i grandi donatori del partito, “la gente con i soldi di New York”, non vede di buon occhio i candidati che non concordano con la linea del governo israeliano. La tempistica degli eventi che hanno portato al veto alle Nazioni Unite è un indizio: è avvenuto appena una settimana dopo la sconfitta di un Democratico in un distretto congressuale ebraico di New York, sino ad allora profondamente democratico. L’ultima tensione in rapido acuirsi nelle relazioni tra USA e Iran, il falso complotto “terrorista” iraniano – presumibilmente realizzato da un venditore di auto usate alcolizzato – è ancora di più la prova evidente che la politica estera è poco connessa a quello che accade in realtà, mentre esercitano su di essa grande importanza le esigenze politiche dei vari attori della vita politica interna del paese. In un’epoca in cui le prospettive di rielezione del presidente si fanno sempre più cupe, l’amministrazione Obama ha paura di perdere i donatori chiave e i blocchi di voto che dubitano del suo impegno per la “sicurezza” di Israele. Così, voilà, la grande inversione di rotta è fatta.
Nell’asserire che la politica interna di un Paese è fondamentale per comprendere le relazioni con gli altri Stati, è importante non fare distinzioni, sia ideologiche che strutturali. Cioè, non si devono considerare nel ragionamento le descrizioni autoreferenziali e altri concetti che mascherano la comunanza di fondo di tutti gli Stati in tutto il mondo. Se stiamo parlando di democrazie, o monarchie, “repubbliche della gente” sul vecchio modello sovietico o repubbliche delle banane alla Hugo Chavez, si applica la stessa regola: l’”establishment”, sia esso capitalista, “socialista”, teocratico, o di qualunque altro sapore ideologico è tenuto e determinato a mantenere il potere, e farà di tutto per acquisirne di più.
Questa comunanza è dimostrata dal fatto che le democrazie hanno le stesse probabilità di impegnarsi nelle guerre imperialistiche quanto le dittature di qualsiasi tipo: la nostra attuale politica della guerra infinita dimostra questa regola in modo abbastanza drammatico, e la storia lo conferma. La Gran Bretagna, di gran lunga l’impero più liberale e democratico che sia mai esistito, era allo stesso tempo il più grande aggressore, espandendo senza sosta l’impero in quasi tutti i continenti, abolendo la schiavitù ma schiavizzando milioni di persone sotto altre forme. I rivoluzionari francesi erano allo stesso modo espansionisti, come dimostra chiaramente la carriera di un famoso caporale francese. Come Roma, l’Atene dell’antichità classica, fondatrice dell’ideale democratico, era inizialmente una repubblica e successivamente ha costituito un impero nel Mediterraneo, che alla fine è andato in rovina.
Una teoria libertaria degli affari esteri inizia con l’assioma che chi detiene il potere ci vuole rimanere: tutto il resto segue da questa proposizione di base. È il “tutto il resto”, tuttavia, a essere la parte importante e non un mero dettaglio da chiarire successivamente. Poiché la politica e le decisioni politiche sono fatte da persone reali, non da “forze” impersonali e da astrazioni fluttuanti, il contesto specifico in cui vengono prese queste decisioni è la chiave per comprendere il corso degli eventi. Non basta dire che c’è qualche grande complotto organizzato dagli Illuminati, dai partecipanti al Bilderberg o dai Savi di Fandom, i quali operano dietro le quinte e manipolano la “crisi” del momento a proprio vantaggio. È necessario citare dettagli particolari, cioè connessioni causali tra specifici individui, certe scelte politiche e i benefici ottenuti.
Questo è il motivo per cui il giornalismo è una branca importante delle arti letterarie, e perché il suo declino è un duro colpo per la causa della pace e della libertà. Senza dettagli specifici e senz’armi di fronte ai fatti, né l’analista professionale né il cittadino interessato possono ottenere un indizio su ciò che sta accadendo nella più grande, e più pericolosa, potenza del pianeta. Ecco perché Antiwar.com è uno strumento così importante nella lotta contro il militarismo e l’interventismo: perché portiamo alla vostra attenzione le informazioni che non vogliono farvi conoscere. Il nostro orecchio è sempre a terra, ascoltando i segni rivelatori di un’altra “guerra per la democrazia” e/o “crisi umanitaria” che richiedano l’intervento militare degli Stati Uniti. Portandoli aldilà dei titoli dei giornali, diamo ai nostri lettori notizie importanti sulle ultime mosse del Partito della Guerra e, come il Partito della Guerra, non ci fermiamo mai.
Non possiamo riposare, perché la tendenza dei governi a cercare costantemente opportunità di espandere il proprio potere, anche oltre i confini nazionali, è intrinseca al potere stesso e quindi costante. Non può essere né eliminata né ignorata: deve essere costantemente osservata e sfidata. Ecco perché siamo qui, e per questo dobbiamo continuare a essere qui sino a quando i governi esisteranno.
* Un think tank (letteralmente “serbatoio di pensiero” in inglese) è un organismo, un istituto, una società o un gruppo, tendenzialmente indipendente dalle forze politiche (anche se non mancano think tank governativi), che si occupa di analisi delle politiche pubbliche e quindi nei settori che vanno dalla politica sociale alla strategia politica, dalla economia alla scienza e la tecnologia, dalle politiche industriali o commerciali alle consulenze militari.
Fonte: Why Governments Make War 26.10.2011
7 novembre 2011, Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di ALESSIA
http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=print&sid=9292