Perché le guerre non vengono riferite onestamente?
Nel manuale dell’esercito USA sulla contro-insorgenza, il comandante generale David Petraeus descrive quella in Afghanistan come una guerra “di percezione… condotta continuamente usando le notizie diffuse dai media”. Quel che davvero importa non è tanto la battaglia quotidiana contro i taliban quanto il modo in cui si vende l’avventura in America dove “i media influenzano direttamente l’atteggiamento dei settore chiave dell’opinione pubblica”. Leggendo questo, mi è tornato in mente di quel generale venezuelano che guidò un colpo di stato contro il governo democratico nel 2002: “Avevamo un’arma segreta”, si vantò, “avevamo i media, specialmente la TV. Si devono avere i media”.
Mai si è spesa tanta energia a livello ufficiale nell’assicurarsi che i giornalisti siano conniventi con chi fa guerre di rapina, che secondo quanto dicono i generali ai media loro amici sono diventate “senza fine”. Echeggiando i signori della guerra più verbosi dell’Occidente, come l’ex-vice-presidente USA Dick Cheney, sostenitore della tecnica di tortura del waterboard [consistente nell’immobilizzare un individuo in modo che i piedi si trovino più in alto della testa, e versargli acqua sulla faccia, ndt], che annunciava “50 anni di guerra”, essi programmano uno stato di guerra permanente che dipende interamente dal tenere a bada un nemico di cui non osano fare il nome: il pubblico.
A Chicksands nel Bedfordshire [GB], presso la sezione di guerra psicologica del Ministero della Difesa (Psyops), persone specializzate nel lavorare con i media si dedicano a tale compito, immersi in un mondo gergale di “dominanza informativa”, “minacce asimmetriche” e “cyberminacce”. Operano negli stessi locali con coloro che insegnano i metodi d’interrogatorio che hanno portato a una pubblica inchiesta sulla tortura da parte dei militari britannici in Iraq. La disinformazione e la barbarie della guerra coloniale hanno molto in comune.
Ovviamente, solo il gergo è nuovo. Nella sequenza d’apertura del mio film The War You Don’t See [La guerra che non vedete], c’è un riferimento a una conversazione privata pre-WikiLeaks, del dicembre 1917, fra David Lloyd George, primo ministro britannico per buona parte della prima guerra mondiale, e CP Scott, direttore del Guardian di Manchester: “Se si sapesse davvero la verità”, diceva il primo ministro, “la guerra si fermerebbe domani. Ma naturalmente non si sa e non si può sapere”.
Nella scia di questa “guerra per por fine a tutte le guerre”, Edward Bernays, un amico del presidente Woodrow Wilson, coniò il termine “pubbliche relazioni” (PR) come eufemismo per propaganda “al quale si è dato un brutto nome durante la guerra”. Nel suo libro, Propaganda (1928; traduzione italiana: Propaganda, Fausto Lupetti, Bologna 2008), Bernays descriveva le PR come “un governo invisibile che è il vero potere in carica nel nostro paese” grazie all’ “intelligente manipolazione delle masse”, ottenuta con “false realtà” e la loro adozione da parte dei media. (Uno dei primi successi di Bernay fu persudere le donne a fumare in pubblico. Associando il fumo alla liberazione delle donne, ottenne titoli inneggianti alle sigarette come “torce di libertà”).
Ho cominciato a capire tutto ciò da giovane reporter nel corso della guerra USA in Vietnam. Durante la mia prima missione, vidi i risultati del bombardamento di due villaggi e dell’utilizzo del Napalm B, che continua a bruciare sotto la pelle; molte fra le vittime erano bambini; gli alberi avevano brandelli di membra umane. Il lamento che “in guerra succedono di queste tragedie inevitabili” non spiegava perché virtualmente l’intera popolazione del Sud Vietnam corresse un grave rischio da parte delle forze del loro “alleato” dichiarato, gli USA. Termini del linguaggio delle PR come “pacificazione” e “danno collaterale” divennero la nostra moneta corrente: quasi nessun reporter usava la parola “invasione”. “Coinvolgimento” e poi “pantano” furono capisaldi di un vocabolario dei notiziari in cui si riconosceva l’uccisione di civili come null’altro che tragico errore mettendo di rado in questione le buone intenzioni degli invasori.
Sui muri degli uffici di Saigon delle principali agenzie di stampa americane spesso c’erano fotografie orripilanti mai pubblicate e raramente inviate perché si diceva che avrebbero reso “sensazionale” la guerra sconvolgendo i lettori e gli spettatori, non essendo quindi “obiettive”. Il massacro di My Lai nel 1968 non fu riferito dal Vietnam, benché vari reporter ne fossero a conoscenza (e di altre atrocità analoghe), ma da un freelance negli USA, Seymour Hersh. La copertina della rivista Newsweek lo definiva una “tragedia americana” intendendo che gli invasori ne erano le vittime: tema liberatorio entusiasticamente ripreso da Hollywood in film come The Deer Hunter e Platoon. La guerra era difettosa e tragica, ma la causa era essenzialmente nobile. Inoltre, fu “persa” grazie all’irresponsabilità di un mezzo di comunicazione ostile e non sottoposto a censura.
Benché il contrario della verità, tali false realtà divennero le “lezioni” imparate da chi conduce le guerre attuali e da molti dei media. In seguito al Vietnam, l’ “embedding” (il coinvolgimento controllato, ndt) dei giornalisti è divenuto centrale per la politica bellica di là e di qua dell’Atlantico. Tranne poche onorevoli eccezioni, è riuscito nel suo compito, specialmente negli USA. Nel marzo 2003, circa 700 reporter e video-operatori embedded accompagnavano le forze americane che invasero l’Iraq. A guardare i loro reportage concitati, sembrava di assistere a una nuova liberazione dell’Europa in tutto e per tutto. Gli irakeni erano distanti, attori secondari e fugaci: John Wayne era tornato inpiena forma.
L’apogeo fu il vittorioso ingresso a Baghdad, con le immagini TV di folle giubilanti all’abbattimento di una statua di Saddam Hussein. Dietro tale facciata una squadra Psyops USA manipolò con successo quello che un reportage dell’esercito USA di cui non si tenne conto definiva un “circo mediatico [con] quasi altrettanti reporter che irakeni”. Rager Omaar, che era lì per la BBC, riferì al notiziario principale serale: “La gente è uscita ad accogliere [gli americani], alzando segni a V [=di vittoria]. Un’immagine che vale per tutta quanta la capitale irakena”. In realtà, era ampiamente in corso in quasi tutto l’Iraq, per lo più passata sotto silenzio, la conquista sanguinosa e la distruzione di un’intera società.
In The War You Don’t See, Omaar parla con ammirevole franchezza: “Effettivamente non ho fatto il mio lavoro come si deve”, dice, “avrei da obiettare che non si sono sottolineati abbastanza i temi più scomodi”. Descrive come la propaganda militare britannica sia riuscita a manipolare i reportage sulla caduta di Basra, riferita da BBC News 24 come se fosse avvenuta ben “17 volte”; e fu, dice ancora, “una gigantesca sala di eco”.
La portata nuda e cruda delle sofferenze irakene durante l’assalto ebbe poco posto nelle notizie. Davanti al n. 10 di Downing Street la notte dell’invasione, Andrew Marr, allora redattore politico della BBC, dichiarò: “[Tony Blair] ha detto che sarebbero in grado di prendere Baghdad senza un bagno di sangue e che alla fine gli irakeni avrebbero celebrato, e in tutt’e due le cose si è dimostrato in conclusione quanto avesse ragione…” Chiesi un’intervista a Marr, ma non ebbi risposta. In alcuni studi svolti dall’ Università del Galles a Cardiff sulla copertura televisiva, e in Media Tenor, si evidenzia come le trasmissioni della BBC riflettessero essenzialmente la linea governativa e i reportage sulle sofferenze dei civili fossero relegati sullo sfondo. Media Tenor pone la BBC e l’americana CBS all’ultimo posto nella graduatoria di una serie di trasmittenti occidentali per il tempo assegnato agli oppositori della invasione. “Accetto pienamente l’accusa che siamo stati ingannati” ha detto Jeremy Paxman, a proposito delle armi irakene di distuzione di massa inesistenti rivolgendosi a un gruppo di studenti l’anno scorso. “È evidente che lo siamo stati”. Da professionista ben retribuito dell’emittente, ha omesso di dire perché sia stato ingannato.
Dan Rather, anchorman dei notiziari CBS per 24 anni, è stato meno reticente con me: “In ogni redazione USA c’era una tal paura, paura di perdere il posto… paura di venire incastrato con qualche etichetta, di non patriottico o che altro”. Rather dice che la guerra “ci ha reso degli stenografi” e che se i giornalisti avessero messo in discussione gli inganni che condussero alla guerra in Iraq invece di amplificarli, l’invasione non sarebbe avvenuta. Opinione oggi condivisa da vari autorevoli giornalisti che ho intervistato negli USA.
In GranBretagna, David Rose, i cui articoli sull’Observer ebbero una parte importante nel collegare falsamente Saddam Hussein ad al-Qaeda e all’11 settembre, mi ha coraggiosamente concesso un’intervista in cui ha detto: “Non posso accampare scuse… Quel che è successo [in Iraq] è stato un crimine, un crimine su una scala molto ampia…”.
“Questo rende complici i giornalisti?” gli ho chiesto.
“Sì… inconsapevolmente, forse, ma sì”.
Qual è il valore di ammissioni di questo genere da parte di giornalisti? La risposta è fornita dal grande reporter James Cameron, il cui coraggioso e rivelatore reportage filmico, fatto con Malcolm Aird, del bombardamento dei civili in Nord-Vietnam fu bandito dalla BBC. “Se noi, ritenuti quelli che dovrebbero scoprire che cosa hanno in canna i bastardi, se non riportiamo quanto troviamo, se non la diciamo tutta”, mi disse, “chi può fermare tutto il maledetto affare che sta di nuovo capitando?”
Cameron non avrebbe potuto immaginare un fenomeno moderno come WikiLeaks ma l’avrebbe sicuramente approvato. Nell’attuale valanga di documenti ufficiali, specialmente quelli che descrivono le macchinazioni segrete che conducono alla guerra – come la mania USA per l’Iran – si nota di rado il fallimento del giornalismo. E forse il motivo per cui Julian Assange sembra eccitare tale ostilità fra i giornalisti al servizio di una varietà di “lobby”, quelli che il portavoce-stampa di George Bush chiamò una volta “potenziali complici”, è che WikiLeaks e la sua veridicità li fa vergognare. Perché il pubblico ha dovuto aspettare WikiLeaks per scoprire come agisce realmente una grande potenza? Come rivela un documento trapelato di 2.000 pagine del Ministero della Difesa, i giornalisti più efficienti sono quelli considerati nei palazzi del potere come non embedded o cooptabili, ma come “minaccia”. Questa è la minaccia alla vera democrazia, la cui “moneta corrente”, diceva Thomas Jefferson, è “il libero fluire dell’informazione”.
Nel mio film ho chiesto ad Assange come WikiLeaks abbia trattato le draconiane leggi sulla segretezza per cui è famosa la Gran Bretagna. “Beh,” disse, “quando si guardano i documenti etichettati secondo la Legge sui Segreti Ufficiali, vi si trova l’asserzione che è reato detenere l’informazione ed è reato distruggerla, quindi l’unico risultato possibile è dover pubblicarla”. Questi sono tempi straordinari.
10.12.10
Titolo originale: Why are wars not being reported honestly?
http://www.johnpilger.com/articles/why-are-wars-not-being-reported-honestly
Traduzione di Miki Lanza per il Centro Studi Sereno Regis






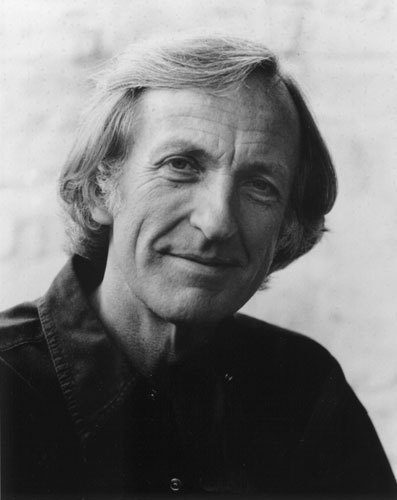





















Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!