Il Dio di Gandhi tra ricerca della verità, mito e laicità
Antonio Vigilante, Il Dio di Gandhi. Religione, etica e politica, Levante, Bari 2009
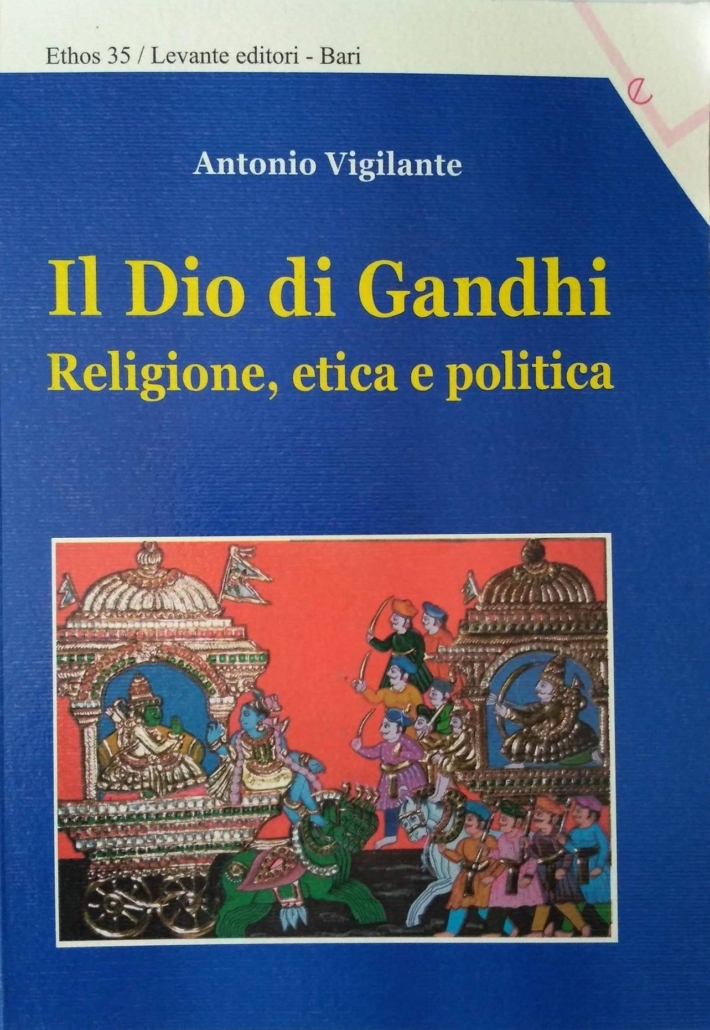 La letteratura su Gandhi, come quella su molte altre grandi personalità, è sterminata e si accresce di anno in anno con articoli, libri, saggi, biografie molti dei quali disponibili liberamente su Internet. D’altronde, già i cento volumi dei suoi Collected Works, digitalizzati e anch’essi disponibili su Internet, sono una sfida notevole per chi voglia conoscere più a fondo il suo pensiero. A queste difficoltà si aggiunge il fatto che Gandhi ha vissuto a cavallo di due culture: da un lato quella Occidentale, soprattutto inglese, e dall’altra l’antichissima, vastissima e profondissima civiltà dell’India.
La letteratura su Gandhi, come quella su molte altre grandi personalità, è sterminata e si accresce di anno in anno con articoli, libri, saggi, biografie molti dei quali disponibili liberamente su Internet. D’altronde, già i cento volumi dei suoi Collected Works, digitalizzati e anch’essi disponibili su Internet, sono una sfida notevole per chi voglia conoscere più a fondo il suo pensiero. A queste difficoltà si aggiunge il fatto che Gandhi ha vissuto a cavallo di due culture: da un lato quella Occidentale, soprattutto inglese, e dall’altra l’antichissima, vastissima e profondissima civiltà dell’India.
In tempi di crisi e di incertezze sono molti coloro che si rivolgono a Gandhi chiedendosi quanto del suo pensiero, delle sue opere e dei suoi insegnamenti siano attuali e possano aiutarci a trovare una via d’uscita dai vicoli ciechi in cui siamo incappati.
E d’altra parte, l’influenza del suo operare si è fatta sentire lungo tutto l’arco del ventesimo secolo (da Martin Luther King a Mandela, da Capitini a Lanza del Vasto, sino agli eventi culminati nel 1989 con la trasformazione epocale del sistema di relazioni internazionali) e secondo molti è alla nonviolenza gandhiana che l’umanità deve rivolgersi per affrontare le sfide del XXI secolo.
Tra i libri più recenti, merita una particolare attenzione il lavoro di Antonio Vigilante, che ho letto e riletto più volte, prima di scrivere queste poche righe, poiché la densità e ricchezza sia delle informazioni, spesso poco conosciute, relative alla figura di Gandhi, sia le argomentazioni proposte nei quattro capitoli di cui si compone il libro rendono quanto mai difficile una semplice presentazione. Occorre leggerlo integralmente, farne occasione di discussione, formazione e ricerca ulteriore.
Il primo capitolo ricostruisce la formazione culturale e religiosa di Gandhi e le molteplici influenze che influirono sul suo pensiero. Ma l’autore non si limita a riproporre una ennesima biografia, bensì si propone di individuare i tratti caratteristici che ricorreranno man mano nella vita di Gandhi a partire dall’ipotesi che le prime esperienze di ciascuno di noi, risalenti all’infanzia, lascino tracce profonde e durature.
E qui si tocca un primo punto centrale, quello della “sacralità della persona umana”, violata in India dal sistema delle caste e in Occidente dai massacri compiuti su larga scala (Shoah, Hiroshima e Nagasaki) e dalle istituzioni totali dove rinchiudere “folli e criminali”. “Per il massacro -scrive Vigilante- ci si è serviti degli ebrei e dei Rom. Oggi sono rimasti questi ultimi, a rappresentare gli uomini non sacri, gli uomini dissacrabili e massacrabili. La loro posizione in Occidente, e segnatamente in Italia, è del tutto simile a quella degli intoccabili in India… Come in India la retorica dell’ ahimsa, che afferma il valore della stessa vita animale, si scarica poi sugli intoccabili, così nell’Italia cristiana e cattolica la retorica del prossimo trova un limite preciso nel Rom, che diventa il più lontano, colui in cui non è possibile riconoscere un uomo.” (p. 34)
Per tentare di comprendere il pensiero di Gandhi, occorre tener conto che egli non è un pensatore sistematico, non è interessato a costruire un sistema di pensiero coerente e immodificabile, ma la sua continua ricerca della verità lo porta a compiere esperimenti che talvolta possono condurre a risultati contraddittori e alla necessità, alla quale di solito egli non si sottrae, di modificare il suo pensiero e di aggiustarlo man mano nel corso della sua vita.
Difficile quindi individuare dei principi univoci, rigidi e dogmatici. Sul fronte religioso, egli si confronta con la sua tradizione, mettendola in discussione là dove gli sembra non accettabile, e approfondisce la conoscenza delle altre principali tradizioni religiose, il che lo porta a concludere che esiste un “solo tronco, molti rami”, titolo del primo capitolo del libro.
Nel secondo capitolo, Vigilante ci porta a esplorare, in un’ampia carrellata, il rapporto tra Gandhi e il “neo-hinduismo” attraverso vari autori, Ram Mohan Roy, Ramakrishna, Vivekananda, Tagore, ognuno dei quali ha contribuito al rinnovamento della cultura tradizionale indiana.
Il terzo capitolo è dedicato a una lettura incrociata della Bhagavad Gita, il testo che per Gandhi costituisce una sorta di “vangelo”, mettendo a confronto la sua interpretazione con quelle di Prabhupada, Sri Aurobindo Ghose e Vinoba Bhave.
La lettura della Gita fatta da Gandhi lo porta a sostenere “che Dio interviene in favore degli uomini buoni per difenderli dal male”. Sulla base di questa convinzione che “consente di aver fiducia nella riuscita dell’impresa nonviolenta” si fonda il satyagraha, una scelta che ad altri potrebbe apparire folle e senza speranza (p. 184). Non senza difficoltà, Gandhi cerca di conciliare l’esigenza mistica della concezione del divino con quella etico-politica di intervento nella realtà sociale. Il suo pragmatismo gli consente di “trarre dall’immenso patrimonio religioso indiano le convinzioni di fondo che hanno mosso una pratica politica assolutamente inedita, straordinaria, profetica” pur “lasciando nel vago non pochi problemi teorici” (p.203).
Il quarto capitolo entra più direttamente nel merito della concezione gandhiana di Dio e delle pratiche ascetiche necessarie per entrare in contatto con esso e prende l’avvio da una lunga citazione di un discorso tenuto nel 1931, nel quale Gandhi presentò per la prima volta la sua tesi che “la Verità è Dio”. Dopo aver esordito dicendo che “Dio è amore”, egli sostiene che mentre questa affermazione può comportare alcune ambiguità dovute al significato che attribuiamo al termine amore, “non ho mai trovato un doppio significato in connessione con la Verità, e nemmeno gli atei hanno mai negato la necessità o il potere della Verità…. E’ a causa del loro modo di ragionare che ho realizzato che non avrei dovuto dire ‘Dio è verità’, ma ‘la Verità è Dio’” (p. 206).
Ma accanto a questa “Verità-Dio”, Vigilante mette in evidenza come per Gandhi esista un “Dio etico” nel quale egli ripone la sua totale fiducia sino al punto di prevedere il crollo dell’impero britannico: “Nessun impero, intossicato con il vino rosso del potere e del saccheggio delle razze più deboli può durare a lungo in questo mondo, e questo ‘impero britannico’… non può durare, se un Dio giusto governa l’universo”.
E l’imperò effettivamente crollò: merito del “Dio giusto”, dell’azione di Gandhi, dell’ inevitabile conseguenza dei processi storici che si susseguono con crolli degli imperi, da quello romano, a quello sovietico, al prossimo crollo dell’impero USA, previsto con tanto di teoria basata su quattordici contraddizioni da Johan Galtung entro la fine di questo decennio (The fall of the US empire. And then What?, TUP, 2009)?
Qui si apre uno dei punti cruciali per fondare in modo radicale, sebbene non esaustivo, una teoria della nonviolenza. L’ottimismo metafisico di Gandhi, basato sull’idea di un Dio giusto che governa il mondo sembra inadeguato a interpretare sia il male provocato dall’uomo ad Auschwitz, Hiroshima e Nagasaki o a Chernobyl e Bhopal (per limitarci agli eventi più noti), sia quello delle catastrofi naturali, sebbene esse siano oggi ampiamente superate in intensità dalla smisurata potenza dell’agire umano.
E’ lo “scandalo” di una natura cieca al bene e al male, ma anche quello di un Dio debole che, come ebbero a dire alcuni rabbini, “guardava da un’altra parte mentre avveniva la Sohah”. E’ il “silenzio di Dio” che tanto angustia molti teologi, e che probabilmente indusse Dietrich Bonhoeffer a tentare con altri di sopprimere Hitler. Ma non è il “silenzio del Buddha”, che Vigilante richiama opportunamente in un altro suo lavoro (“Compresenza e vacuità. Una lettura buddhista di Aldo Capitini” in: Giuseppe Moscati, a cura di, Il pensiero e le opere di Aldo Capitini nella coscienza delle nuove generazioni. Atti della I Giornata dei giovani studiosi capitiniani, Perugia, 14 marzo 2009, Levante editori, Bari 2010) e che invece ha molto a che fare con il riconoscimento dei nostri limiti conoscitivi e con l’incapacità, se non l’impossibilità, di dare risposte esaustive ai grandi problemi della vita.
Giunto a questo punto, nelle brevi e incisive pagine della Conclusione, che intitola problematicamente La forzatura della Verità, Vigilante non si limita a riassumere i punti principali del suo lavoro, ma lo amplia ulteriormente cimentandosi in un confronto quanto mai importante, interessante e indispensabile tra il pensiero di Gandhi e quello di Aldo Capitini su cui è bene soffermarsi.
Per introdurre le sue riflessioni, Vigilante prende spunto dal paragone tra l’azione dello sconosciuto ragazzo che in piazza Tienanmen il 5 giugno 1989 riuscì a fermare a mani nude i carri armati (immagine che evoca quella altrettanto famosa a Praga nel 1968) e il tentativo finito tragicamente, di Rachel Corrie, il 16 marzo 2003 a Gaza, di fermare un bulldozer. Paragonandoli agli “esperimenti con la verità” di Gandhi, Vigilante si chiede “che diremo oggi della forza della verità? Possiamo crederci?” La conclusione a cui giunge è quella, ben nota, che non ci sono “leggi della storia” che garantiscano il successo di uno strumento violento (che, come afferma Gandhi, è tale che “la violenza genera violenza” e “occhio per occhio e il mondo diventa cieco”) oppure di quello nonviolento.
Vinay Lal, profondo conoscitore del pensiero gandhiano, sostiene che per Gandhi “ La storia non poteva essere una guida all’azione nel presente; in realtà, l’idea di fondo che la lotta dovesse essere condotta nei confronti dell’oppositore in maniera nonviolenta comportava che si ignorasse la storia, o altrimenti il peso del passato sarebbe stato talmente elevato da rendere futile l’impresa nel momento stesso in cui veniva pensata. Gandhi respinse l’idea, largamente diffusa oggi, che ci fossero “lezioni” da apprendere dalla storia. Forse l’unica lezione era che la storia deve essere dimenticata.” ( The History of History: Politics and Scholarship in Modern India, Oxford University Press 2003, p. 61-62).
L’opinione di Gandhi può essere rafforzata ulteriormente osservando che gran parte delle nostre azioni e delle nostre scelte avvengono in condizioni di “ignoranza”, ovvero nella impossibilità di prevedere l’esito delle nostre azioni, il che rende assai problematica la classica distinzione weberiana tra etica della responsabilità ed etica della convinzione. In realtà, agiamo quasi sempre per convinzione, anche quando sosteniamo di agire in nome della responsabilità. Si può sostenere che Gandhi abbia anticipato le riflessioni che oggi vengono svolte da coloro che analizzano i problemi complessi, globali e controversi e l’impatto che le decisioni nel campo dei problemi scienza-tecnologia-società provocano sugli ecosistemi e sulle società umane.
Connessi con tale questione sono i temi della compresenza capitiniana e del rifiuto di limitarsi ad accettare la realtà così com’è, che Vigilante richiama nelle ultime pagine del suo lavoro affermando che per Capitini, “la nonviolenza è, nella sua essenza, non collaborazione con una realtà nella quale i carri armati schiacciano esseri umani, il pesce grande mangia il pesce piccolo, i deboli sono spazzati via e il tempo annulla tutti” (p.271).
Se Gandhi fonda la sua concezione del divino con la forzatura di un Dio-Bene al centro dell’universo, il Dio di Capitini “pensato a partire dalla prassi è un Dio eccentrico, sta ai margini, là dove la trama delle cose mostra i suoi strappi” (pp.270-271). Ma le due concezioni, sostiene Vigilante, trovano un punto di contatto “tra questi due straordinari protagonisti della nonviolenza” nell’idea di un Dio dei poveri, quel Dio, dice Gandhi, che si presenta ai poveri “sotto forma di pane” e che costituisce tuttora una sfida tanto per le tradizioni religiose quanto per quelle laiche.

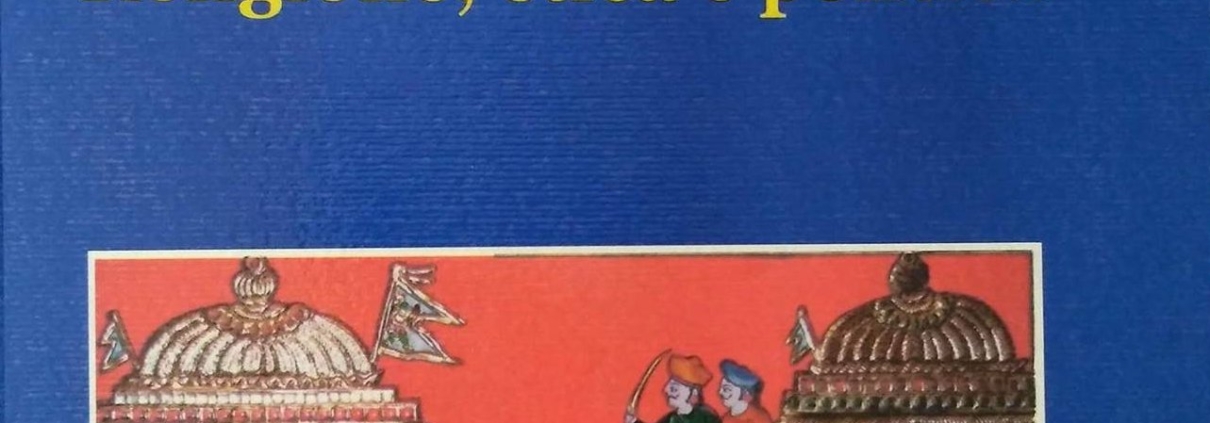























Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!