A proposito di nonviolenza evangelica
Cristianesimo, violenza, nonviolenza. Mi pare che ci sia una ambivalenza (non ambiguità) nelle interpretazioni del cristianesimo riguardo a violenza e nonviolenza.
Evangelo, euangelion, significa “annuncio di bene” (espressione che trovo migliore della consueta e consunta “buona notizia”); cioè annuncio che c’è un Bene fondamentale, più profondo e più forte del male presente nel mondo; un Bene che salva la vita le dà senso.
Non è un ottimismo, cioè una probabilità o una opinione fiduciosa nella prevalenza del bene.
Ma è un evento (realmente iniziato e sempre in corso) altamente drammatico: il male rifiuta e colpisce il bene; ma non lo vince; la vita giusta e buona vince il male; questo processo in corso si compirà in un tempo escatologico, finale, completo. È un fatto che ogni comparsa di bene nella storia (amore, giustizia, liberazione) suscita una reazione del male (dominio, falsità, violenza). La fiducia evangelica è che il male vince solo provvisoriamente. Il segno più alto di questo dramma è visto nella morte infamante di croce, e nella risurrezione (o glorificazione, o elevazione a Dio, non semplice rianimazione biologica) di Gesù Cristo. Ciò è evento e processo (Pascal: “Cristo è in agonia fino alla fine dei tempi”), non solo memoria ma anche attesa del suo ritorno.
Bene e male non sono da intendere come sostanze o entità metafisiche, ma come modi di vivere: vita giusta e collaborativa, oppure vita iniqua e dominante, avversa a ciò che è e che vive.
*
“Dio” è un nome comune usato come nome proprio del Vivente non definibile. Il suo nome-non-nome udito da Mosè è: “Eccomi, sono con te” (Esodo 3,14). Non è una definizione, ma un’azione, una relazione.
Chi accoglie il vangelo chiama “Dio” un Vivente che intuiamo, che speriamo, che Gesù chiama Abbà, cioè Papà, Babbo (per esprimere intimità e vicinanza familiare); un Vivente che il cristiano confida sia il fondamento e la realtà viva del Bene, per cui gli dà fiducia e si tiene in relazione intima con lui.
Implicitamente, se cerchiamo di fare un po’ di bene, mentre il male trionfa, crediamo nella realtà del Bene, più vivo di noi, che vive in noi (“più vicino a me della mia vena giugulare”, dice il Corano 50,16), qualunque sia il modo in cui lo pensiamo e lo chiamiamo.
*
Bene e male sono dentro ciascuno di noi, non vanno visti come campi di realtà opposti e nettamente separati; perciò, la prima lotta è interiore; però, nello stesso tempo, non possiamo spiritualizzare o psicologizzare troppo le due realtà, perché nella storia il bene e il male prendono corpo in culture, tradizioni e strutture che, benché intrecciate tra loro (parabola del grano e della zizzania, Matteo 13, 24-30), hanno qualità distinte: o positive, favorevoli alla vita buona, al rispetto della vita; oppure avverse ad essa; o più giuste o più ingiuste. Io non posso essere buono lasciando che il mondo sia cattivo. Non posso aspettare che il mondo sia buono per essere buono io. Persone benintenzionate in strutture cattive fanno cose cattive senza volerle, ma le fanno. Il problema del male e del bene, dunque, riguarda la politica e la storia, insieme alle nostre scelte morali interiori.
La scelta tra il bene e il male (quasi mai estremi assoluti, ma per lo più un allontanarsi dal male e avvicinarsi al bene) nelle nostre azioni non è solo per costruire la propria personale vita buona, ma per costruire anche una storia umana (strutture e culture) più buona e più giusta.
Ora, la vita proposta dall’evangelo consiste sia nel fare il bene (essere generosi, amare chi non ti ama, dare più che ricevere, dunque essere creativi, porre bene dove c’è male), sia nell’evitare e avversare il male.
La coscienza e la ricerca del bene rende più viva e dolorosa la coscienza del male. Chi più cerca il bene più aborre il male. Chi ha più speranza ha più delusioni e sofferenze.
D’altra parte, la presenza del male “dimostra” in qualche modo la realtà del bene, perché noi non sentiremmo che quello è male se non avessimo il criterio (nostalgia, speranza) del bene a confronto del quale il male è male. Senza il bene, il male sarebbe normale.
L’ambivalenza degli esiti possibili dell’impostazione evangelica di vita dipende dal prevalere della ricerca del bene nonostante il male (superare il male col bene; rispondere al male col bene) oppure dell’avversione al male in nome del bene (non fare il male; proibire e impedire il male).
Il massimo della prima via è il perdono “sette volte sette”, l’assumere su di sé la sofferenza o la colpa altrui, il donare senza corrispettivo, ecc. Il massimo della seconda via è punire l’omicida con l’omicidio di lui, eliminare il malvagio per togliere il male, infliggere pena per correggere, rendere male per male, restituire colpo per colpo, violenza per violenza, ecc.
La prima via porta alla nonviolenza attiva e forte, lotta al male con la forza tutta alternativa del bene. La seconda via porta alla giustificazione, in nome del bene, della violenza punitiva, nella pretesa di sradicare il male ben individuato (con tutti i rischi dell’arbitrio, e di strappare grano insieme alla zizzania). Nella storia, il cristianesimo ha prodotto sia l’una sia l’altra via.
*
Il Concilio Vaticano II, specialmente nella dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa (www.vatican.va) , ha superato la concezione secondo la quale solo la Verità e il Bene avevano diritti, l’Errore e il Male nessuno, e ha spiegato, senza cadere nel relativismo, che i diritti spettano alle persone e non a entità impersonali come la Verità e l’Errore, il Bene e il Male.
Già Pio XII, in un discorso ai giuristi del 6 dicembre 1953 respingeva l’affermazione incondizionata che si debba sempre impedire il male (ciò che riteniamo traviamento religioso e morale), e che la tolleranza del male sia già di per sé un male; e affermava che, poiché Dio riprova ma lascia esistere il male (la zizzania insieme al grano, fino al giudizio), nessuna autorità umana (né politica né religiosa) ha il dovere assoluto di reprimere l’errore e il male morale, ciò che causerebbe per lo più un male ancora peggiore e impedirebbe un miglioramento.
Il Concilio va oltre questa tolleranza per necessità, e apre la cultura cattolica a pensare il conflitto tra vita buona e vita malvagia, tra l’agire giusto e l’agire ingiusto, in termini di nonviolenza positiva e attiva, che corrisponde al rispetto assoluto anche della persona che agisce male, e alla originale genuina ispirazione evangelica dell’amore effettivo per l’errante e il nemico.
*
Abbastanza chiaro nelle sue origini, il cristianesimo è stato catturato, nel IV secolo, dagli imperatori Costantino e Teodosio, che, facendolo religione di stato, lo hanno liberato dalla persecuzione asservendolo alla strumentalizzazione (instrumentum regni), in successive forme storiche. Così, fino ad oggi le chiese cristiane, in vari modi, si sono compromesse coi poteri, anche violenti. Chiese minoritarie, specialmente alcune protestanti, hanno conservato la nonviolenza evangelica. Il Concilio Vaticano II, tornando al vangelo genuino, voleva sancire la “fine dell’era costantiniana”, ma con qualche mediazione realistica. Inoltre, la sua attuazione e sviluppo sono stati finora congelati.
Mi pare che non conti tanto la differenza qualitativa tra il cristianesimo pre-costantiniano e quello post-costantiniano, quanto la tensione tra ispirazione e istituzione nella tradizione cristiana.
Se prevale la rigidità della istituzione, interessata all’autoconservazione e al potere, si riduce o si perde l’ispirazione. Ma l’ispirazione non manca e non è mai mancata del tutto nella storia, fino a Martin Luther King, ai coniugi Jean e Hildegard Goss, e tanti altri, che hanno praticato la nonviolenza animati da ispirazione evangelica.
*
Ancora due note. La prima: sul grave e complesso problema della violenza nella Bibbia, riassumo da un lavoro di Giuseppe Barbaglio (Amore e violenza. Il Dio bifronte, Ed. Pazzini 2006): anche nella Bibbia, come in generale nelle religioni, l’immagine della divinità è duplice: affascinante e tremenda. Il 90% delle scritture ebraiche e cristiane riflette questa ambivalenza, archetipo religioso di cui si riscontra qualche traccia persino in alcune parole di Gesù (che dovette confrontarsi con questa teologia del suo ambiente), ma lo straordinario è il 10% di immagini chiare di un Dio di amore, che caratterizzano il messaggio di Gesù, preannunciato da qualche profeta.
Seconda nota: riguardo al dolore accolto per autopurificazione, per solidarietà, per coraggio e fedeltà al compito, bisogna vigilare su alcune estese torsioni del vangelo in senso doloristico. Il dolore non è un valore, ma un male, perché offende la vita, ma può essere un prezzo che si accetta di pagare al male – assunto e trasformato in forza (come Nadia Neri dice di Etty Hillesum) – per raggiungere un bene.
In particolare, la sofferenza affrontata e accettata da Gesù, oggi, alla luce di un’idea più pura di Dio, non può più essere pensata (come è stata a lungo pensata), come voluta da Dio per l’offesa fattagli dai peccati dell’umanità, scaricando la sua punizione sull’uomo più giusto, figlio perfetto di Dio, il cui sacrificio (la croce) era l’unica soddisfazione adeguata alla maestà infinita di Dio e alla infinita gravità dei peccati umani. Una tale concezione, basata su astrazioni metafisiche, urta radicalmente la bontà e la giustizia del Dio annunciato da Gesù Cristo e non vede che Gesù morì in quel modo per la sua fedeltà strenua alla sua missione di verità, per il suo coraggioso amore “fino in fondo” (Giovanni 13,1), e per la sua solidarietà, come condannato innocente, nell’affrontare il male che l’umanità patisce, senza fare assolutamente alcun male a chi gli fa male.
È la sua piena libertà dal male la forza che libera dal male chi cammina con lui in fedeltà e coraggio. Il “sacrificio” di Gesù non è affatto la vendetta di Dio sulla vittima più pura, trattato come capro espiatorio, ma è la forza dell’amore con cui Gesù sfida il male perdonando anche chi glielo infligge, affinché non ci sia più alcuna vittima sacrificale.
Va risolta totalmente, nelle religioni, l’ambiguità grave dell’idea di sacrificio, che significa varie cose opposte: distruggere altri per salvare sé (sacrifici religiosi di animali o di umani); esporre sé per salvare altri (il coraggioso che annega per salvare qualcuno); autodistruzione (mortificazione) in omaggio ad una divinità di morte, che si eleva sulla riduzione delle creature.
C’è chi propone di archiviare la parola sacrificio, troppo ambigua e deviante (anche nell’uso che ne fa la retorica della patria in guerra, o l’ideologia dello sviluppo materiale infinito!).
C’è chi la intende in tutt’altro senso: “sacrum facere”, cioè rendere sacra, guardare e trattare come inviolabile e preziosa, ogni creatura e ogni cosa della vita.
Dopo la ricca relazione di Marco Scarnera sulla nonviolenza evangelica (nel ciclo seminariale del Centro Studi Sereno Regis sulle varie spiritualità della nonviolenza), e dopo la discussione seguitane, ho annotato e raccolto qualche appunto in tema. (27 maggio 2010)


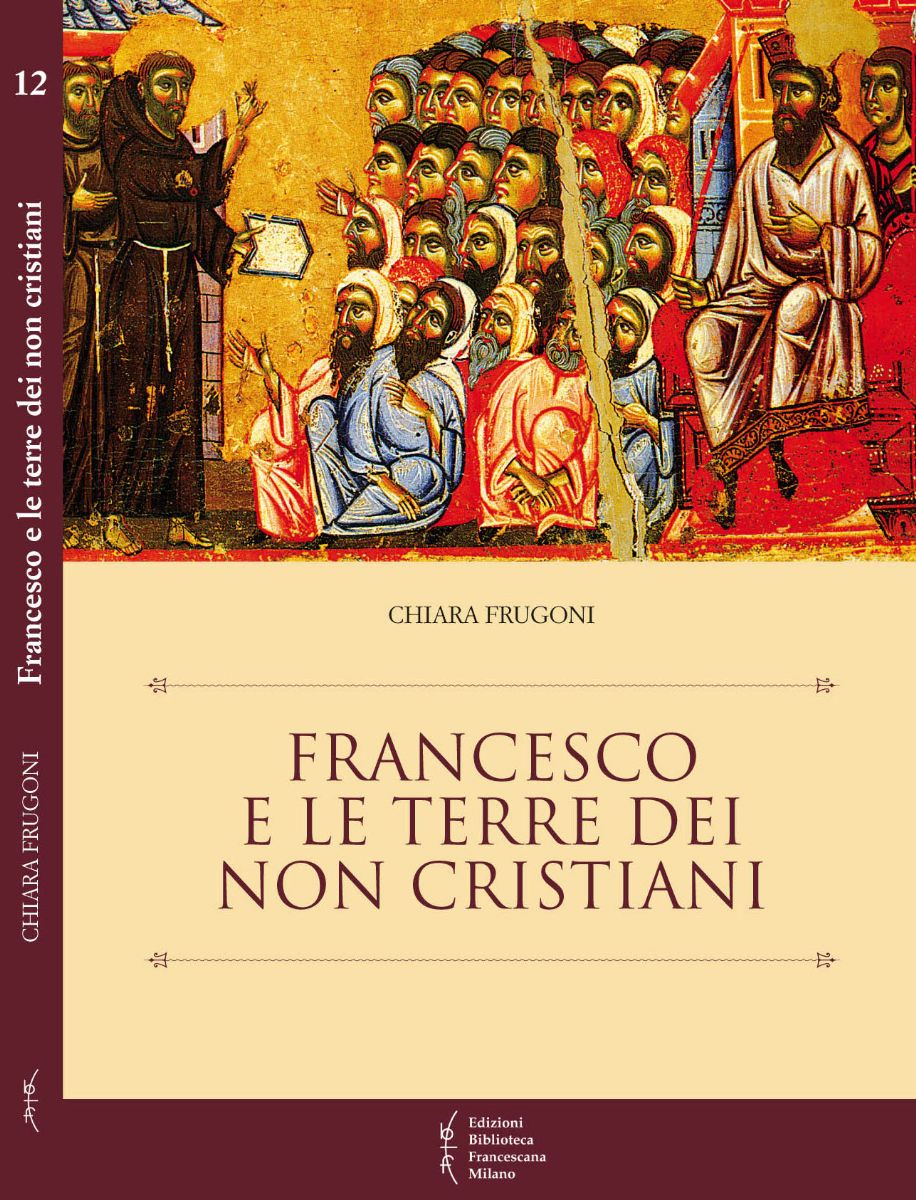





















Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!