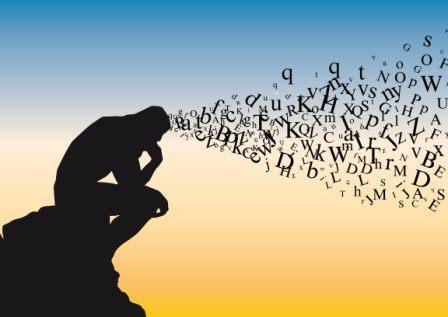Pensiamo la diminuzione. L’apporto del nichilismo nell’ambientalismo scientifico – Recensione di Marco Scarnera
SI SPEGNE, SIGNORI, SI CHIUDE. L’era della diminuzione
XL edizioni – 2008
(pp. 314 – € 15,50)
La fine della violenza: questa sì, meriterebbe forse davvero da sola la scelta di procreazione
Giuliano Cannata
Nonostante l’abbrivio demografico e l’approdo antropologico, a guidare la stesura del recente libro di Giuliano Cannata è stato un interesse squisitamente filosofico, come viene attestato nella conclusione: “Non si è fatto che parlare del senso: si è finito, ora, per rassegnarsi a quell’unico senso (ma a posteriori!) che alla vita viene dalla sua qualità” (p. 289). D’altronde l’esordio indica subito la direzione del discorso, senza ambiguità: “E un giorno all’improvviso fu chiaro che ‘la specie umana’ si prendeva il controllo cosciente del suo destino: perché stava cominciando a ‘scegliere’ (in modo frantumato e confuso, si intende) tra le strade biforcate sulle quali l’aveva sempre lasciata il caso, nella lunga storia dell’evoluzione della specie, tutta e ciecamente casuale in senso biologico (anche se ‘necessaria’ nelle decisioni individuali). Questa scelta era molte cose assieme: ma una su tutte, la diminuzione delle nascite, coi suoi effetti pratici enormi e forse anche con un elemento nuovissimo di significato, che potremmo chiamare con il nome pesante di rifiuto. O di bisogno inconscio di condizionare la decisione di aver figli, oltre che alle difficoltà pratiche, a qualcosa che la vita deve darci in cambio (vien voglia di dire, razionalizzando: una ragionevole speranza di qualità). Quella riluttanza dal procreare, che sta dietro alla drammatica statistica di 1,3 o 1,5 figli per donna, si potrebbe infatti anche intendere come incertezza sulla bontà del vivere, tanto pare evidente nella scelta di non generare la proiezione del desiderio di non nascere, il rimpianto” (p. 11). In tale cornice la chiave del nichilismo, articolato in tre fasi schematiche, si dimostra efficace per penetrare nel cuore della trattazione.
Innanzitutto l’autore accoglie la rottura di Nietzsche a scapito della tradizione occidentale. Con la disgregazione dei fondamenti e col dilagare della secolarizzazione la verità perde ogni riferimento oggettivo e si offre come una costruzione puramente convenzionale: “La crisi dei valori, proprio la rimozione dei valori delle categorie della conoscenza, è ciò che dà senso al mondo” (p. 226). Pertanto l’uomo – non più sostanza né soggetto – diventa espressione della volontà di potenza in un illimitato processo di autosuperamento: “Se la vita umana è solo cultura, e se la cultura governa ormai l’evoluzione, allora è già doppio, e autoinnescato, il meccanismo che farà i nuovi individui con la loro volontà di potenza, il superuomo tra essi” (p. 242).
Quindi l’affermazione delle scienze impone un sistema tecnologico su scala planetaria, al quale i singoli rimangono funzionali. Ma in questa maniera il progresso delle facoltà creative si rivela direttamente proporzionale al pericolo della distruzione: “Molte delle trasformazioni biologiche o fisiche indotte sono ‘inutili’, non hanno cioè riscontro in un vantaggio per la specie dominante o per i suoi individui, risultano anche gratuitamente distruttive. Per loro gratuito effetto scompaiono rapidamente migliaia di specie, cambia rapidamente la forma e la superficie della terra, la copertura vegetale, la composizione dell’aria e dell’acqua; il clima sopporta apocalittiche minacce. In questo quadro allora sembra che gli esseri umani non abbiano fatto altro che portare al mondo fisico l’attacco cieco – l’aggressività, la sete di sangue – che governa le loro pulsioni profonde, verso i propri simili e verso tutte le cose, sentite sempre in qualche modo nemiche. Come la realtà circostante condizionasse poi il mancato riconoscimento delle diversità e della parità (con la divisione di ruoli familiari), anziché esserne condizionata dall’azione umana, rammenta la possibilità (il sogno) d’una seconda diversa antropizzazione della terra” (p. 226).
Infine negli ultimi vent’anni la diminuzione della fertilità, consentita dagli strumenti di controllo delle nascite sempre più diffusi non solo nei Paesi ricchi, caratterizza un’autentica svolta epocale: l’umanità è in grado di programmare il proprio annientamento. Dunque varrà ancora la pena trasmettere la vita? “Un’estetica superiore d’improvviso giudicherà insufficiente la qualità della propria esistenza, e non avrà (nell’inconscio) più alcuna voglia di impegnarsi a difenderla; anche se a livello razionale, per trovare un minimo di coerenza, un posto plausibile in un’umanità come la nostra, dovrà sostenere il cliché del nobile impegno umanitario: ma in un mondo senza più bisogni forse non c’è neanche bisogno di giustizia. O non lo sosterrà affatto: non trovando nessun motivo di dedicazione” (p. 139). “Ridotto all’osso il dilemma” è il seguente: “Quanto sei disposto a pagare per la tua ebbrezza, a far pagare a un ‘innocente’ che non ti ha autorizzato a decidere per lui?” (p. 143).
Se la morte di Dio sigla la prima fase del nichilismo e la catastrofe atomica impronta la seconda, l’autoestinzione simboleggia la terza. Tuttavia sarebbe un errore attribuire la negatività di queste figure ad un irrevocabile pessimismo rinunciatario e senza speranza. Anche se “il ‘male’ esistenziale di fondo è pur sempre la decadenza e la morte” (p. 255), la questione tragica (amletica) rimane aperta: “Come la qualità decide, orienta, la scelta sul diritto individuale di non esistere, di non essere nato (sul quale fonda evidente il transfert di non procreare), così il benessere, la salute, la mancanza di bisogni, di menomazioni, di handicap, frutto del proseguimento dell’evoluzione culturale straordinariamente positiva, giustifica il giudizio (che ora volge al positivo, almeno fino a una certa età) dato sulla nascita” (p. 239).
Infatti l’originalità dell’analisi si percepisce esattamente nel luminoso presagio dell’era della diminuzione. In essa il governo del futuro sarà sempre più agevole, grazie alla condizioni della popolazione relativamente stazionarie, quindi prevedibili; e le ragioni del sì alla vita risiederanno nella bellezza, intesa ora come il bene (naturale e artificiale) della fruizione individuale ora come il prodotto della pianificazione collettiva: “tra i ‘valori’ di qualità che Nietzsche ha proposto, e tra quelli di ‘senso comune’ che non ha respinto, è la bellezza, sicuramente, il più universale” (p. 183). “Sta nella qualità, come detto all’inizio, nel contenuto di ‘felicità’ che tutto giustifica e paga, la sua desiderabilità in assoluto (…); allora riprendono senso, diritto di verifica, le esortazioni umanitarie, umanistiche etc. a qualcosa come il dover essere, gli altri, il compito ineludibile della ragione valorizzante… Possiamo per semplicità classificare separatamente (a) le qualità di lettura razionale (scoprire i bisogni reali economicamente fattibili) e quella (b) inconscia, del regno del piacere (Aut aut). Dalla prima si scende fino alla sfida della pianificazione (non ci si accontenta di ciò che esiste ‘ora’: la qualità è misurata, apprezzata, sulle possibilità di seguire virtute e conoscenza, collettività di interessi, democrazia). Della seconda si esalta la liberazione di godimento estetico, l’affiorare quotidiano della libido” (p. 194).
A questa sintetica presentazione annetto alcune considerazioni, senza pretesa di organicità, però non troppo disparate.
Una prima annotazione si muove sul terreno teoretico; ovviamente non si tratta di un rimprovero, ma di una constatazione: in base alla limpida lezione di Heidegger (profondo interprete di Nietzsche anche per Giuliano Cannata), la dottrina della volontà di potenza si struttura come un rovesciamento del platonismo. In questi termini dunque sembrerebbe… fecondo rilevare il nesso tra l’inizio e la fine della metafisica, accostando l’indimenticabile sentenza di Sileno al sublime insegnamento di Diotima: da un lato “Stirpe miserabile ed effimera, figlia del caso e della pena, perché mi costringi a dirti ciò che per te è vantaggiosissimo non sentire? Il meglio è per te assolutamente irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma la cosa in secondo luogo migliore per te è – morire presto” (in Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi, 1984, p. 31/2); dall’altro lato “Poiché dunque l’amore è sempre questo [desiderio di possedere il bene per sempre], in quale modo e in quali azioni lo zelo e la tensione di coloro che lo perseguono, possono essere chiamati amore? Quale sarà mai questa azione? Lo sai? (…) Te lo dirò io allora – è la procreazione nel bello, secondo il corpo e secondo l’anima” (in Platone, Simposio, 206 b, Editori Laterza, 1982, p. 185/6). Così – forse non del tutto inaspettatamente – l’ambientalismo, proprio con la sua vivida aspirazione alla bellezza, rientrerebbe a pieno titolo nella melète thanàtou, ossia nella preparazione o cura o meditazione di morte, come Platone definisce la filosofia nel Fedone (81 a).
Una catena di interrogativi si dipana lungo il piano politico: se la storia è un museo degli orrori, come il testo suggerisce più volte, la pianificazione razionale è compatibile con la dissennata efferatezza della specie umana? L’autore stesso ammette: “La scarsità materiale così spesso creata artificialmente (le guerre, il sacrificio, le sanguinose ricchezze votate alla divinità, i bisogni artificiali, le nuove povertà di posizione, la rendita creata e sottratta) era necessaria al dominio. (…) C’è chi teme che la raggiunta abbondanza (di produttività e di diminuzione demografica) non abbia scalfito il potere dei grandi poteri economici o delle lobbies internazionali, o quelle incrociate di potenti e di paesi potenti (…)” (p. 194). In tale prospettiva il ruolo dell’antropologia della diminuzione si riduce a quello di un ideale regolativo che indica all’umanità ciò che potrebbe essere, ma non è né mai è stata? Quale rivoluzione o quale evoluzione occorreranno, affinché le coscienze si accordino nella splendida dichiarazione citata in esergo: “La fine della violenza: questa sì, meriterebbe forse davvero da sola la scelta di procreazione” (p. 214)?
Un’ultima osservazione fa breccia nella sfera privata: le pagine del saggio pullulano di rimandi eruditi, non di rado impliciti. Però la fatica del loro riconoscimento si attenua, quando li recepiamo come i segni di una confessione; quasi che, affidandosi alla nostra amichevole comprensione, lo studioso avesse voluto trasmettere almeno una frazione della sua vasta esperienza con toni non tronfi e paternalistici, semmai umili e paterni, e consegnare un messaggio di mitezza, di ragionevolezza, di nostalgia. Ne porgo solo un esempio: “quell’ambientalismo” (ovvero quello che ha contribuito a sviluppare in tanti anni di impegno) “doveva tener conto della contraddizione della felicità, la bellezza estetica (e quella carnale) e il nobile e il giusto, il dolce dolore del ricordo e l’angoscia del tempo perduto. L’avvento della giustizia spinto sempre troppo lontano, ma la pace, il pacifismo presente, toccabile, nel dolce soffio del femminismo trionfante” (p. 253). Perciò in questa luce appare paradossale il richiamo alle monadi per documentare l’invincibile isolamento interpersonale. Benché ogni mortale si ritrovi unico e solo di fronte al proprio destino, nel suo dialogare coabitano tanto l’esclusione e l’incomunicabilità quanto la partecipazione e la solidarietà: dal recinto della parola si può sprigionare la condivisione, nella quale proviamo che “chi non vive per gli altri, non vive neanche per se stesso” (p. 278), secondo la toccante testimonianza di Giuliano Cannata. Qui risuona l’eco della domanda che retrocede nel silenzio della meraviglia e rinnova il bel rischio della ricerca.