La fine del neo-liberismo? – Jake Lynch
 E’ un segno dell’insana alleanza fra giornalisti e classi politiche che ci venga detto così sovente che c’è nell’aria un cambiamento radicale, epocale. Le ere vengono regolarmente concluse. Ogni elezione rappresenta una scelta storica, anche quando le differenze fra i partiti sono relativamente lievi. Ogni conflitto mette in gioco la nostra stessa sopravvivenza, quando in effetti ci sono molte misure sensate che potremmo facilmente prendere per ridurre qualunque pericolo abbiamo di fronte. Al passo con tale eccitabile tendenza, il neo-conservatorismo, la dottrina Bush di politica estera USA interventista, è stata dichiarata morta, con il trionfo di Barack Obama nella gara per la Casa Bianca; ma in quanto al neo-liberismo?
E’ un segno dell’insana alleanza fra giornalisti e classi politiche che ci venga detto così sovente che c’è nell’aria un cambiamento radicale, epocale. Le ere vengono regolarmente concluse. Ogni elezione rappresenta una scelta storica, anche quando le differenze fra i partiti sono relativamente lievi. Ogni conflitto mette in gioco la nostra stessa sopravvivenza, quando in effetti ci sono molte misure sensate che potremmo facilmente prendere per ridurre qualunque pericolo abbiamo di fronte. Al passo con tale eccitabile tendenza, il neo-conservatorismo, la dottrina Bush di politica estera USA interventista, è stata dichiarata morta, con il trionfo di Barack Obama nella gara per la Casa Bianca; ma in quanto al neo-liberismo?
Il neo-liberismo è il corpus di prescrizioni politiche derivanti dalla diagnosi dei mali economici fatta dalla teoria ortodossa. E’ una chiesa vasta, ma generalmente caratterizzata dalla fede nel potere dei mercati, sicché ampi settori di beni e servizi pubblici sono stati monetizzati, mercatizzati e liberalizzati da politici persuasi o costretti ad applicarne i rigori. Gli studiosi di neo-liberismo si riferiscono alle due fasi di riflusso ed estensione: tali politiche determinarono il riflusso della democrazia sociale nel mondo ricco durante gli anni ’80 e furono quindi estesi al resto del mondo, mediante le Istituzioni Finanziarie Internazionali, negli anni 1990 e oltre.
I notiziari traboccano di previsioni funeste – uno dei vari vezzi giornalistici – ora per graziosa concessione del Fondo Monetario Internazionale, che ammonisce che la crisi finanziaria globale degli ultimi sei mesi sta per inasprirsi in una profonda recessione mondiale che porterà i suoi guai almeno a tutti i paesi sviluppati. Milioni di persone hanno ora di fronte la perdita della casa e del lavoro come risultato finale di una sequenza di avvenimenti che cominciarono con la vendita senza freni di credito, un mercato entusiasticamente deregolato dai governi seguendo le politiche neo-liberiste. E’ ormai un luogo comune osservare che i mercati possono essere un bravo servitore ma, in questo caso, un pessimo padrone.
I titoli delle prime pagine di ieri nei due quotidiani a grosso formato in vendita qui a Sydney catturavano, fra le righe, qualcosa dello zeitgeist (lo spirito del tempo) politico. Il Sydney Morning Herald annunciava che il governo laburista di Kevin Rudd doveva “passare all’azione sulla paga dei capi”. Lo scontento per l’eccessivo compenso degli alti dirigenti era da un po’ un segnale di perdurante consapevolezza sotterranea, anche in tempi d’abbondanza, che il sistema di spartizione dei rischi e delle gratifiche era in qualche modo fuori sintonia con le aspettative pubbliche.
Ormai il caso AIG, l’American Insurance Group, di fronte alla rovina, poi al salvataggio grazie a un colossale riscatto addossato ai contribuenti, poi prontamente passato a 250 milioni di $ di denaro pubblico in gratifiche ai dirigenti, stava a simboleggiare i mali del giorno. A Washington, il presidente Obama acquisiva scioltezza per affrontare la tematica, mentre Rudd mandava il suo segnale che le cose dovevano cambiare. Salvo che, in questo caso, l’azione risultava gravare sugli azionisti, cui si doveva dare “più potere per controllare l’entità dei pagamenti di fine rapporto dovuti ai dirigenti”.
Lì accanto in edicola, il quotidiano Australian aveva un’angolazione diversa. “Crisi finanziaria alla costruzione della nazione” raccontava dei piani del governo di divincolarsi dall’incombente recessione investendo prioritariamente in progetti infrastrutturali. Con un problema – “una carenza di finanziamenti resi disponibili dal settore privato”. In un articolo laterale, il giornale si concentrava in particolare su un progetto di massima di sviluppo residenziale di lusso su un’ambita fetta di terreno edificabile a Brisbane. Il responsabile dello sviluppo veniva sottoposto a pressione affinché accendesse un prestito da un fondo governativo speciale per l’immobiliare commerciale, ossia la “banca Rudd”, ma adesso era riluttante per lo squagliarsi delle prospettive di acquirenti per gli appartamenti una volta costruiti. Il Tesoriere Federale, Wayne Swan, si era ridotto, diceva il giornale, ad “appellarsi al mantenimento del flusso del credito” nell’economia australiana, tentando di sostenere le proprie idee.
Il quadro qui, come altrove, fa tornare in mente il famoso commento di Christopher Hitchens sulla cosiddetta terza via seguita dall’amministrazione Clinton che cercava di fare concessioni politiche sia a destra che a sinistra: però, scrisse Hitchens “la sinistra ottiene parole, la destra fatti”.
Gli schianti elastici
Alcune settimane fa, una delle prime vittime eccellenti della scivolata economica fu una società di nome Pacific Brands, che gestiva parecchie fabbriche australiane di biancheria intima, principalmente per il mercato nazionale. Per mantenere in funzione la fabbricazione qui piuttosto che esportare la lavorazione in Cina, riceveva sovvenzioni plurimilionarie in dollari dal governo. Il mese scorso annunciò che sette suoi stabilimenti dovevano chiudere, con la perdita di 1.850 posti di lavoro. Sei dei sette erano effettivamente in perdita, mi disse un portavoce aziendale, mentre il settimo, meglio noto come quello delle mutande alla Bond, “non andava abbastanza bene da tenerlo aperto”.
Nella logica del neo-liberismo, va così. Le spiegazioni dell’azienda all’epoca si addensavano sulla necessità di “ristrutturarla”. Potrebbero continuare a lottare per una produzione redditizia in Australia, lasciavano capire, ma il denaro investito negli stabilimenti poteva rendere di più altrove. Domanda, allora: il governo australiano avrebbe potuto – e dovuto – rilevare le fabbriche in proprietà pubblica, magari considerando le passate sovvenzioni come un anticipo per impianti e macchinario?
C’è una clausoletta fastidiosa nella costituzione australiana che proibisce al governo federale di fare alcunché interferisca nel commercio fra gli stati, che è talvolta invocata come ragione d’inazione in tali circostanze, ma questo è leggermente fuori tema. La proposta di nazionalizzare l’industria suona bizzarra perché contraddice tutto quanto ci è stato detto su come funziona l’economia per una generazione o giù di lì.
Al tempo stesso un sondaggio d’opinione commissionato dal ACTU – consiglio australiano dei sindacati – mostrava che una maggioranza d’intervistati volevano più intervento a protezione dei posti di lavoro. Questo in un contesto di dibattiti sulla promessa del governo Rudd di abrogare le norme antisindacali introdotte dal suo predecessore, la coalizione Liberal (conservatrice), e il mercato delle vacche richiesto per far passare la nuova legislazione al Senato, dove i Laburisti non hanno una maggioranza netta, cosa infine avvenuta, permettendo ai ministri di corrispondere in tre punti chiave all’opinione pubblica, come riflessa nel sondaggio ACTU:
• * 77% degli australiani sono per il ripristino delle protezioni dai licenziamenti iniqui per tutti i lavoratori;
• * 74% sono per i diritti di contrattazione collettiva per tutti i lavoratori;
• * oltre 3/4 (76%) degli australiani vogliono liberarsi dalle norme che impediscono ai lavoratori l’accesso a consulenza sindacale sul posto di lavoro.
Queste sono protezioni importanti, ma nel contesto dell’assalto neo-liberista dei tre decenni scorsi equivalgono a poco più che armeggiare ai margini. Intervenire in modo tale da contrastare i segnali che i prezzi stanno mandando in un “libero mercato” – risparmiare le mutande Bonds all’Australia, in questo caso – sarebbe stato affrontare direttamente il neo-liberismo, esentando il governo Rudd dal dileggio trasmesso dalla formula Hitchens.
Il guru economico più influente dei tempi recenti, Milton Friedman, sottolineava il ruolo dei mercati nello svolgere tre compiti importanti: trasmettere informazioni, allocare risorse e distribuire redditi. Quando Friedman morì nel novembre 2006, la Crisi Finanziaria Globale (CFG) era una nuvoletta su un orizzonte lontano. Però tutto quanto è successo da allora dovrebbe indurci a mettere in questione i suoi dogmi.
La struttura altamente incentivata dei servizi finanziari ha portato torme di venditori in cerca di gratifiche, a indurre i consumatori ad assumersi più debiti di quanto potessero permettersi. Non solo non c’era nulla a fermarli, a causa del falò di regolamenti nel settore, ma la dinamica del mondo aziendale attorno ad essi effettivamente imponeva un tale comportamento. Will Hutton, lo scrittore britannico di economia, ora Amministratore Delegato della Work Foundation, spiega come in un ambiente aziendale come quello prevalente in GB, USA e Australia ogni società sia implicitamente ‘in gioco’, appena collezioni un insieme di cattivi risultati, dall’essere soggetta a un tentativo di acquisizione ostile. Il denaro scottante – “capitale a piede libero” lo chiama lui – scova i più alti ritorni a breve, e prima della stretta creditizia che presagiva la CFG, di quello ce n’era in abbondanza.
Nel suo libro The World We’re In [Il mondo in cui siamo], Hutton fa la cronaca delle fortune di General Electric, che conseguì 80 trimestri consecutivi di crescita dei profitti, con il suo leggendario Presidente e Amministratore Delegato, Jack Welch, che presiedette a un decuplicarsi del valore di mercato della GE, ma la trasformò intanto “in una società per metà manifatturiera, per metà di servizi finanziari”. Contemporaneamente, la spesa per ricerca e sviluppo, un tempo fulcro della vitalità aziendale, calò sotto la media aziendale USA e continuò a declinare.
Questa è una delle debolezze della teoria economica ortodossa. La sua contabilità di come i mercati distribuiscono redditi non bada minimamente ai conflitti strutturali come quello intergenerazionale. Nei decenni scorsi, patrimoni accumulati pazientemente in ere precedenti sono stati dilapidati in una gigantesca scorreria nei salvadanai. Nei paesi neo-liberisti di ceppo anglofono, si sono privatizzate imprese statali, de-mutualizzate casse di risparmio e de-stratificate [=smontate nella loro integrazione verticale], frammentate e subappaltate fabbriche – tutto in nome della riduzione degli ostacoli operativi per i liberi mercati. Il che lascia i governi che vogliano investire nel tessuto dei propri paesi – in case, strade, ospedali e scuole – alla mercé del capitale privato, come ha scoperto Swan a sue spese.
Questo è stato, ci ricorda Hutton, un progetto politico, grevemente influenzato dalle lobby d’affari, noto anche come la “rivoluzione del valore per l’azionista”. Si considera spesso un famoso discorso dello stesso Welch, Growing fast in a slow-growth economy [Crescere velocemente in un’economia a crescita lenta], fatto a New York nel 1981, come contributo fondamentale al dibattito. Il pesante adeguamento del compenso dello stesso Welch verso le opzioni di quote-capitale caratterizzò il nuovo “allineamento”, registra Hutton, fra gli interessi dei dirigenti e degli azionisti.
Ora, emergendo, a luci lampeggianti, all’altro capo di tale viaggio, gli sbalorditivi riscatti a spese dei contribuenti di filiere di servizi finanziari stanno effettivamente ipotecandoci il futuro. La percezione di un affare bacato, già scritto a caratteri cubitali nella cosiddetta rivoluzione dei 700 euro in Grecia – dove perfino laureati competenti sono stati costretti a contemplare una vita di lotta con paghe stentate – può solo crescere.
I governi e i legislatori più audaci esigono qualche assicurazione in cambio del denaro. Il parlamento USA ha approvato leggi per tassare le gratifiche AIG a tassi del 90 o anche 100% – dopo tutto, si sono detti i deputati, possediamo ormai i quattro quinti dell’azienda, e allora che altro ci vuole? Come si vede, nazionalizzando si possono dettare i termini.
In Australia, Rudd ha concesso una garanzia, ineguagliata ovunque al mondo, per cui il suo governo ripagherà il 100% dei depositi bancari se qualunque istituto finanziario avesse guai seri, e la gente comincia a ritirare i suoi soldi. Questo, combinato con l’effettiva spesa di 8.000 milioni di $ australiani di fondi pubblici in titoli ipotecari, ha fatto sì che lo champagne continuasse a scorrere nel Quartiere Alto di Sydney, noto anche come CBD (Central Business District, Quartiere centrale degli affari) di Sydney – dove il settore finanziario letteralmente torreggia sui passanti. (Una minuscola frazione di tale generosità sarebbe bastata a mantenere le operaie di Bonds alle loro macchine da cucire).
Nonostante ciò, il governo se n’è stato mitemente in disparte mentre la banca ANZ esportava 500 posti di lavoro amministrativi a Bangalore recentemente; e questo dopo l’annuncio di 3.300 milioni di $ australiani in profitti annui e previsioni di ulteriore crescita dei guadagni perfino nel tormentato primo trimestre di quest’anno.
Jack Welch ha rilasciato un’intervista nel corso di questo mese al Financial Times, in cui sconfessava la sua dottrina precedente: “A quanto pare, il valore per l’azionariato è la più stupida idea al mondo; è un risultato, non una strategia… I principali sostenitori di un’azienda sono i suoi dipendenti, i suoi clienti e i suoi prodotti”, ha detto poco prima che fosse confermato che General Electric aveva perso la sua classifica di fido triplo-A da Standard&Poor.
La deificazione dei liberi mercati alla Friedman ha condotto a massicce pessime allocazioni di risorse e maldistribuzioni di reddito e ricchezza, e ne continueremo a pagare il prezzo per molti anni a venire. Un precedente governo laburista australiano, quello riformatore e per certi aspetti radicale di Gough Whitlam, prese il potere negli anni 1970 dopo una campagna imperniata sul semplice ma efficace slogan E’ ora. Chiaramente è di nuovo ora, sia in Australia che altrove. La domanda è: per cosa?
23.03.09
Traduzione italiana a cura di Miky Lanza per il Centro Sereno Regis
Titolo originale: THE END OF NEO-LIBERALISM?
http://www.transcend.org/tms/article_detail.php?article_id=1005




















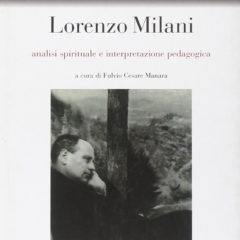
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!