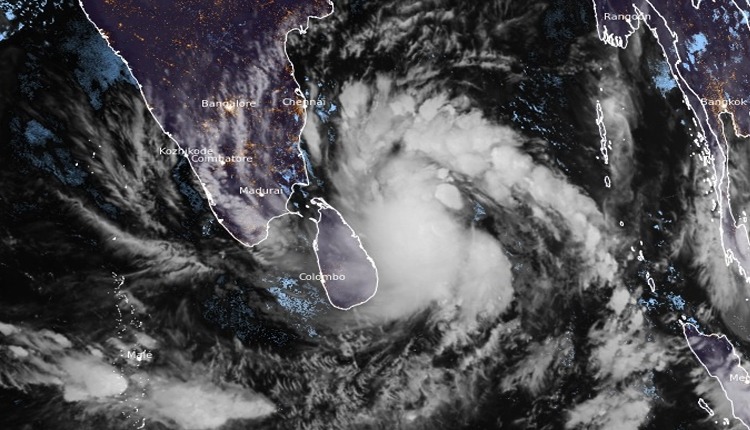Mumbai. Quanto è reale il reale?
Riuscite a immaginarvi coinvolti nell’attacco alla città indiana di Mumbai? Se sì, come? Quali immagini richiamate all’occhio della mente, e da dove provengono? Un tale supplizio è per la gran parte di noi, fortunatamente, remoto dalla propria esperienza personale o sociale. È, per usare un termine gergale accademico in voga, “incommensurabile” negli ambiti di riferimento fornitici dalla quotidianità.
Così attingiamo alla nostra esperienza mediata per aiutarci a figurare la situazione, forse le messe in scena sensazionalistiche di 24, in cui Kiefer Sutherland dirige un’unità antiterroristica con base a Los Angeles, o il film in versione originale Die Hard, con ostaggi tremebondi di paura del malvagio Alan Rickman, mentre il poliziotto di New York Bruce Willis agisce in solitaria per macchinare infine il loro rilascio.
Per il vasto pubblico indiano, A Wednesday, che vede Naseeruddin Shah chiamare un commissario di polizia pensionando, recitato da Anupam Kher per dirgli che ha installato bombe in 5 posti attorno a Mumbai, fornisce un vivido senso di panico e catastrofe per strada. I cinefili avevano già avuto l’esperienza sconvolgente di vedere lo scenario di un giallo d’azione, Contract, rappresentato quasi al pelo nella realtà una settimana dopo con le bombe di Ahmedabad, dove attacchi a bassa intensità erano un preludio ad altri più gravi agli ospedali che ricevevano i feriti.
Il massacro di Mumbai, in altri termini, ha introdotto la condizione postmoderna, ed è all’iper-realtà (altro vezzo accademico) di celluloide che ci rivolgiamo per cavarne un senso. I codici e le strutture di significato fornite da Hollywood e Bollywood integrano quelli dei notiziari e dei discorsi politici per metterci in grado di trarre un qualche senso da eventi così estremi e sconvolgenti.
Quali sono più reali? Il giornalismo, dopo tutto, presumibilmente ci racconta che cosa è successo – chi, che cosa, dove, quando, perché e come. Ma anche i giornalisti decodificano frammenti d’informazione secondo strutture di senso bell’e pronte, che interiorizzano come convenzioni, o valori informativi, uno dei quali è il primato delle fonti ufficiali del proprio paese (vedi Che cos’è il giornalismo di pace pubblicato nella Newsletter n.45).
La polizia permette l’accesso e rilascia particolari sull’operazione, e i politici fanno dichiarazioni, e tutto quanto plasma i fatti in arrivo dal mondo esterno secondo i propri interessi, i quali possono indurli a rendere illeggibili intere parti della storia comportandosi come se non fossero mai esistite. Una di queste è la motivazione degli sparatori. Perché abbiano colpito, perché proprio adesso, perché a Mumbai e perché questi bersagli specifici? Il governo indiano è fra i molti che negli anni recenti si protendono verso la spiegazione che il proprio paese è divenuto vittima di estranei malintenzionati, proprio come le autorità marocchine hanno incolpato il “terrorismo internazionale” degli attentati a Casablanca del 2003, e Tony Blair attribuì le bombe di Londra nel 2005 all’influenza maligna delle “reti di terrorismo” situate nel lontano Pakistan – e qui cominciano ad annodarsi alcuni bandoli sparsi.
In entrambi quei primi casi c’era una chiara motivazione per far circolare spiegazioni alternative a quella ovvia, ossia che era in parte da incolpare la loro stessa politica. La stridente povertà delle bidonville e dei villaggi del Marocco avrebbe potuto essere progettata apposta come centro di reclutamento per coloro con messaggi politici disperati, specialmente dove si potevano additare contrasti con l’opulenza dello stile di vita degli espatriati che, come a Mumbai, sembrava essere il punto focale degli attacchi. E le esplosioni attuate nella metropolitana londinese da giovani islamisti britannici avrebbero potuto avere qualcosa a che fare con la decisione di Tony Blair di unirsi all’invasione a guida USA di due paesi musulmani, Iraq e Afghanistan?
L’ultima ipotesi era che Blair fosse caduto in errore annullando la distinzione fra lo spiegare e lo scusare l’atrocità, per cui qualunque tentativo di sollevare la questione del perché sarebbe stato automaticamente visto come sospetto. Tali atti sono ufficialmente caratterizzati, dice il romanziere Gore Vidal, come esempi di malignità immotivata. Ma è qui dove la notizia si separa dal reale. Le banalità di Blair giunsero dopo che un sondaggio di un quotidiano nazionale mostrava che la vasta maggioranza dei britannici vedeva gli attentati come “contraccolpo” alla sua politica estera.
Nel caso di Mumbai, l’autore e commentatore Tariq Ali ha confutato la teoria dell’”esterno maligno” come “edificio meditato dell’immaginazione politica dell’India ufficiale”, facendo notare alcune fra la miriade di lamentele che potrebbero plausibilmente formare lo sfondo dello sconquasso. Il Kashmir fornisce forse l’esempio da manuale di dove l’energia politica fosse intralciata, e successivamente abbia trovato espressione in una resistenza violenta. Yousuf Shah, cui fu negata la vittoria nell’elezione truccata del 1987, in seguito emerse come Syed Salahuddin, capo dei Hizbul Mujahideen e capo del Consiglio dei Jehadi Uniti. Il dominio indiano sulla sua parte di territorio si basa sulle norme dello stato d’emergenza, che permettono arresti e detenzione arbitrari. Come fa notare Ali, le violazioni di diritti umani sono comparabili con quelle del Tibet, ma hanno suscitato in confronto a mala pena un gemito di protesta nelle capitali occidentali.
Si è rimarcato in certi racconti che i bersagli a Mumbai erano quelli che avevano a che fare con gli USA e la Gran Bretagna, con gli assalitori che acciuffavano appunto loro cittadini in alberghi di lusso. A partire da luglio ha avuto corso una furtiva invasione del Pakistan, con forze armate USA in Afghanistan agenti per espresso ordine del presidente Bush di attraversare la frontiera a piacere. Le tipiche incursioni aeree di droni Predator ed elicotteri da battaglia inevitabilmente infliggono perdite civili, sicché, se gli assalitori sono effettivamente venuti dal Pakistan o avevano a che fare in qualche modo con quella situazione, gli attacchi potrebbero essere stati proprio azioni di rappresaglia (con i britannici colpevoli, in quanto alleati numero uno, di fornire copertura politica agli attacchi contro i taliban nonché sostegno militare).
Poi l’hotel Taj Mahal poteva offrire un bersaglio sensato di per sé, in quanto posseduto dal gruppo Tata, che ha cercato di dirottare la produzione della sua nuova auto, la Nano, dal Bengala Occidentale al Gujarat, il cui governo statale è stato accusato di violare le sue stesse leggi per far posto al progetto – ed è quello stesso governo, pur sotto altra guida, che fu connivente con l’orribile violenza settaria contro i musulmani non più tardi del 2002. Intanto sul territorio – lamentela ben nota – la costruzione della fabbrica Tata costringerà a sfollare poveri contadini, allargando il divario fra i possidenti e i non. Con le parole di Tariq Ali:
“La nozione assurda che gli effetti di sgocciolamento del capitalismo globale risolverebbero gran parte dei problemi può ora essere vista per quello che è sempre stata: una foglia di fico per dissimulare nuove modalità di sfruttamento”.
E questa, in breve, è la causa che spinge la ribellione dei Naxaliti maoisti, descritta dal primo ministro indiano Manmohan Singh come la più grave minaccia alla sicurezza con cui il paese debba confrontarsi oggigiorno.
Come faccio a sapere che una di queste ingiustizie abbia motivato gli attacchi di Mumbai? Non lo so, naturalmente, e comunque comportamenti sociali complessi non sono mai mono-causali. Sono conscio che la stessa iterazione di istanze di giustizia in collegamento con gli eventi dei giorni scorsi costituisca uno dei codici convenzionali che usiamo per interpretare tali perturbazioni; che la speculazione da parte degli attori sulle probabili interpretazioni dei propri atti che verrà fatta dalla gente rientra sempre nel loro calcolo strategico e che pertanto la realtà e la sua rappresentazione sono inestricabilmente intrecciate.
Allora siamo alla deriva, tagliati fuori dai fatti e con libertà da autore cinematografico di creare la nostra realtà con il solo limite della nostra immaginazione? Se fosse così, a cosa servirebbe il giornalismo, che dovrebbe raccontare i fatti? Ci sono alcuni indicatori di valore permanente. Uno è quello che Johan Galtung chiama l’ipotesi generale che atteggiamenti e comportamenti in conflitto sono in fondo reazioni a contraddizioni soggiacenti, e che ogni racconto di un conflitto che le ometta, come fanno molti commentatori nei notiziari e in politica, è perciò fuorviante.
Un altro è la nozione dei bisogni umani. Abbiamo tutti bisogno di aria da respirare e cibo da mangiare, ma anche di opportunità per sperimentare la nostra identità e che venga rispettata dagli altri. Il Kashmir, solo per dirne una, è un luogo dove tale bisogno è stato sistematicamente negato e, dato che i bisogni sono non-negoziabili, è ragionevole ritenere che la gente cercherà di soddisfarli con qualunque mezzo necessario. Poi, la motivazione all’aggressione è acuita dalle privazioni relative: quando le ingiustizie si ampliano, la società diventa più violenta – analisi tutte sostenute da vaste ricerche sociali.
Il cibo che i contadini poveri non possono più coltivarsi quando sono espulsi da progetti di sviluppo, e le strade rese intransitabili dagli attacchi aerei USA, appartengono a quella che si chiama dimensione intransitiva – esperienze percepite dalla gente indipendentemente dall’interpretazione che ne danno. Ma attribuire loro un senso è inevitabilmente prendere posizione sul perché siano avvenute, quali ne siano verosimilmente le conseguenze e ove non gradite come impedirne la ripetizione. Il teologo N.T. Wright (Nicholas Thomas noto anche come “Tom”, ndt), che ho intervistato una volta in veste di Giusto Reverendo Tom Wright, vescovo di Durham, è fra quanti hanno sperimentato l’utile concetto di realismo critico come modo per quadrare il cerchio:
“Un modo di descrivere il processo di conoscenza che riconosca la realtà della cosa conosciuta, come qualcosa di distinto dal conoscitore (da cui realismo), pur riconoscendo al contempo che l’unico accesso che abbiamo a tale realtà sta lungo la pista a spirale di un dialogo o una conversazione appropriata fra il conoscitore e la cosa conosciuta (da cui critico)”.
Dobbiamo trovare un dialogo appropriato per la mediazione e la rappresentazione delle realtà con cui ci confrontiamo ora. Devono essere incluse istanze di giustizia nelle agende che attualmente ne sono carenti, ai margini del discorso politico prevalente, ossessionato a quanto pare dalla crescita economica mentre ignora le disparità in aumento nel reddito e nella ricchezza. Procedendo in tal senso ci si collegherebbe con quanto è considerato apprezzabile dal buon senso del pubblico globale, ossia che abbiamo tutti bisogni umani e che quando ci sono dei guai, in genere è perché i bisogni sono stati negati arbitrariamente. Per come vanno le cose, è spesso più facile trovare qualcosa del genere nel cinema che guardando i notiziari.
Titolo originale: HOW REAL IS REAL?
Traduzione italiana a cura di Miki Lanza per il Centro Studi Sereno Regis