Attenti ai «successi» di Trump in politica estera
L’attentato in corso alla democrazia statunitense, promosso dalla presidenza di Trump sotto gli occhi del mondo, non deve oscurare i successi, purtroppo destinati ad essere duraturi, della sua politica estera. Ovviamente, quando scrivo “successi”, mi colloco esclusivamente dal punto di vista della classe dirigente di quel paese, nella sua configurazione attuale, sia d’élite finanziaria che di “Deep State” (l’espressione con cui i liberals d’Oltreoceano definiscono le struttre più possenti dello Stato). Qualsiasi politica atta a contrastarla deve, tuttavia, conoscerne la pervasività e la forza.
Il primo e principale successo della politica estera trumpiana – che ha anche motivato e permeato la trasferta romana del suo segretario di stato, Pompeo – è quello di avere individuato nella Cina il principale nemico. Contrariamente a quanto è stato scritto, non si tratta soltanto di un espediente elettorale. Anche se definire la pandemia, di cui ora lo stesso Trump è vittima, “the Chinese plague”, la peste cinese, rientra nell’armamentario tipico del personaggio, l’individuazione di un nemico su cui rinnovare un bipolarismo globale costituisce un’esigenza duratura del potere statunitense nella sua configurazione non solo attuale. Non è un caso che Joseph Biden, suo avversario politico e persino probabile successore, si sia guardato bene dal contestare questa sua scelta, a cui ha aderito in più occasioni in forma solo lessicalmente più blanda. I temi di cui si nutre sono tutti professati e praticati, con relative pressioni nei confronti dei propri alleati minori: guerra tecnologica e commerciale; diritti umani non intesi come valore coerente e universale, bensì utilizzati come arma di offesa; opposizione ovunque ad investimenti cinesi ritenuti strategici; militarizzazione del confronto in Asia.
Per giustificare i costi economici ed umani tuttora imposti dal complesso militare-industriale – che il presidente ed ex comandante militare Eisenhower, nel 1960, definiva una minaccia alla democrazia – occorre un nemico, indispensabile per un paese la cui popolazione, per ragioni storiche e geografiche, altrimenti subisce la tentazione isolazionista. Ne consegue che, dopo la caduta del Muro e il crollo dell’Unione Sovietica, l’elemento costante della politica estera statunitense – appena attenuato dalle presidenza di Obama – è stata la ricerca di un nemico che surrogasse quello venuto meno e che, grazie alla politica estera di Trump, debitamente accompagnata da un incremento della spesa militare, è approdata all’antagonismo verso la Cina. Per una varietà di ragioni. la così detta guerra al terrore, stimolata dall’attacco alle Due Torri, e le conseguenti guerre all’Afghanistan, all’Iraq, alla Libia e in Siria si sono rivelate inadeguate allo scopo anche se, insieme con le iniziative restauratrici di Putin, sono state utili a giustificare l”esistenza della Nato, estendendone la competenza geografica (“Out of area or out of business”).
Il secondo obiettivo raggiunto dalla politica estera di Trump è stato quello di ridefinire la politica mediorientale degli Stati Uniti, trasformando il rapporto sempre più stretto con Israele, sotto la guida di Benjamin Netaniahu e quello, fortemente motivato da interessi legati al petrolio e all’esportazione delle armi, con gli stati del Golfo, in una vera e proprio alleanza, con il così detto Patto di Abramo. Vera e propria rottura non solo con la prospettiva di uno stato di Palestina, ma anche con il diritto internazionale, a partire dalle risoluzione 212 del Consiglio di sicurezza dell’ONU che, come noto, non riconosce la sovranità israeliana sui territori occupati. Necessario sbocco di una tale politica è anche la crescente tensione nei confronti dell’Iran, in maniera da consolidare i rapporti tra le componenti sunnite del mondo arabo e gli interessi israeliani in Siria e nel Libano. Malgrado la crescente opposizione ad una tale politica nelle comunità ebraiche americane, ulteriormente consolidata nello stesso partito democratico da Bernie Sanders, Joseph Biden non ha dato alcun segno di volersene discostare, confermando anzi la decisione trumpiana, di alto significato simbolico, di collocare la propria ambasciata a Gerusalemme.
Il terzo risultato conseguito dagli Stati Uniti sotto la presidenza di Trump è stato quello di alimentare una crescente rivalità, tendenzialmente ostile, nei confronti dell’Unione Europea, intesa come rappresentante dell’Europa nel suo insieme, con la sempre più netta preferenza a collocare i rapporti con gli alleati europei nel contesto della Nato, in cui prevalgono rapporti di forza di ordine strutturale e militare, o a confinarli a livello bilaterale, ove lo squilibrio è ancora più marcato. Anche in questo caso non si tratta di una svolta più o meno epocale, bensì del consolidamento chiarificatore, con qualche elemento di ulteriore radicalità, di politiche che hanno un lontano passato. Sin da quando è iniziato il graduale declino del potere relativo degli Stati Uniti nei confronti del resto del mondo, grosso modo risalente alla sconfitta subita nella guerra del Vietnam, il rapporto con gli alleati europei è divenuto meno egemonico – cioè gramscianamente condiviso dai soggetti subalterni – e maggiormente segnato dall’uso dominante del potere, soprattutto di presenza militare. Tale mutamento è accompagnato dal graduale abbandono del disegno di un’Europa partner tra eguali, concepito negli anni cinquanta, fino a nutrire un crescente disagio, se non ostilità, nei confronti di un’Europa più unita, più forte in quanto potenzialmente capace di estendere la propria concorrenzialità dalla sfera economica e commerciale a quella strategica e politica. Esso è stato lucidamente praticato, se non proprio teorizzato, da Henry Kissinger, e nemmeno abbandonato da Clinton e Obama. E’ problematico attendersi qualche passo in altra direzione da parte di una presidenza Biden. Più importante sarà la volontà di noi stessi europei di procedere sulla strada dell’integrazione, sottratta alla prospettiva di diventare sempre più terreno di rivalità e di conquista di Washington, Pechino e, in qualche misura, Mosca.
Meno netta risulta la continuità tra l’esplicita sfida dell’amministrazione in carica ad ogni forma di legalità ed organizzazione multilaterale, dalle Nazioni Unite all’Organiizzazione Mondiale della Sanità, ed un atteggiamento di convivenza, non priva di strumentalità e strappi, che ha caratterizzato la storia di un paese che, da Wilson a Truman, ne è stato il protagonista originario. Joseph Biden avrebbe interesse a tenerne conto. Come occorre non confondere gli aspetti duraturi dei risultati conseguiti dall’Amministrazione Trump con le insofferenze soggettive del presidente. Nei confronti della Nato, esse si sono risolte in un espediente tattico per ottenere maggiori contributi economici o di uomini nelle missioni congiunte da parte degli alleati europei.. Anche i conflitti d’interesse personali o il fascino esercitato da personalità e regimi autoritari che hanno segnato rapporti di Trump con Vladimir Putin, non hanno seriamente modificato la politica estera degli Stati Uniti. Restano alcuni risultati che con ogni probabilità segneranno un eventuale presidenza Biden, comunque da considerarsi un male minore rispetto ad una vittoria elettorale o, peggio ancora, giudiziaria di una politica che costituisce una sfida aperta all’eredità democratica degli Stati Uniti.
Articolo già pubblicato in forma ridotta su «il manifesto» di venerdì 16 ottobre 2020




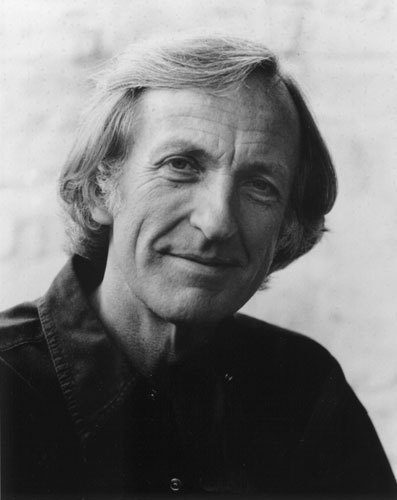
























Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!