Colombia: una pace difficile | Sergio Bassoli

Ho conosciuto Rubén Cano, ex-guerrigliero delle FARC-EP (Fuerza Armada Revolucionaria del Ejercito Popular), oggi impegnato a costruire per sé e per la sua famiglia un futuro di pace. La storia di Rubén è la storia della Colombia. Rubén proviene da una famiglia di commercianti, che vive del proprio lavoro e del piccolo appezzamento di terra che possiede. Rubén studia fino ai quindici anni, quando decide di arruolarsi nelle fila delle FARC-EP. Una scelta di campo, ideologica, per combattere con le armi le ingiustizie e il potere dei latifondisti, e costruire una società fondata sugli ideali marxisti. In quegli anni (1970/80), chi apparteneva alla maggioranza degli esclusi e sfruttati, non restava che scegliere tra adattarsi e sopravvivere o intraprendere la strada della rivoluzione armata per combattere il sistema capitalista dominante, che, tradotto nel contesto colombiano, significava combattere l’oligarchia terriera e i suoi alleati.
Rubén ha passato 32 anni combattendo, nella selva, rimanendo sempre nella regione dove è nato e cresciuto, bruciando la sua gioventù per ritrovarsi adulto, padre di due figli, oggi più che ventenni. Ha partecipato e ha visto il peggio che l’esperienza umana possa offrire, la guerra, pensando che quella strada potesse portare giustizia e pace, fino a che è maturata la consapevolezza di quanto fosse sbagliato “combattere e uccidersi tra colombiani” e quindi, di dover cambiare strada, senza rinunciare ai propri obiettivi, ma perseguirli attraverso il dialogo e il confronto politico, con umiltà, sapendo che quella strada sarebbe stata molto difficile e piena di ostacoli, ma con la convinzione che non ce ne fossero altre.
Rubén ha quindi partecipato alla discussione dentro le FARC-EP, lui, nome di battaglia “Manteco”, comandante del Gruppo 58, considerato un comandante coraggioso e intrepido, per altri semplicemente un sanguinario, ha scelto la strada della pace e oggi guida la sua comunità nel processo di re-inserimento nella vita civile e politica.
La decisione di lasciare la lotta armata è stato un processo lungo, individuale e collettivo, iniziato ufficialmente nel 2010 e conclusosi nel 2016 con la firma all’Habana, dell’Accordo di Pace tra il governo Santos e le FA RC-EP. Per chi lo ha vissuto nella selva, come Rubén, ha significato un travaglio interiore profondo, di messa in discussione di una scelta di vita radicale, totalizzante. Dalla scelta della lotta armata, L’abbandono dei propri familiari e degli amici, il vivere una vita in clandestinità, con un nuovo nome, nascondersi, combattere, fuggire, accamparsi, fuggire nuovamente, scendere a patti con i narcos, uccidere per non essere uccisi, fino a maturare la scelta di porre fine a tutto ciò. Prendere atto di essere su di una strada sbagliata, decidere di negoziare con il nemico storico la fine del conflitto, senza aver raggiunto gli obiettivi sperati, con la prospettiva piena di nuovi rischi e nuove incognite, ma con la speranza di continuare il proprio impegno politico senza più le armi, come soggetto politico riconosciuto ed immerso nella società civile.
E basta leggere il testo dell’Accordo Finale per la fine del conflitto e la costruzione della pace, per avere conferma di come sia stato complesso giungere alla sua firma da entrambe le parti.
L’Accordo è stato approvato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che impegna tutto il sistema delle Nazioni Unite ad accompagnare la sua realizzazione.
Il testo dettaglia in modo preciso ogni singolo aspetto, parola per parola, come un trattato scientifico che non tralascia nulla a libere interpretazioni, affrontando tutti gli ambiti strategici: riforma rurale integrale, partecipazione politica, fine del conflitto, eradicazione della produzione di droga (cocaina), riparazione per le vittime, esecuzione, verifica, riconoscimento della dimensione indigena e di genere. Identifica 520 indicatori/obiettivi, con impegni che debbono essere raggiunti entro 15 anni dall’implementazione dell’Accordo.
Un’architettura di “accordo di pace” considerata come un modello innovativo, mai disegnato fino ad ora, per la sua completezza, programmazione, capillarità, metodologia, strumentazione, per porre fine a 50 anni di guerra civile, che ha causato oltre 200mila morti, 100mila desaparecidos, 9 milioni di vittime, in maggioranza sfollati, privati delle loro case e della loro terra (9 milioni di ettari di terreno espropriati).
Un contesto nazionale che, oltre alle conseguenze della guerra interna, deve fare i conti con tre questioni strutturali che, in parte sono loro stesse concausa della guerra, e che senza un deciso e profondo impegno delle istituzioni e la partecipazione attiva di tutta la popolazione colombiana, continueranno a condizionare, in negativo, l’esito del processo di pace:
- la concentrazione di terra, lo 0,4% della popolazione possiede il 90% della terra coltivabile, pur in condizioni di assenza di un catasto fondiario, visto che solo il 6% delle terre hanno un titolo di proprietà registrato;
- la presenza di gruppi armati di distinta natura, paramilitari che operano con sospette coperture tra le fila dell’esercito, gruppi armati al servizio dei traffici illeciti, gruppi guerriglieri rivoluzionari, che mantengono un controllo territoriale esclusivo seminando terrore, violenza e sfollati;
- il business del narcotraffico che ha bisogno di un controllo assoluto del territorio, garantito dai gruppi armati assoldati, in grado di corrompere gli apparati militari e civili, che rappresenta una fonte illegale ma reale di reddito per campesinos che coltivano la coca e lavoratori impiegati nel processo di trasformazione.
Appare chiaro che la sfida che hanno accettato le due parti, il governo colombiano guidato dal Presidente Santos e le FARC-EP, è di portata storica. Una occasione unica per pacificare un paese dove la violenza ha permeato ogni ambito della società per generazioni, e chissà quanto tempo servirà per ricostruire fiducia, riparazione e riconciliazione.
Purtroppo, prima di proseguire, occorre ricordare due fatti avvenuti tra la firma dell’accordo e i giorni nostri:
- il risultato del referendum
per l’approvazione dell’Accordo di Pace firmato all’Havana, che ha
visto la vittoria del No, per la campagna sferrata dal partito di destra
dell’ex-presidente Uribe, contrario alla pacificazione del paese per il timore,
più che giustificato, di perdere privilegi, potere ed i profitti dai traffici
illeciti, in particolare il business del narcotraffico;
- il risultato delle elezioni presidenziali del 2018, dove al secondo turno ha vinto Ivan Duque, candidato dell’ex-Presidente Uribe, e contrario all’Accordo con le FARC, contro Gustavo Preto, espressione della sinistra colombiana, favorevole all’Accordo.
Il primo evento ha determinato che l’Accordo di Pace, per essere implementato ha dovuto essere rinegoziato da una commissione composta da rappresentanti dei due fronti referendari del No e del Sì, per poi essere approvato in extremis dal Parlamento, nonostante i partiti di destra fossero contrari.
Il secondo evento, ha fatto sì che l’implementazione dell’Accordo cadesse nelle mani di un governo guidato da un Presidente e da forze politiche contrarie all’accordo di pace, come se le difficoltà per la sua realizzazione non fossero sufficienti.
Il cambio di governo, ha rallentato l’implementazione dell’Accordo e la violenza nel paese contro attivisti sociali, sindacalisti ed ex-guerriglieri, rimettendo a rischio il processo di pace.
Dal novembre 2016 ad oggi, sono stati uccisi quasi 600 tra sindacalisti ed attivisti sociali, e 184 ex- guerriglieri delle FARC che hanno scelto la pace, depositando le armi, registrandosi e partecipando ai programmi di assistenza per la reincorportazione alla vita civile. E gli omicidi tendono ad aumentare di anno in anno, tanto che i primi 42 giorni dell’anno in corso hanno registrato una media di un omicidio al giorno, di sindacalisti ed attivisti sociali, oltre agli attentati e alle minacce recapitate, senza che lo stato riesca a intervenire e a fermare questa ondata di violenza e di terrore che rappresenta il vero nemico della pace e della riconciliazione nazionale.
Stessa situazione di minacce e di terrore, vivono i dirigenti del movimento politico FARC, che rappresenta la nuova immagine e l’organizzazione politica del movimento guerrigliero, che ha mantenuto l’acronimo, mutandolo in: “Fuerza Alternativa Rivolucionaria del Comùn”. Il riconoscimento politico del movimento ex-guerrigliero delle FARC è uno dei punti centrali dell’Accordo, contrastato dalle destre, ma sul quale i dirigenti delle FARC non hanno fatto alcuna concessione. In base all’Accordo, il gruppo politico FARC ha diritto, con nomina diretta, a 5 seggi alla Camera e 5 seggi al Senato, per due mandati. Ma già oggi, due di questi parlamentari hanno abbandonato il seggio e la vita civile, per ritornare nella selva, riprendendo le armi, a causa delle minacce, dell’assenza di protezione, del clima di stigmatizzazione nei confronti degli ex- guerriglieri, e il timore di essere assassinati o arrestati (nota: 140 ex-guerriglieri sono ancora trattenuti in carcere, nonostante abbiamo completato gli obblighi previsti dall’Accordo). I leader politici, ex-comandanti, incontrati nella sede del partito, a Bogotà, denunciano ritardi e assenza di sicurezza, ma resistono, dichiarando di aver scommesso sulla pace e di “non avere un piano B, per noi la scelta è la pace, non torniamo indietro”.
Le difficoltà che sta attraversando il processo di pace trovano una conferma nelle visite realizzate nelle due comunità di San José de Leon, quella dell’ex-comandante Rubén, e quella della comunità di pace di “La Madre Uniòn” della zona del Bajo Atrato, regione del Chocò.
Comunità di San José de Leon (Municipio di Mutatà, distretto di Urabà, Dipartimento di Apartadò)

Il gruppo di ex-guerriglieri a cui appartiene Rubén, una volta deposte le armi, è stato inserito in uno dei piani di reinserimento previsti nel programma di implementazione dell’Accordo. Per un periodo di sei mesi i 41 ex-guerriglieri e le rispettive famiglie, sono rimaste in un territorio del Dipartimento di Cordoba, senza nessun tipo di prospettiva di vero reinserimento, in uno stato di abbandono e di pericolo di rappresaglie e vedendo svanire le proprie aspettative e speranze. Ed è stata l’iniziativa di Rubén, da ex-comandante, trasformatosi in leader comunitario, a convincere la comunità a trasferirsi nel municipio di Mutatà, nella zona dove per anni hanno vissuto nella selva, per loro uno spazio conosciuto e considerato come casa propria. Con il contributo che ogni ex-guerrigliero ha ricevuto dallo stato, hanno acquistato un terreno di qualche decina di ettari, in forma collettiva, e hanno iniziato a disboscare per costruire le abitazioni, un centro comunitario, la strada di collegamento con la strada carrozzabile e avviato micro-progetti produttivi come l’allevamento di galline per vendere le uova, l’allevamento di pesci di acqua dolce, prima a livello familiare, e poi, visti i buon i risultati raggiunti e lo sbocco di mercato, hanno intrapreso un progetto a scala comunitaria. Un progetto di insediamento a lungo termine, autogestito, dove ogni decisione è discussa in assemblea e dove i progetti produttivi sono a partecipazione volontaria, di ogni singola persona. Le donne hanno costituito un Comitato e svolge attività di promozione dei diritti delle donne, educazione, raccoglie e vende piantine autoctone, ha in proiezione la costruzione e la gestione di un punto di ristoro. I principali progetti che la comunità sta pensando ed in parte già implementando sono l’itticoltura e il turismo consapevole, sfruttando al meglio le risorse naturali presenti.

Una esperienza completamente autogestita, inizialmente non riconosciuta dallo stato, in quanto “Area territoriale di reinserimento e di formazione”, come invece prevede l’Accordo di Pace, quindi, privata di assistenza tecnica, contributi e sicurezza. Solo dopo aver visto i risultati, la determinazione di queste famiglie, le buone relazioni creatisi con le altre comunità confinanti e con le autorità locali, e grazie alle pressioni delle organizzazioni di difesa dei diritti umani, della missione ONU e dei parlamentari della “bacada alternativa”, il governo ha riconosciuto la comunità come una “Nuova Area di reintegrazione”, con diritto all’assistenza tecnica ed ai finanziamenti per sostenere i progetti economici. Ma, nonostante ciò, nella comunità non esistono servizi di base, come la scuola primaria e un presidio sanitario, la luce elettrica è arrivata da poco, la comunità sta lavorando alacremente per completare la strada carrozzabile, fondamentale per uscire dall’isolamento e poter vendere i prodotti al mercato locale.
La sicurezza rimane un grave problema, vista l’ondata di odio e di vendetta nei confronti degli ex- combattenti, e la presenza di gruppi armati para-militari presenti nella zona e al servizio delle attività illecite legate al narco-traffico.
Comunità “La Madre de la Uniòn”, zona del Bajo Atrato, regione del Chocò

Per accedere alla comunità occorre percorrere una strada sterrata che attraversa chilometri di terre disboscate per far spazio al pascolo estensivo dei bovini, nel modello classico del latifondo latinoamericano. Queste terre tropicali, dal suolo fertile e con abbondanza di acqua, sono state il teatro di conflitti ed espropriazioni per liberare le terre dalla popolazione locale, per poi consegnarla, in affitto, alle multinazionali dell’agro-business. Tra il 1995 e il 2004, in questa zona sono avvenuti fatti di violenza inaudita.
Si racconta che, in quegli anni, per eliminare qualsiasi forma di organizzazione sindacale nelle piantagioni, furono catturati dieci lavoratori che stavano organizzando un sindacato, furono uccisi, decapitati e le loro teste conficcate alla sommità dei pali ed esposte a mo’ di avvertimento. Il sindacato dei campesinos, Fensuagro, a sua volta denuncia che dal 1986 ad oggi, oltre 600 dirigenti sindacali sono stati assassinati.
Il sistema della violenza sperimentato in Colombia nell’ambito rurale, è un vero e proprio sistema a “economia illecita circolare”: i gruppi armati fanno il lavoro sporco, potendo contare con la garanzia dell’immunità, affittano le terre liberate ai narcos per la produzione di coca, o ai latifondisti per l’allevamento o alle multinazionali per le piantagioni di banane, ananas, caffè, queste, a loro volta, appaltano la gestione a persone, in genere familiari, di fiducia, chiudendo così il cerchio. I campesinos, rimasti senza terra, diventano mano d’opera da sfruttare senza alcun limite e controllo, alla mercé di questo sistema basato sulla illegalità, in quanto le terre non hanno alcun titolo di proprietà), sulla violenza, chi protesta viene cacciato o eliminato, sullo sfruttamento, con salari da fame.
La storia di questa comunità, La madre Uniòn, è frutto di queste drammatiche vicende, di campesinos e indigeni, prima cacciati dalle loro terre, deportati in altre regioni del paese, poi riavviati in percorsi di reinsediamento.
L’insediamento si è avviato in periodi diversi, ma solo nel 2014 lo stato ha riconosciuto un territorio di protezione comunitaria, su di una superficie di circa 107mila ettari denominata “Zona di biodiversità – La Madre de la Uniòn”, e le diverse comunità precedentemente sfollate o rimaste senza terreni da altre regioni, hanno iniziato il trasferimento in questa zona protetta, raggiungendo oggi il numero di 49 diverse comunità, indigene, afro-discendenti e interetniche, per un totale di 2.200 famiglie.
Ma, nonostante il territorio sia protetto da un decreto statale, ancora oggi, quasi la metà del territorio non ha ancora il titolo di proprietà definitivo. Prima dell’Accordo di Pace il territorio era sotto il controllo delle FARC che non esercitavano pressioni o minacce alla comunità, ma con l’Accordo di Pace e la smobilitazione delle FARC, si è creato un vuoto ed i vari gruppi armati, paramilitari e ELN (Ejercito del Liberaciòn Nacional) se lo contendono, nella completa assenza dello stato.
Il 27 novembre del 2017, Mario Castaño, leader della comunità, noto per il suo impegno ed attivismo per ottenere i titoli di proprietà della terra a favore della comunità, fu ucciso da un gruppo di paramilitari, davanti alla sua famiglia, sulla soglia di casa. L’ennesimo omicidio rimasto impunito che, oltre ad dramma umano, ha prodotto terrore e panico in tutta la comunità.
Avvicinandoci alla sede della comunità, i nostri interlocutori ci avvisano di non parlare di politica e di fare molta attenzione, perché la strategia dei paramilitari ora, è di infiltrare persone in borghese, delatori pronti a denunciare chi osa rispondere alle domande degli stranieri, e far scattare la rappresaglia che può essere l’intimidazione di lasciare il territorio, o direttamente subire un attentato, spesso mortale.

Anche in questo caso, i membri di questa comunità, debbono arrangiarsi da soli, senza poter contare con il sostegno e la protezione dello stato. Stretti tra la tentazione di fuggire di nuovo e il desiderio di restare, in silenzio, sotto minaccia e con la paura di nuovi attacchi e nuove vittime. Le persone che incontriamo, ci fanno capire che la loro decisione è quella di restare per costruire una comunità di pace e di convivenza, tra le diverse etnie sfidando il pericolo e la paura.
Nella Madre de la Uniòn, come nelle altre realtà costruite nelle zone di conflitto, non esistono vie di comunicazione carrozzabili, non vi è copertura telefonica, scuola e presidio sanitario. L’economia è di sussistenza, con produzione di alimenti per l’auto-consumo, yucca, banane, riso, e la vendita dell’eccedente ad intermediari che monopolizzano il mercato locale e impongono i prezzi (p.e. 25Kg di banane vendute a Euro 1,5). La comunità ha messo al bando le armi e ha proibito il taglio del legname, come risposta ai gruppi armati e ai contrabbandieri di legname. Ha avviato una esperienza autogestita di educazione interculturale che si sta diffondendo in tutte le comunità. La presenza di etnie diverse con culture diverse ha fatto sì che si stia sperimentando un modello di società plurietnica multiculturale, dove afro-discedenti, indigeni e meticci, si ritrovano uniti a difendere la terra e a costruire uno spazio di pace in armonia con l’eco-sistema, grazie alla centralità che l’ambiente naturale, la madre-terra, riveste per le culture indigene. Da alcuni anni per iniziativa di alcuni giovani, è nata una associazione di produttori di riso, mettendo a coltura 10 ettari di riso, il cui raccolto è venduto senza la necessaria lavorazione per rendere il chicco commestibile, quindi, lasciando agli intermediari il grosso del profitto. Servono finanziamenti per costruire un magazzino, acquistare i macchinari, aumentando così gli ettari produttivi, posti di lavoro, maggiori entrate per migliorare le condizioni di vita, ma lo stato non c’è e neppure l’Accordo di Pace è arrivato fin qui.
Peggio. Le testimonianze raccolte denunciano la collusione delle autorità locali e dei militari con le bande armate e di fare gli interessi delle grandi imprese, concedendo permessi di sfruttamento delle risorse naturali (oro, coltan,..) presenti nelle alture e nelle foreste, mantenute incontaminate e protette in quanto territori di caccia degli indigeni, che non possono più accedervi, per la presenza dei paramilitari. Questi ultimi, mai paghi, chiedono il “pizzo” su ogni cosa che si muove. Esattori e carnefici.
Se lo stato è il primo accusato di fare poco per la pace, le FARC stanno facendo tutto ciò che era loro obbligazione. 13.200 combattenti hanno consegnato le armi e si sono registrati per il processo di reinserimento come previsto dagli accordi. Il comando delle FARC ha consegnato la lista dei beni in suo possesso. Oltre 2500 ex-combattenti si sono presentati nelle sedi della Commissione per la Verità, per affrontare il delicatissimo percorso di ricostruzione della verità, a cui solamente gli appartenenti alle FARC hanno l’obbligo di testimoniare, mentre i militari e le parti terze (altri soggetti coinvolti negli atti di violenza) lo possono fare su base volontaria. (Questa è una delle principali modifiche dell’Accordo, a seguito della rinegoziazione post-referendum).
I rappresentanti del governo si trincerano dietro la complessità dell’applicazione dell’Accordo, che richiede tempi lunghi e la volontà di tutta la nazione. La violenza e gli omicidi sono fisiologici in un territorio vasto come quello colombiano. Non esiste nessuna prova che confermi l’implicazione dell’esercito in atti di violenza o di collusione con paramilitari e narcotrafficanti. Chi denuncia i morti assassinati non è informato, non sa di cosa stia parlando.
Tra quello che abbiamo ascoltato nelle sedi istituzionali e ciò che abbiamo visto e ascoltato nelle visite nelle comunità, con i rappresentanti delle FARC e con i parlamentari della “bancada alternativa”, l’intergruppo composto da 42 deputati di 4 diverse forze politiche, impegnati per la pace, rappresentano due realtà opposte, due mondi che non si conoscono.
L’espressione “società polarizzata”, sentita ripetere più volte, da entrambe le parti, è forse quella che unisce e che rappresenta la realtà ed il risultato del referendum del 2016, dove per soli 50mila voti su oltre 30 milioni di votanti, ha vinto il No. Manca ancora quella volontà popolare, la decisione e l’impegno della società colombiana di staccarsi dall’eredità della guerra e dal sistema di potere, politico, economico, sociale e militare, che si è costruito attorno e che ha condizionato l’esito del referendum e delle elezioni del 2018.
Ci sono segnali positivi. La manifestazione del 21 novembre scorso convocata dai sindacati, contro le politiche anti-sociali e neo-liberiste del governo, si è presto trasformata in una manifestazione di giovani, donne, indigeni, uomini e donne di ogni settore, contro la violenza e per la pace. L’elezione della prima donna a sindaco di Bogotà [Claudia López Hernández, ndr], donna, lesbica, impegnata per i diritti civili e contro la corruzione, è un’altro segnale del cambiamento in atto.
Ma occorre molto di più per evitare che il tempo continui al servizio della violenza e della criminalità. La comunità internazionale, dalle Nazioni Unite, ai suoi stati membri, alla società civile organizzata, tutti quanti dobbiamo impegnarci e sostenere il processo di pace in Colombia, ognuno per le proprie responsabilità e competenze, accompagnando la società colombiana in questa difficile ma indispensabile, attraversata verso la pacificazione.
Sergio Bassoli, area Politiche Internazionali CGIL
Roma, 28 febbraio 2020
(articolo scritto a seguito della missione della delegazione di Justice for Colombia, realizzata tra il 15 e il 21 febbraio 2020)






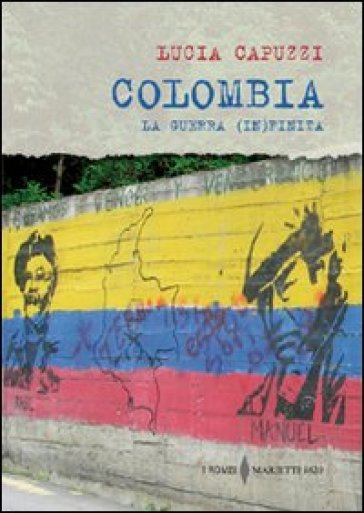





















Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!