Italiani d’Austria. Un destino difficile – Claudio Belloni
Spesso si dimentica che una minoranza di italiani fece la Grande Guerra con la divisa dell’esercito austro-ungarico. Le condizioni di vita al fronte furono durissime per tutti, ma furono sicuramente più complesse per trentini, ladini, friulani, triestini, istriani, dalmati, e “litorali” in genere.
Già prima di cominciare, erano preceduti dalla fama di non essere particolarmente combattivi; «nelle campagne d’Italia del 1848-49 costoro avevano procurato non pochi problemi e dispiaceri al maresciallo Radetzky», tanto che il XXII reggimento di fanteria Conte Wimpfen, che arruolava i sudditi del territorio corrispondente «al vecchio Regno di Illiria e composto per lo più da elementi di ceppo veneto, venne indicato anche con il nomignolo di “reggimento scampa”». Le cose migliorarono (per la fama del reggimento, non degli italiani) dal 1883, quando l’arruolamento si estese fino ai croati di Spalato, «gente rude e combattiva».
L’irredentismo italiano non fece che gettare un’ombra supplementare e definitiva sull’affidabilità degli “italiani d’Austria”. Da sempre i graduati degli eserciti dell’Impero erano prevalentemente austriaci e ungheresi, tranne poche eccezioni ai livelli inferiori, ma alla vigilia della Grande Guerra quasi mai si trattava di italiani. Pur poco stimati, gli italiani non vennero disdegnati come carne da cannone per il fronte orientale, con la sola precauzione di distribuirli lasciandoli sempre in minoranza nei vari reggimenti sotto il controllo di ufficiali e compagni d’arme ben più bellicosi e motivati.
Le cose si complicarono col passare dei mesi soprattutto per i fortunati che erano stati sottratti alla vita di trincea: le decine di migliaia che furono fatti prigionieri dai russi già a partire dai primi grandi scontri della tarda estate del 1914. «In molti dei diari esaminati, notiamo una persistente attenzione alla situazione contingente, alla possibilità di darsi prigionieri. Un servizio di pattuglia, uno sconfinamento, la perdita più o meno voluta di un sentiero erano occasioni propizie per darsi prigionieri e finire la propria guerra». Deposte le armi, si mettevano a mangiare le scorte di cibo e a fumare in attesa di essere catturati dal nemico; ciò, però, avveniva in entrambi gli schieramenti. Un triestino riferisce che suo padre raccontava sempre di aver «fatto tanti prigionieri russi, perché anche loro gettavano via i fucili e disertavano. E là litigavano per darsi prigionieri: “No, no, no… ti te ne porti indrio a noi!”. E allora […] han dovuto prendere dieci russi e portarli al comando. E là stupefatti gli han chiesto: “Ma come avete fatto in tre a prender dieci prigionieri con tutte le armi?”. E loro: “Eh, li abbiamo circondati!”».
I soldati italiani catturati vennero distribuiti nell’Impero zarista per lavorare nei campi, nelle miniere e nei cantieri. Con l’intervento del maggio del 1915, il Regno d’Italia cercò un accordo con lo zar per arruolare nelle proprie file i prigionieri austriaci di nazionalità italiana. A costoro venne offerta l’opportunità di essere rapidamente “rimpatriati” (in Italia) per cambiare cittadinanza e tornare a combattere contro la loro “patria” del momento (l’Impero austro-ungarico). Una percentuale significativa accettò la proposta e venne progressivamente concentrata in un campo di smistamento a Kirsanov (governatorato di Tambov). Il primo rimpatrio (di circa quattromila Kirsanover, traditori per l’Impero austro-ungarico) venne organizzato via mare attraverso il porto di Arcangelo nell’autunno del 1916. Gli altri, in attesa d’imbarco, rimasero bloccati dal gelo invernale prima e dal caos della rivoluzione russa poi. A differenza degli altri prigionieri, questi italiani si ritrovarono in un campo provvisorio e sovraffollato, senza occupazione ed esposti a freddo e malattie. Inoltre, si diffondeva il timore di una pace separata, che per loro non avrebbe significato la fine della guerra, ma la restituzione all’esercito di provenienza per il quale rappresentavano dei disertori. Alcune migliaia tentarono la via del “rimpatrio” lungo la linea della Transiberiana e andarono incontro ad avventure degne di Odisseo.
Per fortuna dei Kirsanover la guerra finì con la sconfitta austriaca, ma, qualunque fossero stati i percorsi seguiti o le scelte fatte, al termine della guerra gli italiani d’Austria andarono incontro alla diffidenza della nuova patria che in loro vedeva dei potenziali austriacanti. Duemila trentini, per esempio, prima di essere restituiti alla vita civile dovettero passare per i campi di prigionia di Pescara, Asinara, Isernia, dove furono sottoposti a trattamenti durissimi e molti di loro non sopravvissero a freddo, fame, malattie. I più sospetti erano quelli che, essendo stati prigionieri dei russi, si temeva avessero contratto anche il morbo bolscevico.
Dopo la guerra prevalse lo spirito del nazionalismo italiano e ben presto furono emanate direttive specifiche (e correttive della piega presa nei primi tempi) per l’erezione di monumenti commemorativi. Furono vietati i monumenti nelle piazze e concessi solo nei cimiteri, ma, soprattutto, fu vietato l’uso del termine “caduti”. Gli italiani d’Austria morti in guerra, infatti, non si erano immolati per il Regno d’Italia, ma, appunto, erano semplicemente “morti”: per la patria sbagliata. Nel fiume di retorica di quegli anni, stupisce la lucidità di giudizio con cui le autorità, accecate dalla propaganda antiaustriaca, leggevano gli eventi della Grande Guerra. Per esempio, nell’infausto ottobre 1922 il comune di Rovereto chiese ai parroci di inviare l’elenco di «coloro che incorporati nell’esercito austriaco e mandati al macello sulle diverse fronti, durante la guerra mondiale, vi lasciarono miseramente la vita».
Né le amministrazioni locali, passate sotto il controllo italiano, né tanto meno il governo centrale, si preoccuparono di accertare la sorte di tutti quei soldati. Il governo austriaco, d’altra parte, non insistette certo nel fornire informazioni. Iniziò così la rimozione della memoria della vicenda degli italiani d’Austria.
Clericalismo e devozione nuocciono gravemente alla salute
Dalle ricostruzioni storiografiche più recenti e attendibili delle vicende di quegli anni, del numero dei caduti e della loro provenienza, emerge che la percentuale maggiore di perdite è quella dei soldati provenienti dalle valli e dalle campagne.
Una prima spiegazione, di tipo politico, è legata al fenomeno dell’irredentismo, che si concentrava nei centri urbani e nelle classi medio-alte. Ogni sospetto era ritenuto inaffidabile e tenuto lontano dal fronte, dunque, paradossalmente, protetto dal fuoco nemico.
Vi sono poi generiche motivazioni sociologiche: «in un mondo a economia rurale o silvo pastorale, la coscienza che un minimo mutamento o la presenza di un elemento estraneo avrebbe potuto compromettere il delicato e instabile equilibrio ambientale da cui traeva il sostentamento, può aver favorito la nascita di una mentalità accorta e vigile, ma conservatrice e statica, la quale, per le sue reazioni lente, può trovare qualche difficoltà ad adattarsi alla situazione continuamente instabile del fronte; invece una mentalità cittadina, abituata a cogliere le occasioni di sopravvivenza in un ventaglio più o meno ampio di opportunità offerte dalla città, o anche solo da un popoloso centro valligiano, è più dinamica e attenta alle possibilità che le si offrono per limitarne i danni in situazioni difficili».
Le radici del fenomeno potrebbero essere di tipo religioso: «la religione cattolica, che si avvale della capillare azione del clero, trasferisce il fatto contingente della guerra su un piano trascendente, considerando la stessa come un “castigo di Dio”, che vuol punire l’uomo per i suoi peccati. Ne consegue che il cattolico osservante, maggiormente presente nel mondo contadino, non solo subisce in modo passivo e fatalistico la guerra, ma dimostrerà anche di accettare la volontà divina attraverso l’adempimento dell’obbligo impostogli». Secondo Una circolare vescovile al clero di campo pubblicata su “Il Trentino” (quotidiano diretto da Alcide De Gasperi) del 7 agosto 1914 (erano i giorni in cui partivano i primi treni per il fronte), il cappellano militare deve «infondere ai soldati affidati alle sue cure confidenza nella provvidenza divina, incoraggiarli alla fedeltà, all’adempimento del proprio dovere, confortare e tranquillare i feriti […] invitare i soldati a ricevere i Sacramenti ed essere giorno e notte a loro disposizione per le confessioni. Quando i suoi soldati vanno ad affrontare il nemico, il sacerdote li inviterà al pentimento e a darne un segno esterno (per es. battendosi il petto)». Sempre in quei giorni caldi dell’agosto 1914, il vescovo di Trento, con la circolare n. 2180/1 Eccl., così si rivolse al clero della diocesi: «cercate di confortare e consolare le famiglie ed i paesi col dire loro nelle prediche, nelle confessioni, nelle visite pastorali, parole di incoraggiamento, di fiducia in Dio, di fortezza e di rassegnazione e di uniformità ai voleri divini. “Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra”. “Non cade foglia, che Dio non voglia”. Anche i flagelli più tremendi, come insegna la storia alla luce delle rivelazione, sono permessi dalla mano paterna di Dio. Sono permessi come castigo dei peccati dell’umanità; sono permessi però per il nostro bene e per la nostra correzione». «Sono innegabili quindi i condizionamenti e le pressioni a cui sono soggette delle persone addestrate all’obbedienza, prive di alternative, e assuefatte a una religiosità tipicamente devozionale, una religiosità legata alla materialità e alla ritualità del gesto – elementi quindi socialmente controllabili – a cui affidare la salvezza della propria anima».
«Ben diverso era l’atteggiamento del soldato agnostico o religiosamente più critico o tiepido, proveniente soprattutto dalle città (e per tali intendo anche i capoluogo di distretto): la guerra, per lui (sottratta a qualsiasi sfera soprannaturale), rimaneva un semplice fatto politico e perciò egli, meno rassegnato del contadino, cercava di sottrarsi ad essa con le proprie forze […]. Essendo allora l’orientamento politico una proiezione del sentimento religioso, possiamo forse cogliere una sfumata conferma di questa situazione nei risultati delle elezioni amministrative svoltesi nell’aprile del 1914: nei singoli distretti e relativi capoluoghi, il tasso di mortalità bellica tende generalmente ad aumentare o a diminuire parallelamente alla percentuale dei voti clericali.
Le citazioni sono tratte da:
G. Fait (a cura di), Sui campi di Galizia (1914-1917). Gli Italiani d’Austria e il fronte orientale: uomini popoli culture nella guerra europea, Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto 2004.
In proposito, cfr. anche:
R. Francescotti, Italianski. L’epopea degli italiani dell’esercito austroungarico prigionieri in Russia nella Grande Guerra (1914-1918), Valdagno 1994.
C. Medeot, Friulani in Russia e in Siberia 1914-1919, Gorizia 1978.
Oppure due testimonianze di soldati:
G. Fait, Una generazione di confine. Cultura nazionale e Grande Guerra negli scritti di un barbiere rivano, Trento 1991.
M. Rossi, Nei diari inediti di un maestro di Fiumicello riaffiora la tragedia degli internati italiani a Kirsanov: le “cronache” di Domenico Rizzatti (20 ottobre 1914-16 novembre 1916), “Qualestoria”, XX (1992), n. 3, pp. 7-32.







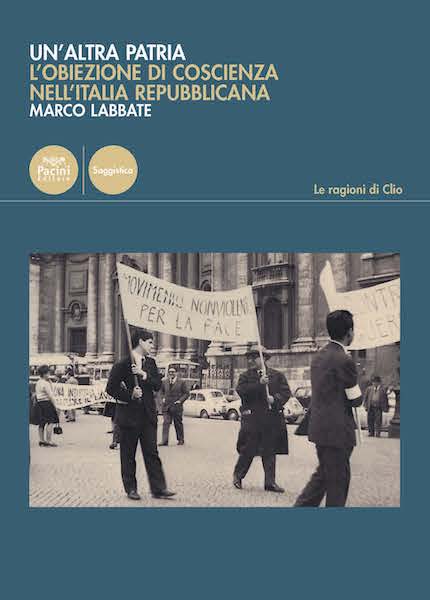





















Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!