Il caso italiano. Industria, chimica e ambiente
Pier Paolo Poggio, Marino Ruzzenenti, Il caso italiano. Industria, chimica e ambiente, Jaca Book, Milano 2012
L’autocolonizzazione dell’Italia
Hai mai visto Bormida? Ha l’acqua color del sangue raggrumato, perché porta via i rifiuti delle fabbriche di Cengio e sulle rive non cresce più un filo d’erba. Un’acqua più porca e avvelenata, che ti mette freddo nel midollo, specie a vederla di notte sotto la luna.
Beppe Fenoglio, Un giorno di fuoco (1963)
Acciaio e sottosviluppo
La lavorazione degli acciai è nota dall’antichità: resti di ghisa e leghe ferro-carbonio sono stati ritrovati in siti del XII secolo a.C. in India, Anatolia e Caucaso. Le prime produzioni in altoforno risalgono, invece, all’Europa del XIV secolo, servivano per le bocche da fuoco e le palle di cannone e già allora la trasformazione del minerale era accompagnata dall’emissione di fumi, ossidi d’azoto, diossine e metalli pesanti. Un altoforno oggi è in sostanza un reattore chimico in cui per azione del coke ha luogo la riduzione degli ossidi di ferro con formazione della ghisa. L’energia necessaria per scaldare il minerale fino alla temperatura di reazione, superiore a 1000 °C, è fornita dalla combustione del coke stesso con l’aria. Il processo successivo di trasformazione della ghisa in acciaio – cioè la raffinazione per decarburazione e riduzione delle impurità sovente nocive, come fosforo, zolfo, manganese etc. – è andato affinandosi dal XVII secolo. Nel caso delle acciaierie Ilva di Taranto, si effettua in speciali convertitori di tipo LD, operanti per insufflazione dall’alto di ossigeno. La sigla LD deriva dalle iniziali delle città di Linz e Donawitz in Austria, dove per la prima volta questi convertitori furono usati negli anni ’50 del secolo scorso. Non si tratta di macchinari innovativi, lo erano alla fine degli anni ’60 quando l’Italsider scelse Taranto per la costruzione del proprio quarto centro siderurgico: un impianto a ciclo integrale – dal minerale grezzo all’acciaio laminato – con i nuovi convertitori LD al posto dei forni Martin Siemens, sostituiti anche a Piombino, Bagnoli e Cornigliano, mentre un quinto centro era in programma nella piana di Gioia Tauro in Calabria.
Il piano di risanamento e sviluppo della siderurgia italiana fu uno dei pilastri del miracolo economico. La crescita del settore andava ricalcando il modello giapponese basato sull’economia di scala e sulla concentrazione di capitali, produzioni e manodopera in grandi impianti costruiti in riva al mare per favorire il trasporto delle materie prime (minerale e coke) e dei prodotti finiti. Per il raddoppio del polo di Taranto nel biennio 1974-75 l’impegno pubblico fu di quasi 4mila miliardi di lire, per una capacità produttiva, tuttora mantenuta, di 10,5 milioni di tonnellate annue di acciaio: tre volte quella del 1969, anno d’inaugurazione. Questo mentre già emergevano gli scompensi per l’eccessiva dimensione degli impianti e degli investimenti (77milioni di lire per addetto nel 1974), che oltretutto non fornivano i livelli di occupazione promessi. Intanto l’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) guardava al cambiamento che si profilava in Germania e negli Stati Uniti con l’introduzione di forni elettrici per il riciclaggio dei rottami di ferro ormai abbondanti. La relazione programmatica del 1973 mostra un ripensamento critico dei dirigenti IRI. “La corsa al gigantismo – scrivevano – ha reso più acuti i problemi sia del finanziamento di così ingenti immobilizzazioni, sia dell’organizzazione della produzione e in particolare dei trasporti che implicano la realizzazione di infrastrutture su scale senza precedenti, sia dell’incidenza sull’ambiente e sull’assetto del territorio. Inoltre, non va taciuto il notevole grado di vulnerabilità di complessi dalle dimensioni indicate di fronte ad eventi che possono turbare il regolare svolgimento dell’esercizio” (cit. in B. Mazza, D. Sinigaglia, La siderurgia italiana, Sapere N. 781-782, aprile-maggio 1975, p. 49).
In quegli stessi anni il piano che allora era chiamato di divisione globale del lavoro preconizzava anche per l’Italia il trasferimento degli impianti siderurgici nelle aree del mondo in via di sviluppo, perché la Finsider stava perdendo i vantaggi protezionistici, per l’accresciuto potere di intervento dei lavoratori e perché i problemi di ordine ambientale, sanitario e sociale andavano addensandosi intorno ai grandi impianti coinvolgendo, come nel caso di Taranto, intere città. Invece, la strategia di dislocazione della produzione nei paesi poveri prospettava vantaggi imperdibili mascherati da ragioni ecologiste e terzomondiste. “La visione che ispira questa divisione del lavoro – scrivevano Mazza e Sinigaglia – è semplicemente economicista e neocoloniale e la convenienza è basata su fatti molto concreti: la possibilità di pagare salari cinque volte inferiori, di disporre di una manodopera non organizzata e che può essere sottoposta a più alti livelli di sfruttamento, l’irresponsabilità verso i problemi sociali che crescono intorno alle fabbriche siderurgiche”.
Il caso italiano
La conferma non è piacevole, ma non sorprende che la visione semplicemente economicista e neo-coloniale delle classi dirigenti, associata a un’idea del Meridione e delle aree rurali come sottosviluppate, fornisca una chiave di lettura calzante per l’involuzione di tante situazioni analoghe a Taranto sparse per l’Italia. Lo spiegano sotto più prospettive (economica, tecnologica, sociologica) e con dovizia di documentazioni gli storici dell’ambiente Pier Paolo Poggio e Marino Ruzzenenti, curatori del lavoro a più mani intitolato Il caso italiano. Industria, chimica e ambiente (Jaca Book, Milano 2012), corredato dal cd Un anno di chimica. Elementi e racconti di Giorgio Nebbia e pubblicato con il contributo della Fondazione Luigi Micheletti di Brescia, importante centro di ricerca sull’età contemporanea. Questa riproposizione della storia industriale italiana focalizzata sui danni al territorio e alla salute della popolazione è essenziale per ritrovare le radici di moltissime crisi contemporanee di ordine ambientale, sociale e anche economico. Mentre si dissolvono i fumi del neoliberismo ma ancora dominano le ideologie monocordi del mercato, questa raccolta espone con dati, statistiche e bilanci i lati oscuri della crescita a priori – che ora emergono da Taranto a Casale, dal Lambro a Manfredonia, ma che andrebbero sempre considerati – e impone un ripensamento delle politiche di sviluppo economico e tecnologico finora perseguite.
In Italia vi sono 57 siti di interesse nazionale (SIN) per la bonifica censiti da tre decreti (D.L. 22/97, D.M. 471/99, D.L. 152/2006) che ne stabiliscono l’individuazione “in relazione alle caratteristiche, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini sanitari e ecologici nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali”. Di questi, 44 sono aree industriali, come Gela, Priolo, Bagnoli, Porto Torres, Milazzo, Marghera, le miniere dell’Iglesiente, del Sulcis, del Guspinese, assieme a decine di altre sedi di stabilimenti, perlopiù abbandonate. Oltre ai 57 sottoposti a giurisdizione nazionale, i siti potenzialmente inquinati di competenza regionale – dai distributori di carburante alle piccole fabbriche dismesse – sono circa 13 mila: 1.500 sono impianti minerari, 5mila sono sicuramente da bonificare. In Sardegna, le ex aree minerarie di Sulcis, Iglesiente e Guspinese coprono quasi 450 mila ettari.
Altri lavori – come l’intera opera di Giulio Maccacaro, testi come L’imbroglio ecologico di Dario Paccino, o Che cos’è l’ecologia. Capitale, lavoro e ambiente di Laura Conti, i romanzi autobiografici di Renzo Tomatis sulla medicina – hanno svelato localmente e in determinati frangenti le contraddizioni e le dissimulazioni che fanno da retroscena alla retorica della crescita e del progresso. Il caso italiano è però una delle poche letture (si vedano anche A. Caracciolo, L’ambiente come storia, Il Mulino, Bologna 1988; S. Adorno, S. Neri Serneri, Industria, ambiente e territorio, Il Mulino, Bologna 2009) capaci di gettare luce sulle origini e gli sviluppi storici di così tante dissimulazioni e contraddizioni esplose nell’attualità, al punto che oggi complessivamente l’estensione dei SIN interessa più di 8mila km quadrati di suolo e 3mila di fondali marini. Si tratta del 3 per cento dell’Italia, il 12 per cento delle pianure, quasi il 35 per cento delle aree urbanizzate, un’estensione enorme non più disponibile che fra residenti e lavoratori coinvolge sei milioni di persone.
La prima sezione dell’antologia raccoglie saggi che contestualizzano sul piano economico, sociale e culturale le prime grandi realtà industriali e lavorative sviluppatesi in Italia a partire da metà dell’800 (Le lavorazioni chimiche nell’Ottocento in Italia e l’ambiente, di Nicoletta Nicolini), grazie anche allo sfruttamento sistematico dei corsi d’acqua e dell’energia idraulica (Il capitalismo nelle vallate. Acque e industria dell’Italia dell’Ottocento, di Stefania Barca). Considerazioni sull’immaginaria purezza della natura introducono la nascita dei primi movimenti di conservazione dell’ambiente, in contrasto con il disagio crescente per la società industriale, ma capaci anche di incarnare “il volto amato della patria” in senso nazionalistico (Paesaggio della Belle époque. Il catalogo delle bellezze naturali d’Italia 1913-1926, di Luigi Piccioni).
Quando l’analisi si sposta oltre la metà del Novecento, mentre “un paese contadino si modernizza nel giro di un decennio”, emergono nomi e luoghi simbolici delle lotte ambientaliste italiane: l’Acna di Cengio, la Rumianca di Pieve Vergonte in Val d’Ossola, il nucleo d’industrie belliche e chimiche di Colleferro e della Valle del Sacco fra Roma e Frosinone. Emerge anche l’esperienza dei due curatori, attivi in battaglie sindacali con la camera del lavoro di Brescia, in rivendicazioni sulla salubrità degli ambienti di lavoro con Medicina Democratica (Marino Ruzzenenti, Un secolo di cloro e… PCB. Storia delle industrie Caffaro di Brescia, Jaca Book, Milano2001) e in iniziative di formazione e divulgazione (P. Poggio, La crisi ecologica: origini, rimozioni, significati, Jaca Book, Milano 2003) esemplificate in questo volume da un saggio di Ruzzenenti sul piombo tetraetile (l’antidetonante tossico usato nelle benzine fino al 1994), e da un’approfondita cronistoria di Poggio sulla vicenda dell’Acna di Cengio in Val Bormida. Quest’ultima è definita “un caso esemplare: centoquindici anni di inquinamento chimico, il conflitto di più lunga durata dentro la modernità italiana, che raccoglie tutto l’insieme di questioni storiche e contraddizioni economiche ed etiche sollevate dall’ambientalismo”. In effetti, nella sua storia secolare l’Acna non s’è persa nulla del peggior repertorio di degrado e irresponsabilità: partecipazioni militari e commistioni con l’industria bellica (esplosivi e gas nervini), esaltazione delle produzioni autarchiche sotto il fascismo, omertà su condizioni di lavoro ed emissioni tossiche nel periodo post-bellico, rivendicazioni sindacali represse con minacce ed epurazioni. Fuori dalla fabbrica, i malumori mai sopiti dei valligiani deflagrarono negli anni ’70 e ’80 fino a diventare un caso nazionale che coinvolse, sull’uno e l’altro fronte, partiti, amministrazioni locali e movimenti. La lotta si protrasse fino agli obbligati e tardivi ma ancora conniventi provvedimenti di bonifica, suggellati dall’arresto di due dirigenti dell’Acna nel 1992 per falso in bilancio, avendo accollato costi esorbitanti alle opere di risanamento. Al momento della liquidazione la situazione economica era disastrosa. Secondo un’interrogazione parlamentare, nel triennio 1990-1992 il passivo dell’Acna era giunto a 391 miliardi di lire (602 milioni per dipendente), parzialmente coperte dall’ENI, cioè dallo stato, con interventi per 194 miliardi (291 milioni per ogni dipendente). Un caso clamoroso di fallimento del progresso le cui conseguenze su lavoratori, cittadinanza e ambiente sono solo parzialmente note – ha osservato Poggio. “Attraverso la storia dell’Acna è possibile ripercorrere tutto il ciclo storico dell’industrializzazione fino a una biforcazione, un aut-aut, che non ha solo un significato locale: o radicalizzare lo sfruttamento del territorio utilizzando una rendita di posizione geopolitica, o sperimentare un percorso alternativo incentrato sull’ambiente, la cultura locale, le risorse intellettuali attivate dal conflitto” (P. Poggio, Industrialismo contro sviluppo locale: il caso Acna, Ecologia Politica, 2006).
L’ambiente fra politica, informazione e lavoro
Secondo i curatori, la transizione industriale in Italia si è risolta in “un miracolo e un trauma mai veramente metabolizzati”; Guido Crainz in Autobiografia di una repubblica (Donzelli, Roma 2009) l’ha descritta come una “trasformazione non governata”, Pasolini parlò di “trasformazione antropologica degli italiani”. “La fuoriuscita dalla miseria trovava la sua celebrazione nei riti collettivi della nascente religione dei consumi, che incentivava la fuga dal Sud e dalle campagne, dal mondo contadino, simbolo di arretratezza, fatica, infelicità, stupidità” – ha scritto Poggio. L’impatto su persone, animali, paesaggio, clima, patrimonio culturale, non veniva preso in alcuna considerazione. Con queste premesse, assumono rilevanza i due saggi della seconda sezione del volume, dedicati al rapporto tra ambiente, soggetti politici istituzionali e organi di informazione (Ambiente o lavoro? Il PCI di fronte agli effetti occupazionali della questione ecologica 1972-1991, di Wilko Graf von Hardenberg; Industria, ambiente e inquinamentoattraverso la lente deimass media, del giornalista Edgar H. Meyer). Per commentare, è difficile evitare il termine negazionismo; l’impressione è che non si volesse vedere quel che stava succedendo, considerando acriticamente utili, necessarie, inevitabili anche le più malefiche esternalità di uno sviluppo senza criterio e spregiudicato. “Una frattura epocale dalle dirompenti conseguenze sociali e culturali venne banalizzata attraverso l’egemonia del linguaggio televisivo e pubblicitario“ (P. Poggio, op. cit.).
Un riposizionamento del pensiero su percorsi di maggiore equilibrio è apprezzabile nella seconda parte dell’antologia costituita da una raccolta di testi di Giorgio Nebbia, introdotti da un’intervista di carattere biografico, e una rassegna dedicata a Laura Conti. Nebbia è il maggior esponente dell’ambientalismo italiano, uno scienziato che da cinquant’anni analizza e popolarizza il tema del rapporto tra natura, merci, produzione e consumi, anche alla luce dei disastri ecologici del passato e del presente. Molti suoi testi, come quelli del cd allegato, invitano inoltre a una rilettura della chimica, contrapponendo a pesticidi, veleni e plastiche, esempi di sostanze utili alla società e processi in grado di ridurre l’impronta ecologica moderna. Di Laura Conti, che sollevò per prima il problema della partecipazione nel controllo del territorio, sono ricostruiti l’intensa attività divulgativa, lo studio del rapporto fra inquinamenti e industria, i rapporti con l’ambientalismo scientifico internazionale e la questione dell’emancipazione femminile come snodo di pedagogia sociale per un’equilibrata distribuzione delle risorse.
Laura Conti scomparve nel 1994. L’Italsider era già stata messa in liquidazione e smembrata in vista della sua privatizzazione, dopo lo stallo del settore siderurgico che negli anni ’80 aveva provocato la crisi dell’intero progetto italiano. La denominazione Ilva – antico nome dell’isola d‘Elba – era stata ripresa nel 1988 quando, dopo aver chiuso Bagnoli, anche Piombino fu ceduta al gruppo bresciano Lucchini. Il più grande centro siderurgico europeo, quello di Taranto, passò nel 1995 per 1.460 miliardi di lire al Gruppo Riva che aveva già rilevato Cornigliano e che poi aprì un contenzioso pagando solo in parte quanto pattuito. Quelli odierni sono gli effetti ultimi di un’industrializzazione svincolata da prospettive concrete di sviluppo, risoltasi in impianti capaci di produzioni enormi ma rigide, che non sono riuscite a innescare attività derivate per incrementare l’occupazione. A Taranto, oltretutto, la mancata predisposizione di lavori pubblici su un territorio che passava da 180mila a 260mila abitanti ha comportato la carenza di infrastrutture, abitazioni e servizi, creando paradossi come l’espansione del rione Tamburi a ridosso dell’acciaieria. Industrializzazione forzata e urbanizzazione incontrollata dentro una città in profonda trasformazione, perdita del lavoro dei cantieri navali e dell’arsenale militare, divieto di raccolta dei frutti di mare, divieto di pascolo per un raggio di 20 chilometri attorno all’area industriale e in aggiunta un prezzo enorme in termini di vite umane e salute. Perché oltre all’inquinamento l‘Ilva di Taranto detiene il record europeo di morti sul lavoro con oltre 50 vittime dal 1993 e il 20 per cento degli addetti afflitti da malattie professionali. La situazione “impone l’immediata adozione, a doverosa tutela di beni di rango costituzionale che non ammettono contemperamenti, compromessi o compressioni di sorta quali la salute e la vita umana, del sequestro preventivo” ha scritto il GIP Patrizia Todisco nell’ordinanza del 16 luglio 2012.
Un manifesto per l’attivismo ecologista
Nei loro meritevoli insegnamenti degli anni ’80 al politecnico di Milano, Bruno Mazza e Dany Sinigaglia sostenevano che in Italia il problema degli investimenti al Sud era stato posto come valvola di scarico di tensioni sociali ed ecologiche create e alimentate al Nord dalla stessa industria, contornata dal ricatto nei confronti della classe operaia più combattiva al Nord, con il surplus dell’accaparramento di sostanziosi incentivi per gli investimenti nel Mezzogiorno. Così si spiegava il trasferimento in zone meno problematiche degli impianti più dequalificati e nocivi. Un fenomeno ispirato – appunto – da una concezione neocoloniale del territorio, che rimanda agli odierni esempi di crescita basati su impianti obsoleti, enormi e inquinanti in India (Pil 2012, + 5 %) o sul modello delle maquiladoras, gli stabilimenti industriali di proprietà straniera installati in Messico (Pil 2012, + 4 %) al confine con gli Stati Uniti.
Per scongiurare la chiusura dell’acciaieria, il sindaco di Taranto Ippazio Stefàno e il ministro dell’ambiente Corrado Clini non hanno escluso di trasformare gli abitanti del rione Tamburi in sfollati, da alloggiare presso strutture abbandonate dalla Marina militare. Come a Marina di Melilli negli anni ’60, quando un borgo di pescatori sulla costa fra Catania e Siracusa fu cancellato per far posto alle industrie petrolchimiche. La scarsa credibilità delle istituzioni si riflette nelle parole del ministro, già medico responsabile dell’igiene pubblica a Porto Marghera, poi nominato direttore generale al Ministero dell’ambiente. “La chiusura dell’altoforno e della cokeria è una questione urgente. Sul piano dei danni ambientali, dell’inquinamento e della salute dei cittadini siamo già in ritardo” – così si esprimeva Clini alla fine degli anni ’90 quando l’emergenza ambientale e sanitaria coinvolgeva gli altiforni Ilva di Cornigliano, alle porte di Genova. In quella sede, nel 1999, dopo una serie di studi epidemiologici, fu raggiunto un accordo per la chiusura della produzione a caldo: troppi i morti nel quartiere genovese limitrofo agli impianti, fu la conclusione delle analisi sull’elevata incidenza tumorale nel territorio. A quella decisione seguì un’estenuante trattativa con l’azienda che seguendo un copione vissuto e rivissuto riproponeva il ricatto occupazionale. Nel 2001 una sentenza del Tar bloccò anche l’alternativa, proposta dai Riva, di sostituire il vecchio impianto con un forno elettrico, perché non era possibile proseguire nessun tipo di attività inquinante su quel sito, ormai compromesso. Quelle stesse produzioni furono trasferite a Taranto.
Nel 2012 Clini ha sostenuto che i rischi ambientali da considerare all’Ilva di Taranto “sono quelli dei decenni passati, mentre è più difficile identificare una correlazione causa-effetto sull’eccesso di mortalità per tumori nell’area con la situazione attuale che, per effetto di leggi regionali e nazionali e misure ad hoc hanno avuto un’evoluzione delle tecnologie con significative riduzioni delle emissioni, particolarmente della diossina e delle polveri”.Durante il processo all’Ilva, gli epidemiologi Benedetto Terracini e Maria Angela Vigotti hanno osservato che il ministro ignorava i risultati dello studio sugli effetti inquinanti a breve termine condotto dai consulenti del GIP: la pericolosità delle emissioni era confermata anche negli anni 2004-2008. Una cattiva interpretazione dei dati epidemiologici a totale beneficio, economico e giudiziario, degli interessi della società Ilva, anche perché secondo i dati ISTAT 1974-2009(http://demo.istat.it/unitav2012/) negli ultimi anni l’attesa di vita della popolazione tarantina è diminuita di 24 mesi.
Il caso italiano conferma che la riflessione sul passato e l’insegnamento di chi si è dedicato al tentativo di conciliare sviluppo e tutela dell’ambiente possono perlomeno aiutare a comprendere meglio la crisi nei suoi connotati attuali, primariamente ecologici. La sovrapponibilità degli avvenimenti è sorprendente perfino nei particolari. In un passaggio di L’Acna e la Valle Bormida si legge che al clima d’intimidazione in fabbrica facevano da contraltare le istituzioni che premiavano l’Acna ridicolizzando le proteste e le rivendicazioni dei contadini. Il 29 novembre 2012 a Darfo Boario Terme in Valcamonica, dove il gruppo Riva possiede tre stabilimenti, mentre i proprietari erano agli arresti domiciliari o fuggiti all’estero con l’accusa di disastro ambientale, un’associazione industriale ha consegnato a un loro delegato il premio “Imprenditore dell’anno”.
“Dovendo affrontare la crescente insostenibilità della civiltà industriale, estesasi su tutto il pianeta – spiegano Ruzzenenti e Poggio – prima che la crisi diventi senza rimedio, per trovare una via d’uscita non è sufficiente, ma è indispensabile conoscere quel che è successo”. A questa conoscenza i nuovi ecologisti dovranno aggiungere riflessioni sulle debolezze e divisioni del movimento, sulle condizioni attuali dei lavoratori e sui concetti di reversibilità e sostenibilità, da proporre a comunità scientifiche e culturali non appiattite sul primato assoluto dell’economia e sulla subordinazione al profitto di ogni altra istanza sociale, di ogni altro bisogno.
Dalla rivista Lo Straniero (www.lostraniero.net), marzo 2013 a cura di Enzo Ferrara

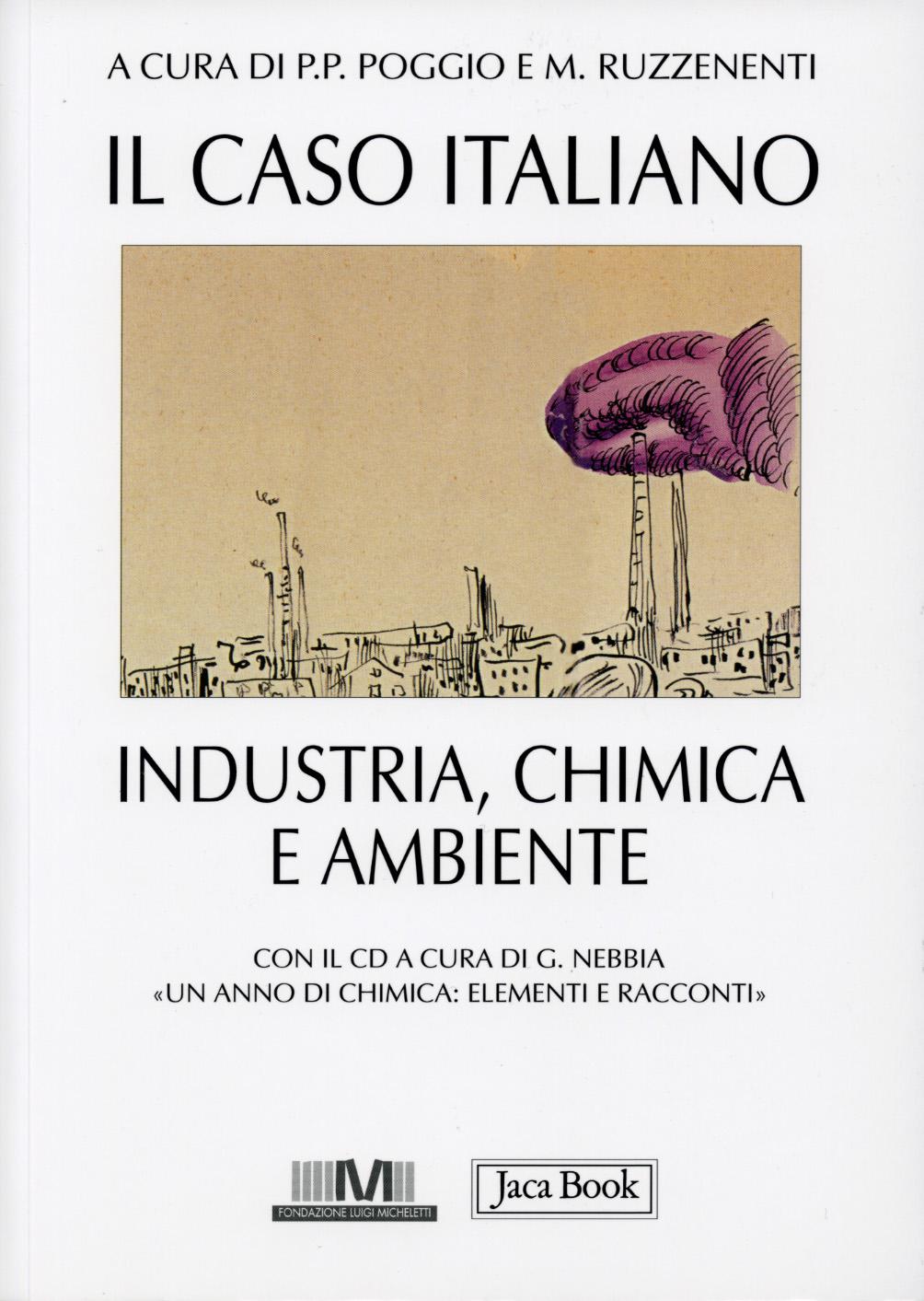


























Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!