Il mestiere di insegnare – Fiorenzo Alfieri
Questo intervento ha avuto una gestione curiosa. L’avevo già scritto, quando un sesto senso mi ha spinto a leggere un libro che avevo portato con me in montagna, di cui avevo sentito molto parlare e che non avevo ancora preso in mano: “Togliamo il disturbo” di Paola Mastrocola.
Sono contento di averlo fatto. Ho letteralmente divorato quel libro perché è a suo modo coraggioso, passionale e molto molto spiritoso. Poi mi sono rimesso al computer e ho riscritto quasi completamente il mio intervento. Quindi ciò che ascolterete è una specie di pane lievitato dalla Mastrocola.
Chi ha letto il suo libro sa che a parere dell’autrice la scuola di oggi e in particolare il liceo scientifico, ordine di scuola nel quale insegna, sono sfasati rispetto al mondo esterno e quindi circa l’ottanta per cento degli allievi li vive come una forzatura, come qualcosa che non appartiene alla loro vita, spesso come una tortura. L’autrice non ritiene che questa situazione dipenda dagli insegnanti, la cui professionalità non è mai messa in discussione in tutto il corso del libro. Le cause sono da cercarsi nelle famiglie borghesi che vogliono a tutti i costi che i loro figli frequentino il liceo e si sentirebbero umiliate qualora scegliessero un istituto tecnico o una scuola professionale; sono da ricercarsi nello Stato che non riesce a fare una seria riforma della scuola; sono da ricercarsi nei ragazzi stessi che nella stragrande maggioranza dei casi hanno come primo pensiero quello di mettersi in tiro per apparire di fronte ai compagni, sono sprofondati nel burrone dei video-giochi, dei Facebook, degli iPhone, non leggono oppure leggono solo libri di vampiri; sono da ricercarsi soprattutto negli ordini di scuola precedenti al liceo e cioè la scuola elementare e media dove da ormai quarant’anni hanno vinto i Don Milani e i Gianni Rodari, e quindi si è consolidato un modello di scuola che da una parte si tara sugli ultimi per paura di perderli per strada e dall’altra sostituisce lo studio dell’ortografia, della grammatica, della sintassi con la “grammatica della fantasia”, cioè con la creatività, la socializzazione, il divertimento. Per tutti questi motivi un liceo serio non ha più modo di funzionare e forse sarebbe meglio che, come dice il titolo, quegli insegnanti che si aspettano dai loro studenti che studino, lascino perdere e tolgano il disturbo.
Il libro è pieno di passaggi molto efficaci e mi dispiace non essere un professore di liceo perché, se lo fossi, lo leggerei ai ragazzi, come faceva e forse fa ancora Pennac nelle sue classi (lo racconta in modo mirabile nel suo fondamentale libro “Come un romanzo”). Mi piacerebbe moltissimo osservare le reazioni dei diretti interessati, specialmente ai brani che più direttamente descrivono i loro comportamenti. Sono convinto che si creerebbero dinamiche veramente molto interessanti, capaci forse di sciogliere certi blocchi cognitivi ed emotivi da entrambe le parti. La Mastrocola, a mio parere, ha scritto inconsapevolmente un ottimo libro… per ragazzi di liceo.
Ci sono in quel testo prese di posizione che io condivido pienamente. Cito le più importanti. Sono assolutamente d’accordo con la Mastrocola sul fatto che va contrastato il principio secondo il quale l’offerta educativa se vuole davvero incontrare gli strati più popolari, deve necessariamente abbassare il proprio livello. Insieme ai colleghi con cui ho collaborato per tanti anni, abbiamo cercato di dimostrare l’esatto contrario e cioè che, lavorando in un certo modo con gli alunni e con le loro famiglie nelle periferie più problematiche della città, si poteva produrre il “miracolo” di ottenere una qualità pari se non superiore a quella riscontrabile in ambienti socialmente più avvantaggiati, così da avere, dopo cinque anni di scuola, ragazzi e anche famiglie che leggevano libri in modo regolare, ascoltavano buona musica, si organizzavano per andare insieme la domenica a conoscere i beni storico-artistici della regione, facevano teatro e soprattutto organizzavano comitati di quartiere spontanei per portare i loro modi di ragionare e di agire fuori dai confini della scuola. E non mancarono casi in cui famiglie appartenenti a ceti medio-alti si complicassero la vita facendo ogni giorno lunghi viaggi in auto pur di mettere a disposizione dei loro figli certi modi di stare insieme e di capire il mondo. E questo in anni in cui quelle che si chiamavano differenze di classe erano ben più accentuate di quanto non lo siano oggi.
All’origine di questo nostro chiodo fisso, secondo il quale occorre fare ogni sforzo per alzare il livello dell’impegno culturale e morale degli alunni anziché abbassare la qualità dell’offerta per timore di perdere chi è più indietro, c’è l’insegnamento del pedagogista russo Vygotskij, il quale negli anni Venti formulò la geniale teoria della “zona di sviluppo prossimale”, che può essere sintetizzata così: il compito dell’educazione consiste nel porre accanto al soggetto da educare un’area di crescita che, grazie alla prossimità, riesca ad agganciarlo e nello stesso tempo lo spinga a fare di più, ad andare oltre. Se l’azione educativa – della famiglia, della scuola ma anche della città – non riesce ad andare oltre, allora non serve alla comunità (qui è d’obbligo il riferimento al fondamentale testo di John Dewey: “Scuola e Società”) perché la lascia nello stato in cui l’aveva trovata.
Una seconda affermazione della Mastrocola che condivido pienamente riguarda le nuove tecnologie. Ci sono in circolazione molti pericolosi fanatici secondo i quali ci troveremmo oggi davanti a una mutazione genetica della specie umana, che ha cambiato la struttura profonda della nostra cultura. E’ pur vero che, come dice il mio amico Giovanni Ferrero, è la prima volta che le tecnologie inventate dall’uomo mettono le mani nel suo cervello; ma io credo sia comunque nostro dovere utilizzarle per ciò che sono in grado di aggiungere a quelle precedenti, evitando di farle diventare un specie di buco nero nel quale vanno ad annullarsi i tanti modi di vivere e di rappresentare la natura, l’arte, la musica, la scienza che l’uomo ha inventato durante la sua storia. Il pericolo c’è e l’aveva ben capito un artista come Wim Wenders quando alla fine del suo film, di oltre vent’anni fa, dal titolo non casuale “Fino alla fine del mondo”, ci aveva mostrato gli esseri umani prigionieri ciascuno di un proprio scatolino producente immagini così seducenti da non permettergli più di distogliere lo sguardo e di rapportarsi con gli altri: tutti gli esseri umani soli con se stessi e con i loro scatolini.
Una terza convinzione della Mastrocola che è sempre stata anche la mia e di tanti colleghi è quella secondo cui uno Stato serio deve saper descrivere la sua scuola in tutto il suo sviluppo: dal primo giorno all’ultimo. La Spagna lo ha fatto, malgrado i tanti anni di dittatura: nel 1990 è in entrata in funzione una riforma che va dal nido all’università, dove quelli che a me piace chiamare i “fili lunghi della programmazione” vengono chiaramente descritti e trasformati in curricoli coerenti.
Qui finiscono le condivisioni. Andiamo avanti.
La Mastrocola è convinta che la rovina della scuola italiana stia nel fatto che non si studi più come si faceva ai nostri tempi, intendendo per studio lo stare molte ore sui libri allo scopo di assorbirne i contenuti onde poterli poi riferire al professore interrogante.
Sentite questo passaggio:
“I ragazzi mi guardano. Attenti, partecipi. L’Iliade li affascina. Mi seguono. Per un’ora, due. Sono ragazzi buoni, pazienti. Non è vero che non sono interessati a niente. D’altronde con Omero, come si fa a non venir travolti? Gli dei, gli eroi, la poesia, il mito… Sono contenta. Soddisfatta. Mi sembra che il mondo funzioni, e che io abbia una mia utilità. Io spiego, loro ascoltano. Bene.
Solo che poi li interrogo.
Che ci posso fare? La scuola è questo: l’insegnante spiega, l’allievo studia, l’insegnante interroga e l’allievo ripete. C’è anche dell’altro, naturalmente, non temete: si discute, si scherza, si parla di tante cose. Ma il nucleo-base resta questo qua. E’ la scuola fondata sullo studio. Tutto normale. Il mondo (scolastico) va (ancora) così.
Ebbene?
Dicembre, è quasi Natale. Fuori è tutto gelato e in classe i ragazzi hanno appeso due palline colorate e uno striscione con gli auguri. E’ tutto molto bianco e allegro e i miei allievi, guardateli, che carini, gentili, invernali, avvolti come sono nei loro maglioni spessi.
Un vero peccato che io li debba interrogare. Non avete idea di quanto mi dispiaccia, sotto Natale poi… Il fatto è che tutti devono avere il voto in italiano prima che si chiuda il quadrimestre, dunque è ovvio che interroghi quelli ancora senza voto. Mi capite, vero? Per precauzione, li ho avvertiti una settimana prima: siete rimasti voi quattro senza voto, ovviamente sarete interrogati. Ovviamente.
Quindi li interrogo. Vengono alla cattedra lenti, portandosi la sedia.
Non hanno studiato.
Il problema è questo: non hanno studiato.
Io faccio le domande e nessuno risponde Quattro interrogati, zero sillabe. Impreparati. Non hanno studiato. Ovvio. Se uno a domanda non risponde, vuol dire che non sa. E non sa perché non ha studiato. Giusto? Giusto.
E io non capisco perché. Questa è la domanda: perché non hanno studiato?
Li mando a posto con 4. Impreparati, quindi 4.”
D’altra parte, qualche giorno fa la stessa autrice, intervistata sull’opportunità di non usare voti al di sotto del 4 ha detto: “Non sono d’accordo. Se un ragazzo vale 2, bisogna dargli 2. Quel che è giusto è giusto”. Facile immaginare con quali criteri (ce lo ha appena detto) si decide che un ragazzo vale 2!
Ho avuto occasione negli anni scorsi di svolgere delle attività di formazione con studenti, al 99% di sesso femminile, del corso di laurea in scienze della formazione di base. Il laboratorio era abbinato al corso di fisica e riguardava l’educazione scientifica nella scuola elementare. Prima ancora di cominciare, le studentesse, che si presentavano più o meno con l’aspetto e l’abbigliamento che così bene descrive la Mastrocola quando parla dei suoi studenti, mi chiedevano di intercedere presso la docente di fisica affinché concedesse a coloro che si erano iscritti al mio laboratorio di portare all’esame un testo in meno tra quelli richiesti o almeno cento pagine o, ultimo prezzo, cinquanta. Questo mi faceva capire che in quel corso di laurea si procedeva per testi da studiare da pagina a pagina e che quindi si pensava che per diventare dei bravi insegnanti quello fosse il metodo di studio più efficace.
D’altra parte, anche nella scuola superiore si segue più o meno lo stesso sistema, usando l’elegante denominazione di interrogazione programmata. Il professore fissa il giorno in cui l’alunno sarà interrogato da pagina a pagina di un certo libro, con l’intesa tacita che nessun altro docente disturberà quella preparazione con interferenze di alcun tipo. Lo studente riempie l’hard-disk della sua memoria con ciò che è contenuto nel libro da pagina a pagina e il giorno dell’interrogazione programmata svuota l’hard-disk, con un altro implicito accordo: che mai più il materiale scaricato verrà riutilizzato e cioè che mai più a quello studente verrà richiesto quanto studiato per l’interrogazione programmata. Non c’è da stupirsi perciò che con questo metodo “riempi-svuota”, alla fine della scuola superiore l’hard-disk risulti vuoto e i docenti universitari affermino che gli studenti di cui si devono occupare non sanno nulla; e che poi lo stesso concetto venga affermato dalle imprese o istituzioni presso le quali i laureati, se ci riescono, iniziano la loro carriera. Così come non c’è da stupirsi che l’ultimo giorno di scuola da un po’ di anni a questa parte venga festeggiato con gavettoni, urla incontenibili di gioia, propositi nel caso di promozione di non fare assolutamente più niente durante i tre mesi di vacanza, quasi si trattasse della fine del servizio militare quando la leva era obbligatoria o dell’uscita dal carcere dopo qualche mese di ingiusta detenzione. Non so a voi, ma a me i servizi televisivi che con infinita faciloneria documentano la fine dell’anno scolastico nelle scuole superiori negli ultimi tempi fanno venire i brividi.
Il libro della Mastrocola mi ha riportato alla memoria un altro film: “L’angelo sterminatore” di Bu?el. Ricordate?: per tutto il film i protagonisti sono convinti che la porta della grande stanza in cui si trovano sia chiusa e che loro non possano uscire di lì. Quindi si agitano sempre di più fin quasi all’impazzimento, un po’ come di pagina in pagina avviene, con un crescendo rossiniano, nel libro di cui stiamo parlando. Contemporaneamente, fuori da quella casa ci sono delle pecore che pascolano nel prato. Alla fine del film si vede una pecora che entra tranquillamente nella stanza. Come ha potuto farlo? Semplice: la porta era aperta.
Quel ripetersi concitato dell’autrice “Tutto normale, no?…” “Ovvio” “Giusto? Giusto” corrisponde al comportamento dei protagonisti del film: “La porta è chiusa, no? Siamo prigionieri. Giusto? Giusto.” Tutto logico, all’apparenza. Peccato che la porta fosse aperta.
Quale è la porta che è aperta e che invece per tutto il tempo del film-liceo si crede sia chiusa? Che cosa c’è scritto sul campanello di quella porta? Una parola tanto semplice quanto in genere ignorata: “Capire”. Più che ignorata, sostituita con un’altra che nel libro di cui stiamo parlando diventa una sorta di mantra: “Studiare”:
E’ il capire la principale caratteristica specie-specifica dell’uomo. L’espressione specie-specifica l’ho mutuata da Chomsky, quando si riferisce alla capacità del bambino di imparare la lingua materna. Dice Chomsky: “Siamo di fronte a una capacità innata, come quella di fare il nido per gli uccelli. Se gli uccelli dovessero imparare dal nulla quella capacità, non basterebbe la loro vita, invece tre mesi dopo la nascita sono già capaci di fare un nido; allo stesso modo se i bambini dovessero imparare dal nulla una lingua come la nostra impiegherebbero decine di anni, invece riescono a farlo in poco più di un anno.”
Perché il capire è una facoltà specie-specifica dell’uomo?: perché è la sola vera risorsa di cui l’uomo è dotato. Non ha denti forti come quelli dei carnivori, non ha pelo per difendersi dal freddo, non ha muscoli per spaccare i tronchi e le rocce. Ha soltanto un sistema cognitivo che lo rende capace di rappresentarsi la realtà così da poterla gestire e lo fa affrontando e cercando di risolvere in modi i più adatti possibile i problemi che gli si presentano.
Trattandosi dell’impulso naturale più forte di tutti gli altri, non ci deve stupire che un bambino anche molto piccolo riesca a resistere abbastanza a lungo senza mangiare e senza dormire ma non possa tollerare neppure un momento di noia e cioè la mancanza di stimolanti esperimenti sul mondo. Più un bambino è dotato di un sistema cognitivo potente più, specie nei primi anni, risulta impegnativo agli adulti che si curano di lui. Questo perché quel sistema cognitivo è sì potente ma non ancora strutturato al suo interno e la strutturazione avviene solo a condizione che il bambino possa compiere esperimenti sugli aspetti del mondo che via via più lo interessano e lo intrigano.
Questo è quello che fa spontaneamente il bambino fin da quando viene alla luce e quando arriva a scuola, a sei anni, si è già costruito delle idee abbastanza funzionali su più dell’80% delle cose del mondo. A quelle idee si è affezionato perché sono partite dai suoi interessi e sono state edificate con materiali di costruzione che sono tutti suoi. Certamente sono stati importanti gli stimoli che ha ricevuto dal sistema familiare e sociale in cui vive, ma senza la sua partecipazione emotiva e senza i suoi materiali di costruzione le idee non si sarebbero formate e soprattutto non sarebbero rimaste attaccate al suo sistema cognitivo, non sarebbero diventate carne della sua carne.
Ovviamente la scuola non può accontentarsi di ciò che il bambino ha già imparato, e continua a imparare nel tempo libero, con un metodo che potremmo definire naturale, ma non può neppure pretendere di andare contro natura. Se lo fa non si deve stupire che gli studenti non amino la scuola e non sappiano studiare.
La porta è aperta ma noi non sappiamo imboccarla e ci stupiamo quando una semplice pecora invece ci dimostra che il problema siamo noi.
Eppure basterebbe riflettere sulla nostra personale esperienza e chiedersi quali sono le conoscenze che sono riuscite a diventare carne della nostra carne. Oppure ricordare cosa successe ad Archimede quando, mentre faceva il bagno, riuscì improvvisamente a capire come fanno i corpi a galleggiare, mettendo per la prima volta in rapporto tra di loro i tanti dati di cui già disponeva ma che non era mai riuscito a inserire in un racconto coerente: andò in giro nudo per Siracusa gridando: “Eureka! Ho capito!”. Si tratta del piacere più grande che un essere umano può provare.
Proviamo a fissare qualche paletto. Il primo lo abbiamo già in parte incontrato. La nostra mente non fotografa la realtà, se la rappresenta, la interpreta, le attribuisce significati; ogni mente a suo modo. Qui ci aiuta Bruner: il significato sta all’incrocio tra epistemologia e ontologia; è cioè una medaglia a due facce: su una c’è il contenuto della cosa che si vuole capire, sull’altra l’interesse che proviamo per essa; su una c’è la cognizione sull’altra l’emozione. Sempre Bruner ci dice che il significato quando è stato costruito viene espresso essenzialmente con linguaggio narrativo: un linguaggio che può raggiungere alti livelli di astrazione ma che si “attacca” a noi soltanto se conserva il fondo narrativo dal quale è partito (abbiamo già detto di Archimede, ma anche lo stesso Newton ha spiegato che non sarebbe mai riuscito a trovare la formula della gravitazione universale se prima nella sua mente le scoperte dei giganti che lo avevano preceduto non avessero preso la forma di una narrazione capace di rendere ragione in modo coerente di ciò che succede nell’universo).
Ancora Bruner ci dice che la cultura è negoziazione di significati all’interno di un gruppo di persone interessate a risolvere un problema e cioè a capire una cosa non ancora capita e quindi non ancora narrabile nella sua anatomia e fisiologia, se così vogliamo dire.
In questa filiera concettuale abbiamo incontrato parecchi altri paletti. Innanzitutto ci vuole un problema da cui partire. Nella vita, fuori dalla scuola, non c’è che l’imbarazzo della scelta e infatti il bambino nei primi anni di vita, i più produttivi come abbiamo visto dal punto di vista cognitivo, segue le sue strade e si arrabatta come può. A scuola è giusto che sia l’insegnante a porsi gli obiettivi culturali che sono necessari affinché la scuola, come voleva Dewey, abbia ricadute positive sulla società. E’ altrettanto giusto che per ogni obiettivo l’insegnante individui i percorsi più convenienti per raggiungerlo, con una certa elasticità ma anche con chiarezza e determinazione.
Ogni percorso però dovrebbe rispettare gli altri paletti che sono emersi. L’incipit del percorso, come abbiamo detto, deve essere ficcante per il gruppo, deve suscitare il suo interesse. Capisco che non sia facile ma credo che si possa essere tutti d’accordo sul fatto che il mestiere di insegnante è sì il più bello del mondo ma anche uno dei più se non difficili certamente impegnativi. Bisogna essere capaci di svegliare l’interesse degli alunni.
Altro paletto fondamentale: fare cultura significa negoziare significati all’interno di un gruppo. A che scopo? Allo scopo di trovare una soluzione che ci paia logica e gratificante del problema di cui ci stiamo occupando. In alcuni casi basta la conversazione, in altri ci vuole la sperimentazione intesa nel significato più ampio. Prima viene la conversazione poi gli eventuali esperimenti, poi ancora la costruzione di una narrazione che il più possibile si aggiusti con i dati di realtà di cui ci stiamo occupando, infine il prosciugamento della narrazione in quella che in termini tecnici si chiama teoria ingenua.
Il mio corso universitario si intitolava: “Il laboratorio di scienze: una palestra del capire”. Questo perché in scienze il processo di costruzione di conoscenza è più evidente che in qualsiasi altro campo. Ci sono fenomeni della natura davvero spettacolari, che se ben presentati non possono lasciare indifferenti, a partire dai più semplici come ad esempio lo scioglimento dello zucchero in acqua. Chi è capace di raccontarlo come fosse una buona narrazione? All’inizio della ricerca nessuno, come avverrebbe nel caso volessimo provare qui tra noi sull’istante.
Allora ripetiamo: prima si sceglie il fenomeno da capire, poi si parla di quello che si vede, poi si interroga la natura con esperimenti mirati che ci facciano vedere altre cose ancora e ci permettano di ampliare il campo delle conoscenze già presenti nel gruppo, poi si costruisce insieme una narrazione il più possibile coerente con ciò che è avvenuto sotto i nostri occhi, poi si prosciuga la narrazione in una teoria ingenua.
Quando il gruppo è stato capace di elaborare una teoria ingenua ed è orgoglioso di averlo fatto, allora si può procedere all’innesto su questo orgoglio della conoscenza consolidata. Questo altro paletto è fondamentale: non c’è nessuno spontaneismo in quanto sto dicendo, nessun rifiuto dello studio sistematico di ciò che le discipline di riferimento ci propongono. Nessuna taratura sugli ultimi per il terrore di lasciarli indietro, nessun ricorso al gioco e al divertimento in sostituzione dello studio serio. C’è solo la convinzione che sia indispensabile l’innesto della cultura formalizzata su quella ingenua, costruita con le nostre teste, le nostre idee, la nostra passione, il nostro sforzo. Se questo innesto avviene, anche lo studio del libro diventa necessario e appassionante e produce conoscenza che si attacca alla mente per non staccarsi mai più.
La verifica ce l’abbiamo nel momento in cui anche la conoscenza formale, quella acquisita studiando le formule contenute nei libri, viene espressa con il linguaggio naturale/narrativo, quello stesso con cui si è discusso all’inizio del processo e si è creata negozialmente la teoria ingenua. Il linguaggio naturale deve stare sia all’inizio sia alla fine del processo di costruzione di conoscenza. Ecco perché il modello che ho sinteticamente presentato si chiama modello a loop. E questo, se vogliamo, è l’ultimo paletto che ci poniamo.
Come ho detto, nel laboratorio di scienze un processo del genere è più facile da seguire. Molti fenomeni della natura fortemente stimolanti sono riportabili nel laboratorio; discuterne attivando le conoscenze previe viene spontaneo; sperimentare altrettanto; e anche il cercare di raccontare in modo efficace la storia dello zucchero che si scioglie nell’acqua o dell’acqua che diventa ghiaccio o del seme che diventa pianta è il naturale sbocco della dinamica conversazione-esperimento. Allo stesso modo, l’andare a cercare nei libri la spiegazione “ufficiale” del fenomeno di cui ci siamo occupati e l’innestare quella spiegazione nella teoria ingenua che ci siamo costruiti con le nostre mani, non presenta nessuna forzatura. Se ben condotto tutto il processo è in grado di entusiasmare allo stesso modo in tutti i suoi passaggi, compreso lo studio del libro, e di far dire ai ragazzi, come è successo durante il decennio che ha visto impegnati parecchi di noi sperimentare il laboratorio di scienze in un gruppo di scuole elementari della nostra città, che a loro piaceva andare a scuola perché c’era il laboratorio di scienze.
(A proposito dei corsi tenuti all’Università, ho potuto constatare che malgrado il punto di partenza fosse quello di cui ho prima parlato, dopo venti ore la quasi totalità delle studentesse scriveva nella scheda di valutazione del corso cose commoventi di questo tipo: “Ma se questa è la proposta noi ci stiamo!”. “Ma perché l’università non è tutta così?”. Allora forse non tutto è perduto…)
E’ per questo che a me pare che il laboratorio di scienze sia una palestra del capire e che in esso ci si possa allenare proprio come si fa in una palestra, per poi utilizzare la nostra mente allenata in tutte le altre aree disciplinari. Ma mi rendo conto che ci siano docenti che considerano “palestre” altre discipline, a seconda della loro preparazione e delle loro personali “intelligenze”. E va bene così, ci mancherebbe.
A proposito di “intelligenze” devo osservare che la Mastrocola presenta come una scoperta sorprendente il fatto che non tutti siamo uguali dal punto di vista degli interessi, delle propensioni, degli stili cognitivi. Forse non sa che è dall’inizio degli anni ottanta che si parla di “intelligenze parallele” e che i nuovi programmi delle scuole elementari e delle scuole materne si sono ispirati a quella teoria. Diciamo che dopo Don Milani e Rodari qualche passo avanti si è fatto!
Tornando alla specificità delle diverse discipline, credo che i principali paletti che ho ricordato, nei loro aspetti generali, valgano per tutte e che sia importante che si respiri durante il viaggio cognitivo che gli alunni realizzano nella scuola, da un’area disciplinare all’altra, un’atmosfera non dico omogenea ma almeno assonante.
Così si potrebbe passare dall’imparare a memoria al capire, dall’affannosa ricerca di mnemotecniche che permettano di apparire preparati al momento dell’interrogazione alla costruzione di conoscenze durature, dalla scuola che non si vede l’ora che finisca a una scuola che accoglie e appassiona.
Cosa avviene invece nel tipo di scuola così efficacemente descritto dalla Mastrocola? L’innesto dei contenuti del libro, anziché su un percorso di costruzione di conoscenza come quello che ho prima ricordato, avviene sul nulla o meglio sul mantra del cosiddetto studio serio. Sembra impossibile che non ci si renda conto che a queste condizioni non può avvenire nessun innesto, che la scuola non può che essere vissuta dalla maggioranza degli alunni come un luogo di tortura e dagli insegnanti come un inferno. Eppure succede proprio così; proprio come nel film di Bu?el!
Bisogna partire dell’inizio, da quando i bambini sono piccoli ed è facile appassionarli. Questo è il vero presupposto. Mi ha sempre colpito sentir dire da un mio alunno, nipote di un celebre filosofo della scienza, che veniva tutti i giorni portato dal centro città in cui abitava all’estrema periferia in cui insegnavo: “Ho finito di capire con la quinta elementare; poi ho fatto finta di imparare per essere promosso.” Non sarebbe stato meglio che avesse continuato a capire anche dopo la scuola elementare? Dal momento che è stato possibile prima, perché non anche dopo?
Per tanto tempo, ho segnalato ai giovani insegnanti in formazione, come indicatori di qualità imprescindibili per una scuola, specialmente se di base, comportamenti molto semplici ma per me molto significativi, ai quali ho personalmente assistito in tante occasioni, come i seguenti:
1) genitori che vengono a scuola il lunedì mattina e raccontano all’insegnante che il loro figlio il sabato, quando ha scoperto che non sarebbe stato accompagnato a scuola, si è messo a piangere;
2) gruppo classe che esce costantemente per ultimo da scuola, con disappunto di genitori e nonni, perché difficile da convincere a lasciare il lavoro al suono della campanella, accolta costantemente da un “Oh, no!”;
3) bambino che alla fine dell’intervallo in cortile chiede all’insegnante: “Cosa si fa adesso?” e sentendosi rispondere: “Divisioni” grida ai suoi compagni: “Ragazzi, divisioni!!!”;
Chi conosce i bambini sa bene che non piangerebbero per venire a scuola di sabato e non sarebbero infastiditi dalla campanella che interrompe il lavoro, se a scuola si perdesse tempo in sciocchezze. I bambini sono intrigati dalla costruzione di conoscenza non dai trastulli. Se li occupassimo con quelle vacuità che la Mastrocola è convinta vengano propinate nei primi otto anni della scuola dell’obbligo, ci guarderebbero con sufficienza e si lancerebbero palline tra di loro. Ma chi non lavora con i bambini queste cose non le sa.
Come ho già detto, bisognerebbe che i diversi ordini di scuola funzionassero d’intesa, pur nelle ovvie differenze. A me non pare sia impossibile raggiungere questo obiettivo. Basterebbe che le conquiste della scienza cognitiva, che si occupa di come si costruisce conoscenza, siano messe a disposizione di tutti gli insegnanti e siano anche a fondamento delle riforme. Si tratta di conoscenze del tutto accessibili a persone mediamente colte. Poi bisognerebbe mettere a disposizione degli insegnanti esempi di programmazione a lungo termine che dimostrino da dove è bene partire e quali sono le tappe del lungo viaggio che va dalla scuola materna alla scuola superiore. Bisognerebbe poi mettere a disposizione degli insegnanti esempi di attività che hanno avuto successo, cioè sono riuscite a far capire, ad appassionare, a far stare bene a scuola, a fornire un metodo di studio che sia un pezzo di vita e non solo una mnemotecnica. Esempi di buona programmazione e di attività di successo ce ne sono tanti perché sono tanti gli insegnanti che, malgrado tutto, lavorano egregiamente: bisognerebbe aiutare tutti, e specialmente i più giovani, a seguire quegli esempi.
Ricordo che quando conquistammo il tempo pieno nel lontano 1970, nel pacchetto c’erano anche 250 ore all’anno di aggiornamento obbligatorio, in quanto facenti parte dell’orario di lavoro. Ricordo anche che negli anni successivi, ogni volta che si costituiva presso il Ministero il tavolo di lavoro per rinnovare il contratto, i rappresentanti dei lavoratori chiedevano che in cambio di aumenti economici che non erano possibili si riducessero almeno quelle inutili ore di aggiornamento. Questo fino al loro odierno totale azzeramento.
Prima di pensare alla valutazione non sarebbe opportuno ricreare le condizioni affinché gli insegnanti possano costantemente perfezionare il loro mestiere studiando, sperimentando e mettendo a punto i loro modi di operare? Anche in questo caso appare sorprendente che un concetto così elementare faccia fatica a passare, che una porta così semplice da valicare si continui a pensare che è chiusa.
Se non ci si pronuncia su come sarebbe davvero giusto fare scuola e ci si limita a valutare l’esistente, non si uscirà mai da un modello di scuola che si rivela inadeguato alle aspettative della società. L’insegnante abbandonato a se stesso nella zona della sua professionalità più importante e sensibile, quella del come si fa per aiutare gli alunni a costruirsi conoscenze durature, non può che trovare approdo nella suola dell’apprendimento da pagina a pagina.
I test valutativi vorrebbero sondare l’acquisizione di conoscenze durature, duttili, adatte alla società contemporanea, però chi impara da pagina a pagina, appena viene minimamente spostato dal trantran a cui è abituato, si confonde e sbaglia. Perciò quei test finiscono per decretare il fallimento del sistema. Il che se vogliamo è l’unico lato buono di questo tipo di valutazione. Peccato che quel giudizio purtroppo non serva alla scuola per migliorare se stessa.
Come dicevo, penso sia opportuno riprendere il discorso da capo, quando forse troppo ingenuamente si pensava che prima di ogni altra cosa dovesse venire la capacità dell’insegnante di fare bene il suo mestiere. Un mestiere che contiene anche la valutazione, ovviamente, ma che prima di ogni altra cosa richiede idee e tecniche di natura professionale, i cosiddetti ferri (e trucchi, perché no?) del mestiere, e modelli di riferimento. Credo si tratti di un fatto normale, quasi banale. Il sarto prima di consegnare il vestito che ha confezionato deve certamente controllare che tutto sia a posto; ma prima deve pur costruirlo quell’abito! E per costruirlo deve avere un modello in carta e disporre di capacità professionali che gli consentano di tagliare e cucire nei modi opportuni affinché quel modello si adatti alla corporatura e al gusto del cliente. Se non ha un modello e se non ha le capacità per trasformarlo in un abito, è piuttosto probabile che la verifica del suo lavoro fornisca un esito negativo, come purtroppo mi pare stia succedendo con le prove di valutazione che stanno tormentando i sonni degli insegnanti e dei dirigenti scolastici.
Da quanto mi viene raccontato da chi lavora da tempo nella scuola e ricorda con nostalgia i tempi in cui si cooperava per individuare contenuti e metodologie per far bene il mestiere di insegnante, tutte le poche energie che sono rimaste vengono oggi indirizzate verso la valutazione e più nessuno si preoccupa che l’insegnante, specie se giovane, venga aiutato a costruire la propria professionalità.
Vi voglio raccontare, per finire, un’esperienza che ho vissuto parecchi anni fa con Silvana Mosca, quando siamo andati a Ginevra per conoscere l’organizzazione della scuola di base in quella città-cantone. Ci siamo trovati di fronte a una situazione di questo tipo. Ogni anno viene ammesso al relativo corso di formazione universitaria un numero di studenti corrispondente a quanti saranno i posti disponibili quattro anni dopo. Metà dei posti sono riservati ai maschi e metà alla femmine, perché si vuole che i bambini abbiano rapporti educativi con entrambi i sessi e non con uno solo. Lo stipendio previsto è quello di un buon professionista e quindi anche i maschi dotati di intelligenza pedagogica (i “maestri nati”) non vengono disincentivati dal punto di vista economico. La selezione avviene proprio in base a quella particolare dote. Il tirocinio e cioè il rapporto diretto con i bambini avviene prima della selezione e non, come da noi, alla fine del corso di studi. Vengono ammessi soltanto i soggetti che dimostrano una chiara propensione per il mestiere di educatore e il piacere di stare con dei bambini. Dopo quattro anni di studio i nuovi insegnanti entrano nella scuola e per otto anni dispongono di un tutor che è un maestro esperto, a sua volta dotato per la formazione di un giovane collega. Ogni cinque anni si può avere un anno sabbatico durante il quale si partecipa ai gruppi di produzione dei materiali didattici che vengano forniti agli insegnanti affinché possano operare secondo le metodologie più aggiornate. Alla nostra richiesta al ministro dell’educazione su come era possibile per quella città-cantone destinare così tante risorse alla scuola di base, la risposta è stata: “La nostra città fonda il suo benessere sull’intelligenza. Se non investissimo in intelligenza fin dalla scuola di base, non faremmo gli interessi della nostra comunità”.


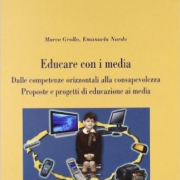
























Ancora una volta Fiorenzo Alfieri, in modo pacato e sereno, con la sua grande cultura e la sua lunga esperienza, mette a fuoco il rischio che la scuola corre ormai da qualche anno, e non è soltanto riconducibile ai miseri investimenti di cui spesso si parla. Il rischio maggiore, a mio giudizio, è l'assenza di un dibattito approfondito, lontano dalle attuali polemiche sugli aspetti contingenti, anche se dolorosi, capace di riportare la scuola al centro dell'attenzione generale di questo Paese. Su questo piano, il piano sul quale si muove Fiorenzo Alfieri, penso si possano realizzare convergenze di pensiero e di proposta, oggi impensabili.
Chissà se, ai tempi della mitica Nino Costa, ci avessero detto che la scuola sarebbe finita in queste condizioni … perchè le sperimentazioni ( come il Tempo Pieno), dopo essere state sperimentate per decenni non sono mai diventate "norma"? Sto leggendo il nuovo libro di Fiorenzo e, ripercorrere quelle esperienze, mi fa veramente male. Dove sono finite le idee portanti di quel periodo? Per fortuna sono tra i fortunati che sono riusciti ad andarsene, in pensione, prima che la scuola da luogo in cui crescere insieme ai bambini diventasse prigione dove morire, a danno dei bambini. Marica Barbaro
Buonasera ; ho tra le mani un libro ,"polenta e castagne", autrice una Sua omonima, o forse proprio Lei ! Se fosse Lei, vorrei solo lasciarLe un complimento e un'espressione di riconoscimento per il suo interesse e il suo sforzo nella ricerca delle radici popolari , che anch'io ritengo fondamentale ; grazie e buone cose .
Solo chi non ha provato cosa voglia dire essere dentro una classe MCE, ed espressamente all'interno della classe di Ornella Papa e Fiorenzo Alfieri puó condividere il libro della Prof. Mastrocola (che ho letto).
A riguardare quegli anni da questo punto (2014) mi rendo conto di vivere ancora di rendita a proposito degli stimoli (non lezioni) ricevuti ma, soprattutto, all'abitudine ala libertá, non solo fisica ma di pensiero. Una frase sopra tutte, che é anche una fotografia: su di un uovo di pasqua che non volevo condividere con i miei compagni-"non é tuo, é di tutti", bene, ora questa frase la vorrei vedere scritta, proprio oggi, su tutti i muri d'Italia.
Ciao, Massimo Pancaldi