Riguardo a questa rubrica
Jake Lynch ha cominciato a scrivere regolarmente questa rubrica per Transcend Media Service nel novembre 2008. Da allora si è procurato molti nuovi seguaci nel mondo, alcuni dei quali così gentili da mandare messaggi di apprezzamento! In questo articolo, pubblicato in tre parti nella versione originale, spiega le motivazioni che stanno dietro a questo lavoro, alcune delle idee guida e il campo d’intervento. Un invito a esplorare gli archivi TMS!
Parte 1: Prospettive critiche di pace sulle notizie
Che cosa ricordate delle notizie? Che cosa accadde a Mumbai, nel novembre 2008, o a Baghdad nel giugno 2009? (vi darò un indizio: bang!) Provate con l’associazione di parole: Somalia = pirateria; Birmania = monaci; Sri Lanka = cricket; Palestina = terrorismo; West Papua = …eh, dov’è? E chi sono i cattivi? I taliban; i terroristi; Hugo Chavez?
Vi viene mai la sensazione che ci sia qualcosa che non vi viene detto? Che cadano via dei frammenti dalle notizie prima che raggiungano i lettori e gli ascoltatori? Provate a ripensare a storie di conflitto, e magari vi tornano in mente in qualche caso chi, che cosa, dove e quando. Ma rispetto al come? E alla domanda cruciale, perché?
I media oggigiorno operano sotto costante pressione delle scadenze, della televisione su 24 ore, e della rete, impassibile. Fra il bagliore intenso della videocamera e quel che è stato definito lo “sguardo distratto” della nostra condizione postmoderna, potremmo cogliere gli stessi nudi fatti ripetuti senza sosta da qualunque emittente per circa cinque minuti prima che l’attenzione si sposti altrove. Quel che manca è il contesto.
Questa rubrica ha registrato il palinsesto globale di un anno nel nostro mondo interconnesso e interdipendente, aggiungendovi lungo il cammino contesto e sfondo. Se il giornalismo è la prima bozza della storia, allora questo è la prima bozza di una storia alternativa, che di solito rimane nascosta al di sotto di interessi particolari e pretese politiche.
Alcune puntate si basano su ricerche originali; altre su reportage compiuti in una data specifica, e comprendono Ramallah in Palestina; Stavanger in Norvegia; Chiang Mai in Thailandia e Cleveland in Ohio. Altre ancora prendono la forma di argomentazioni per una reazione specifica a una determinata situazione sotto esame. Finora, hanno trattato avvenimenti negli Stati Uniti, in Australia, Regno Unito, Indonesia, Birmania, Venezuela, Somalia, India, Sri Lanka, Israele e Palestina, Afghanistan, Pakistan, Mali, Mauritania e altri ancora. Sono stati trattati temi come povertà globale, armi nucleari, diritti umani e ruolo primario della cultura nel plasmare le risposte ai conflitti.
Mettono in evidenza ciò che sta fuori dal contesto, e perché. Tracciano gli schemi di omissione e distorsione nel modo di rappresentare i conflitti ed esplorano cosa questo significa per la nostra comprensione e anche come potrebbe influire sulle azioni e motivazioni di coloro che sono coinvolti.
Dunque la rubrica prende spunto da avvenimenti, notizie e processi per fare ricerche in importanti teorie sulla cultura in generale – e sui media in particolare – e sulle loro relazioni e influenze sulle nostre vite, come pure in questioni chiave del settore accademico noto come Studi su Pace e Conflitto, ossia Ricerca per la Pace.
Ho mostrato:
– Come l’America sia passata dall’essere un paese di solito in pace a uno di solito in guerra. Gennaio – mese inaugurale per il presidente Obama – ha segnato 805 mesi dall’entrata degli USA nella seconda guerra mondiale, dopo l’attacco a Pearl Harbor nel 1941, dei quali 403 passati in guerra;
– Come l’Australia abbia il ministero degli esteri più smidollato di qualunque paese democratico al mondo. Canberra è l’unica capitale mondiale a non aver emesso neppure un pigolio di condanna sia per l’attacco di Israele a Gaza, nel periodo del capodanno, sia della successiva vittoria militare del governo dello Sri Lanka sui ribelli delle Tigri Tamil. Molti altri casi erano ‘coperti’ in dichiarazioni formulate da enti quali la UE, l’OAS o l’ASEAN, anche se non ne hanno emessa una propria;
– Come i giornalisti siano diventati in breve tempo seri nel riferire tematiche attinenti al diritto internazionale nel conflitto Israele-Palestina, contribuendo presumibilmente al commissionare da parte ONU il rapporto Goldstone, pietra miliare nel suo genere, che accusava sia Hamas sia Israele di crimini di guerra e Israele di crimini contro l’umanità;
– Come l’essere a favore dei diritti umani non ci lasci altra scelta che opporci alle guerre, anche se molte organizzazioni per i diritti umani in Occidente tentino ancora di mantenere certe distinzioni;
– Come le emittenti pubbliche trasgrediscano i propri obblighi di riferire dell’opposizione alla continua deriva nel militarismo, con particolare attenzione alla trattazione dell’Australian Broadcasting Corporation dello straordinario riarmo in un paese senza nemici;
– Come il crescente divario globale fra ricchi e poveri minacci di farci precipitare in una nuova era di conflitto, con la cancellazione in molti casi di qualche progresso nell’alleviare la povertà per via delle ricorrenti crisi nei mercati mondiali degli alimenti e della finanza.
E molti altri angoli nascosti, contesti e retroscena che ci servono per cominciare ad attribuire senso agli avvenimenti e ai processi storici che formano la realtà in cui viviamo.
Parte 2: Giornalismo di Pace
L’ispirazione è il giornalismo di pace, un insieme di distinzioni nel reportage, una nuova “scatola degli attrezzi” per giornalisti e loro redattori e una causa per una campagna sia per riformatori di media che per attivisti per la pace. Questa rubrica ha tentato di mostrare cosa si intende per giornalismo di pace, quando venga applicato all’agenda delle notizie settimana per settimana, e commentando altresì gli aspetti concettuali che sorgono strada facendo. Che cos’è dunque il giornalismo di pace? Una definizione:
Si ha giornalismo di pace quando redattori e reporter fanno scelte su che cosa e come riferire, che creano opportunità alla società nel suo complesso di considerare e valutare risposte nonviolente ai conflitti.
Se poi la ‘società’ decide di preferire la guerra alla pace, non c’è più altro che il giornalismo possa fare, rimanendo tale. D’altro canto, non è un impegno paragonabile a quello di assicurare udienza equa alle risposte violente, non fosse altro perché di rado lottano per trovar posto nell’agenda delle notizie.
Perché questo? Riferire è scegliere. ‘Riferiamo solo i fatti’, dicono i giornalisti, ma ‘i fatti’ sono una categoria di dimensioni pressoché infinite. Perfino in questi tempi di profusione mediatica, è una categoria da restringere, filtrare, per diventare notizia. Il giornalista è un ‘portiere’ che permette a certi aspetti della realtà di passare, emergere, ammiccare all’occhio pubblico, mantenendo il resto al buio.
Né questo è un procedimento casuale. Ciò che viene tralasciato è sempre o di solito quanto Johan Galtung mostrò per primo nel lontano 1965 nel suo fondamentale saggio (con Mari Holmboe Ruge), The Structure of Foreign News (Galtung, Johan, and Mari Holmboe Ruge. “The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers.” Journal of Peace Research 2 (1965): 64-91, ndt). Le notizie generalmente preferiscono:
- le fonti ufficiali a quelle ‘di base’;
- gli eventi ai processi;
- presentare qualunque conflitto come una battaglia fra due parti per la supremazia.
Tali preferenze, o tendenze distorte, si consolidarono in convenzioni settoriali allorché il giornalismo cominciò a essere venduto come merce prodotta in serie per società di consumatori, affrontando pressioni per presentarsi come ‘tutto-quanto-per-tutti’ in grado di venire commercializzato ai potenziali lettori, ascoltatori e spettatori di ogni opinione politica dominante e di nessuna. Così facendo, il ‘sentire prevalente’ ovviamente s’indurisce come cemento, soffocando definitivamente introspezioni e prospettive da altre direzioni.
Citare funzionari – categoria in cima alla quale c’è il leader politico del proprio paese – è una scelta e una preferenza, ma con alibi incorporato. Non è ‘colpa’ nostra se il/la tale è diventato/a capo del governo: lo ‘è’ semplicemente. ‘Indicizzare’, ossia la diffusa abitudine giornalistica di restringere l’ampiezza del dibattito alle differenze fra governo e opposizione ufficiale – ‘discordia d’élite’ – ha lo stesso effetto, di camuffare le scelte da fatti.
E per quanto riguarda il prevalere dell’evento sul processo? Una notizia che indugi, diciamo, sui particolari di morte e distruzione provocate da una bomba, evita controversie: l’ordigno è indiscutibilmente esploso; ci sono dati ben documentati sulle vittime, da fonti affidabili come ospedali e polizia. Ciò che è automaticamente più controverso è sondare perché lo abbiano fatto, qual è il processo che li ha condotti a tanto, per quali rivendicazioni e motivazioni.
In quanto al dualismo, beh, quand’ero reporter alla BBC, ci rendevamo tutti conto che una carriera di successo poteva basarsi sulla formula: ‘da un canto… d’altra parte… alla fine solo il tempo potrà dire’. Avere ‘equilibrio’, ‘sentire tutte e due le campane’, è un modo affidabile per isolarsi contro obiezioni di unilateralità, o partigianeria. Appena si stanno a sentire prospettive multiple, ci si espone a ulteriori lamentele.
Ci sono ragioni nel profondo, allora, perché queste siano le convenzioni dominanti nel giornalismo, ma, prese insieme, vogliono dire che il suo inquadrare i dibattiti pubblici su tematiche di conflitto è generalmente dalla parte delle risposte violente; meritando la definizione di ‘giornalismo di guerra’.
Come mai? Prendiamo le tre convenzioni in ordine inverso, cominciando col dualismo. Se si comincia a pensare a un conflitto come un tiro alla fune fra due grandi avversari, qualsiasi mutamento nella loro relazione – qualsiasi movimento – può aver luogo solo lungo un singolo asse; proprio come nel tiro alla fune un metro guadagnato da un lato corrisponde a un metro perso dall’altro. Pertanto qualunque sviluppo in un conflitto così concepito comporta immediatamente di essere valutato in una partita a somma zero. Qualunque cosa non sia inequivocabilmente un vincere rischia di essere riferita come un perdere, recando con sé un incentivo bell’e fatto a intensificare gli sforzi per la vittoria. I soggetti coinvolti in un conflitto ‘parlano duro’, e spesso ‘agiscono duro’, recitando personaggi creati dai media.
Si tolgano gli avvenimenti – come atti di violenza politica – dal contesto e si rimane solo con la violenza come possibile risposta. Ecco perché ci sono così poche notizie sulle iniziative di pace. Se non sono visibili le cause profonde, non c’è nulla da ‘sistemare’. Solo in questa forma di reportage sembra aver senso considerare il ‘terrorismo’ come qualcosa cui è possibile o sensato fare la ‘guerra’.
E se si aspetta, per riferire di cause profonde o iniziative di pace, che faccia comodo ai leader politici trattarle o impegnarsi per affrontarle, si potrebbe attendere a lungo. Gli stimoli alla pace quasi sempre cominciano ad agire a livelli inferiori. C’è inoltre una leva in mano al governo che nessun altro ha: l’uso ‘legittimo’ della forza militare. Per queste ragioni, il primato delle fonti ufficiali, accoppiato al persistente orientamento nazionale di gran parte dei media, è destinato a distorcere la rappresentazione dei conflitti, rendendoli ricettivi ad argomentazioni a favore della violenza.
Quindi, giornalismo di pace, come modo per compensare tali distorsioni e dare una chance alla pace. Il giornalismo di pace:
- esplora i retroscena e i contesti della formazione del conflitto, presentando cause e opzioni su ciascuna parte (non solo ‘entrambe le parti’);
- dà voce alle opinioni di tutti i rivali, di tutti i livelli;
- offre idee creative per la risoluzione del conflitto, lo sviluppo, la costruzione della pace (peacemaking) e il mantenimento della pace (peacekeeping);
- espone le menzogne, i tentativi di copertura e i colpevoli di tutte le parti, e rivela gli eccessi commessi dalle, e le sofferenze inflitte alle, persone di tutte le parti;
- presta attenzione alle storie di pace e agli sviluppi del dopoguerra.
Parte 3: Realtà e rappresentazione
Il giornalismo di pace è più realistico, nel senso di fedeltà a una realtà già esistente, indipendentemente dalla conoscenza o rappresentazione che ne abbiamo. Riferire sulla violenza senza sfondo o contesto è malrappresentarla, giacché qualunque conflitto è, in radice, una relazione di parti che si contrappongono e perseguono obiettivi incompatibili. Ometterne ogni trattazione è una distorsione.
Nel contempo si riconosce che non c’è una singola versione corretta di tale realtà su cui tutti concordino. Noi capiamo il mondo che ci circonda captandone messaggi e immagini – comprese quelle ammannite mediante le notizie – e inserendole in codici che sviluppiamo nel corso della vita e ci portiamo nella testa. Il significato non si crea solo al momento della produzione, ossia la codifica; nessun atto di rappresentazione è completo finché sia stato ricevuto, ossia decodificato: una concezione che è stata proposta per la prima volta in questa forma dal guru degli Studi Culturali Stuart Hall.
La decodifica è qualcosa che facciamo spesso automaticamente, dato che molto di ciò che leggiamo, udiamo e vediamo ci è famigliare. Questo è appunto ciò su cui si basa la propaganda. Mostrare Saddam Hussein come un cattivo, o le armi di distruzione di massa come una minaccia forma un prisma attraverso il quale si tende a vedere tutta la realtà, sia precedente sia successiva. Così si fissa efficacemente un significato.
Il giornalismo è sovente facile preda della propaganda perché generalmente non ci spinge a riflettere sulle scelte che opera, per i motivi anzidetti. Il famoso conduttore televisivo (anchor-man) USA, il defunto Walter Cronkite, concludeva ogni sera il notiziario serale CBS con l’espressione “ecco come stanno le cose”. Come si fosse giunti a quel risultato sarebbe stata un’interessante conversazione, ma non è di quelle in cui il mondo delle notizie tiene a impegnarsi. Come sostiene Gaye Tuchman, in uno studio pionieristico sulle procedure in sala stampa: “l’accettazione delle convenzioni di rappresentazione come realtà fattuale rende la realtà vulnerabile alla manipolazione”.
Allora il giornalismo di pace è a favore della verità, come dev’esserlo qualunque sua variante: ovviamente i reporter devono riferire i fatti in cui s’imbattono nel modo più veritiero possibile; ci si chieda pure però come siano arrivati ad imbattersi, in quei fatti specifici, e come i fatti siano giunti a loro. Se sono sempre gli stessi fatti, o lo stesso genere di fatti, si adotti come direttiva lo scovare storie importanti o particolari importanti di tali storie, che altrimenti sguscerebbero fuori dalle notizie, trovando il modo di reinserirveli. E si cerchi di lasciare gli altri inseriti nel processo, discutendo ed esponendo come siano stati messi insieme dei racconti di parte. Il giornalismo di pace è quello che abbonda in indizi e bandoli per suggerirci e attrezzarci a negoziare le nostre letture, a ipotizzare significati multipli, a scovare la propaganda e altre rappresentazioni auto-gratificanti all’esterno.
I giornalisti sanno effettivamente fare la loro parte in tutto ciò, e la fanno? Recentemente, dei ricercatori si sono messi a misurare il quoziente di giornalismo di pace in atto. Non c’è probabilmente un solo pezzo di reportage che possieda tutte e cinque le caratteristiche citate più sopra (nella parte II, ndt), evitando contemporaneamente un linguaggio demonizzante, l’etichettatura e così via. Ma ci sono sì distinzioni, e sono state misurate.
Il reportage nelle Filippine, specialmente da parte del giornale principale del paese, il Philippine Daily Inquirer, è interessante nel fornire un contrappeso efficace ai tentativi del governo di importare l’ideologia della guerra al terrorismo applicandola a una ribellione di lunga data. Il quotidiano per cui ho lavorato in passato, l’Independent di Londra, fa parecchio giornalismo di pace, particolarmente nelle sue famose copertine, giustapponendo le versioni ufficiali degli avvenimenti a fatti e domande scabrose. La mia consapevolezza del mondo esterno e del modo in cui opera ha preso forma attorno a vividi documentari di persone come John Pilger, Danny Schechter e Adam Curtis. Esistono innumerevoli altri esempi.
Poi ci sono media indipendenti che proliferano mediante piattaforme basate sul web e su tradizioni a lungo nutrite da giornali alternativi e radio di comunità. C’è un po’ di giornalismo di pace, quindi potrebbe essercene di più.
04.01.10
Titolo originale: ABOUT THIS COLUMN
http://www.transcend.org/tms/article_detail.php?article_id=2286
http://www.transcend.org/tms/article_detail.php?article_id=2301
http://www.transcend.org/tms/article_detail.php?article_id=2302
Traduzione di Miky Lanza per il Centro Studi Sereno Regis


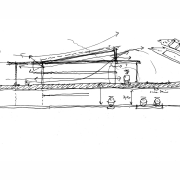
























Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!