Pietro Pinna rifiutò d’impugnare le armi – Amoreno Martellini
Per i redattori di «Crimen» si sarà trattato senz’altro di un diversivo. Il settimanale, molto diffuso all’epoca, si occupava dei casi giudiziari più controversi e curiosi, ma, nonostante il suo serioso sottotitolo recitasse «Settimanale di criminologia e polizia scientifica», aveva fama di indulgere assai allo scandalismo e di presentarsi, fin nella grafica, non certo come un’austera sede di discussione giurisprudenziale, quanto piuttosto come un catalizzatore delle attenzioni più morbose che inevitabilmente il pubblico dei lettori riserva alla cronaca nera. Ma in quel settembre 1949 il settimanale presentò con grande risalto un lungo articolo dedicato a un processo per obiezione di coscienza, quello al giovane ferrarese Pietro Pinna. La grande foto di copertina in bianco e nero ci restituisce l’immagine di un giovane bruno, sorridente nonostante le manette ai polsi, mentre, stretto fra due militari dall’espressione bonaria, attende di essere introdotto nell’aula del tribunale militare di Torino.
Il suo gesto era destinato a gettare il classico sasso nello stagno del dibattito sul pacifismo italiano, portandovi nuovi argomenti e nuovi stimoli. In effetti quello di Pietro Pinna non fu il primo caso di obiezione di coscienza in Italia dopo la fine del secondo conflitto mondiale. A guerra appena conclusa, infatti, nel 1946, il giovane cuneese Rodrigo Castello, appartenente alla Chiesa dei Pentecostali, si era rifiutato di indossare la divisa: processato nel 1947 era stato giudicato colpevole e condannato, ma aveva usufruito dell’amnistia togliattiana ed era stato scarcerato. Pochi mesi più tardi, nel gennaio del 1948, era il soldato di leva Enrico Ceroni di Casale Monferrato, testimone di Geova, a essere condannato per lo stesso reato dal tribunale militare di Torino, che gli aveva comminato cinque mesi e 20 giorni di carcere, con la sospensione condizionale della pena e la non iscrizione. Ma il processo a Pietro Pinna fu senza dubbio quello che fece più scalpore nell’Italia dei convulsi anni della ricostruzione, quello che fece uscire il dibattito sull’antimilitarismo e l’obiezione di coscienza dalle strette conventicole del pacifismo integrale e che si guadagnò un lampo di visibilità presso un pubblico più vasto e una fugace apparizione sulle pagine della stampa nazionale. Un ruolo di battistrada che, con parole piene di commozione, venne sottolineato anche da Tatiana Tolstoj pochi mesi prima della sua morte, in un ideale passaggio di testimone. Durante il processo al giovane obiettore, Tatiana scrisse a Edmondo Marcucci:
“J’ai pleuré de joie en lisant ce que ces courageux jeunes gens font.Le seul moyen de combattre la guerre c’est de se refuser d’y prendre part. Ces malhreux souffriront, mais qui sait s’ils n’ont pas ouvert la voie pour faciliter le chemin aux autres.
Le fait que l’activitè de Pinna a soulevé l’interêt de la presse montre que le public n’est pas indiffèrent à ces sortes de maniféstation.
On y penserà et peut – être les imitera – t – on. Je mourrai plus tranquillement en sachant que des gens pareil éxisistent”.
UN SERVIZIO ALTERNATIVO
Ragioniere poco più che ventenne, impiegato di banca, di origine sarda ma ferrarese di adozione, Pinna era stato chiamato alle armi nel settembre del 1948 e assegnato alla Scuola allievi ufficiali di Lecce. Dopo pochi mesi, nel gennaio del 1949, era maturata la sua crisi di coscienza che lo aveva portato a rifiutarsi di partecipare agli addestramenti militari.
Il suo gesto di disubbidienza era stato accompagnato da una istanza scritta che aveva inviato al ministero della Difesa, nella quale chiedeva che fosse riconosciuto il suo status di obiettore di coscienza e suggellato dalla concessione dell’esonero dal servizio militare. In contropartita Pinna si dichiarava pronto a prestare un servizio alternativo, ma disarmato, anche rischioso, come il rastrellamento di terreni minati.
Fin dalle sue origini, dunque, il dibattito sull’obiezione di coscienza si intrecciò con il problema del servizio civile; né poteva essere altrimenti, dal momento che in tutti gli altri Paesi del mondo in cui l’obiezione di coscienza era giuridicamente riconosciuta e regolamentata (USA e Gran Bretagna in testa) i giovani che rifiutavano l’uso delle armi venivano destinati a servizi civili alternativi. Ma, in questi anni e per tutto il quindicennio successivo, fino all’inizio degli anni settanta almeno, il fulcro centrale del problema era il primato della coscienza individuale sulla legge dello Stato, e la prospettiva di un servizio civile alternativo era del tutto accessoria e marginale nel dibattito generale del problema. Tanto che il corsivo che accompagnava l’articolo di fondo di «Crimen» sul processo Pinna forniva questa esplicita lettura del problema: non sembra molto importante il fatto (se pur utile ai fini contingenti della difesa) che Pietro Pinna si dichiari disposto a saltar per aria rastrellando le mine. Un uomo non ha nessun bisogno di «garantire» di essere un eroe, come si «garantisce» della propria firma in banca. L’eroismo è altamente lodevole e strettamente doveroso quando si tratta di salvare una vita umana in pericolo. Pietro Pinna, a nostro avviso, non ha nessun dovere di farsi ammazzare per dimostrare di non aver paura. Dal ministro della Difesa, anzichè l’attesa esenzione dal servizio militare, arrivarono per Pinna l’esclusione dal corso di allievi ufficiali e la notifica di una nuova destinazione al CAR di Casale Monferrato dove avrebbe dovuto portare a termine la ferma come soldato semplice. Raggiunta la nuova destinazione il giovane ferrarese reiterò la sua istanza con una nuova lettera al ministero e continuò nel suo atteggiamento di disubbidienza, rifiutandosi di prendere parte alle esercitazioni.
Questa volta i suoi superiori lo deferirono al tribunale militare con l’accusa di «disubbidienza continuata» e, in attesa del procedimento, si aprirono per Pinna le porte di una cella: erano le prime settimane di carcere, ma nei mesi successivi molte altre ne sarebbero seguite.
Il processo si celebrò alla fine di agosto, in una piccola aula del tribunale militare di Torino presto riempita da pochi giornalisti e fotografi presenti, dai parenti e amici dell’imputato e da alcuni simpatizzanti e appartenenti ad associazioni pacifiste. La difesa fu affidata a due attivi frequentatori degli ambienti pacifisti nazionali come Bruno Segre e Agostino Buda; importanti anche i nomi dei testimoni della difesa: Umberto Calosso, Aldo Capitini e Edmondo Marcucci.
Il dibattito in aula si svolse secondo un copione che sarebbe divenuto consueto in questo genere di processi: l’imputato, in apertura di dibattito ammise le imputazioni che gli venivano addebitate, dichiarò di non aver ubbidito agli ordini dei superiori e di non aver preso parte agli addestramenti militari. In tal modo svuotò di significato le dichiarazioni dei testimoni dell’accusa, militari e ufficiali presenti al momento della dichiarazione di disubbidienza resa dall’obiettore di coscienza, che ripeterono, con scarsa efficacia, le modalità con cui si erano svolti i fatti. Poi vennero esposti i repertori dialettici dell’accusa e della difesa, anch’essi tendenti a sclerotizzarsi negli anni successivi, sia nelle aule dei tribunali militari, sia nel dibattito all’interno della stampa e in generale della società. L’accusa snocciolò come un rosario i temi dell’articolo 52 della Costituzione repubblicana («liberamente votata», precisava il giudice militare) che prevede per tutti i cittadini l’obbligo di concorrere alla difesa della patria attraverso il servizio militare, e della necessità della risposta armata di fronte a una eventuale aggressione. Il pubblico ministero concluse la sue requisitoria rimproverando la difesa che voleva spostare la discussione sul terreno etico e filosofico, anziché sull’essenza del reato, «con conseguenze ineluttabilmente troppo ardite e rivoluzionarie». Il pubblico ministero concludeva:
“Non possiamo permettere che si vada contro i concetti fondamentali costitutivi; se come uomini possiamo indulgere a considerazioni di carattere etico – morale, come magistrati e militari dobbiamo attenerci scrupolosamente a quanto il codice ci impone. Tutto ciò che turba l’esercito va guardato con occhio sospettoso e severo. Necessita una condanna severa, non tanto per il Pinna, quanto per i principi che voi – giudici rappresentate. Per questo chiedo che il soldato Pinna sia condannato per disubbidienza aggravata e continuata a 18 mesi di reclusione con le conseguenze di legge”.
La difesa insistette sui temi dell’esistenza di una legge superiore a quella dello Stato e della superiorità militare dei Paesi che ammettono l’obiezione di coscienza, chiedendo per l’imputato l’assoluzione con formula piena. Successivamente Pietro Pinna, dopo aver risposto alle domande rivoltegli dal pubblico ministero e dal giudice, rese la sua dichiarazione finale, le cui argomentazioni ripetevano più o meno fedelmente quelle contenute nel memoriale che lo stesso Pinna aveva scritto in carcere, a cui alcuni giornali avevano dato qualche risalto. In esso Pinna esponeva in forma schematica le motivazioni e i principi ispiratori della sua scelta. Le prime erano radicate in un profondo senso di religiosità «tradito» dalla Chiesa cattolica che non aveva saputo dare risposte soddisfacenti, nè sotto l’aspetto spirituale, nè dal punto di vista della dottrina sociale, alle esigenze di rifiuto assoluto della violenza che, affacciatesi nel suo animo fin dall’infanzia,
erano venute a maturazione durante gli accadimenti dell’ultima guerra. Per quel che riguarda i principi ispiratori, Pinna, dopo aver chiarito che nella sua visione religiosa il valore dell’atto religioso è essenzialmente morale e che «il suo giudizio avviene nella coscienza umana (al di fuori di qualsiasi istituzione)», si richiamava ai valori della nonviolenza e della «non – menzogna», riallacciandosi così direttamente alla linea dottrinale che da Tolstoj, attraverso Gandhi, discendeva fino a Aldo Capitini (che, come detto, era presente al processo in veste di testimone della difesa). Il memoriale si chiudeva con una rivendicazione della libertà di coscienza:
“Nessuna legge deve cercar di violentare la coscienza di un individuo al punto di impedirgli di realizzare i suoi destini, di vivere per quei principi a cui si sente nato e nei quali trova la sua ragione di esistenza come uomo. Mi si dice che il dovere di ogni cittadino è innanzitutto quello di servire la patria. Ma io non mi sogno neppur lontanamente di rifiutarmi a questo: chiedo soltanto che la patria escogiti un servizio in cui i suoi figli non siano costretti a tradire i principii della loro coscienza di uomini ed essi allora (ed io con loro, primo) saranno felici e onorati di servirla e di donarlesi”.
La sentenza giunse dopo un’ora di camera di consiglio e fu una via di mezzo con la quale il giudice militare volle far intendere che aveva compreso le profonde motivazioni e la buona fede dell’obiettore, ma non poteva non reprimere un reato che rischiava, a suo modo di intendere, di minare le basi della convivenza sociale: dieci mesi di reclusione con il beneficio della condizionale e la non iscrizione. Ma fu una sentenza che scontentò tutti: il pubblico ministero presentò immediatamente la richiesta di appello per una condanna ritenuta troppo mite; altrettanto fecero gli avvocati della difesa perché la pena venne ritenuta eccessiva e perché non erano state tenuto in alcun conto le attenuanti.
Ma la sentenza del tribunale militare di Torino non concluse l’avventura di Pietro Pinna: la scarcerazione, infatti, lo metteva in condizione di dover di nuovo adempiere al servizio di leva. Così venne immediatamente raggiunto da una nuova cartolina precetto che gli intimava di presentarsi al Centro addestramento reclute di Avellino.
Appena giunto nella caserma, Pinna rinnovò il suo gesto di disubbidienza e ribadì agli ufficiali di turno le motivazioni della sua obiezione di coscienza. Di nuovo chiuso in cella, venne tradotto al carcere militare di Sant’Elmo a Napoli, dove subì un processo per direttissima.
I giudici militari agirono con tanta fretta che non fu possibile all’imputato chiamare i suoi difensori di fiducia (il solo Umberto Calosso poté assistere al processo) e gli venne così assegnato un difensore d’ufficio che «fece una carica a fondo contro l’obiezione di coscienza». Egli prese la parola quattro volte nel corso del dibattimento: la prima per chiedere che l’onorevole Calosso potesse essere ascoltato come teste della difesa; la seconda per rimproverare lo stesso Calosso per la dichiarazione resa («le aule dei Tribunali – lo avrebbe ammonito – non sono delle cattedre e, tanto meno, delle piazze adatte a propagandare nuove dottrine»); la terza per chiedere, quasi incredulo, se effettivamente fosse stato impartito l’ordine col quale si intimava a Pinna di prestare servizio ed eseguire le esercitazioni; ricevuta risposta affermativa da tutti i testimoni e dallo stesso Pinna, prese la parola un’ultima volta in tono sconsolato, per rimettere l’imputato alla clemenza della corte.
NUOVA CONDANNA
La nuova sentenza, pronunciata il 5 ottobre 1949, comminò altri otto mesi di reclusione all’obiettore, che venne riportato nel carcere di Sant’Elmo.
Le gravi irregolarità in fase di istruttoria e di celebrazione del processo, però, non passarono inosservate. Nei giorni successivi lo stesso Calosso presentò una interpellanza parlamentare al governo, parlando di un «imbroglio legale» commesso dai giudici militari ai danni del giovane obiettore.
Ma l’azione del parlamentare socialista in sede istituzionale non si arrestò all’interpellanza: nel novembre successivo, infatti, prendendo spunto dal caso Pinna, egli fece la mossa più importante, presentando, insieme al democristiano Igino Giordani, la prima proposta di legge dell’Italia repubblicana per il riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza. Essa prevedeva per i giovani che si fossero formalmente dichiarati obiettori il passaggio obbligato davanti a un giudice militare, ma quest’ultimo avrebbe avuto facoltà, se riconosciuti fondati i motivi dell’obiettore, di destinarlo a servizi non armati, comunque non riconducibili a una qualsiasi forma di collaborazione con la preparazione di una guerra. La Camera dei deputati decise con larga maggioranza di rimandare l’esame della proposta di legge alla Commissione competente, e questa risoluzione venne interpretata dai firmatari come un primo successo. Alcuni giorni dopo il presidente della Repubblica Einaudi e il presidente del Consiglio De Gasperi ricevettero un appello firmato da oltre venti parlamentari britannici – anch’esso ripreso da parte della stampa nazionale – per la scarcerazione di Pinna e per l’adozione di una legge che riconoscesse i diritti degli obiettori di coscienza. Insomma, il caso Pinna iniziava a fare troppo chiasso, più di quanto non fosse prevedibile, ed era necessario chiuderlo e archiviarlo in fretta. La sua conclusione ha qualcosa di grottesco, ma racchiude al tempo stesso i consueti vizi di fondo di certi ambiti della vita nazionale.
Il 29 dicembre 1949 fu comunicato a Pinna ch’era libero, per l’amnistia dell’Anno Santo. Pinna firmò il rifiuto del condono, ma fu obbligato lo stesso a uscire! Mandato a Bari [al 9° reggimento fanteria, n.d.a.] nel gennaio 1950, rinnovò l’obiezione di coscienza. Ma ecco la sorpresa: a Bari il medico militare volle a tutti i costi visitarlo, gli riscontrò una inesistente «nevrosi cardiaca» per cui Pinna fu riformato e congedato!
Il 12 gennaio 1950 Pinna riabbracciava i suoi familiari a Ferrara dove riprese il suo lavoro d’impiegato bancario.
Tratto da “FIORI NEI CANNONI” di Amoreno Martellini (editore Donzelli, Roma, 2006, euro 24.50) e pubblicato su «L’incontro», anno LX – n. 9 – dicembre 2008




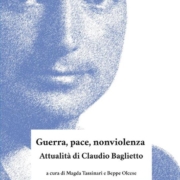
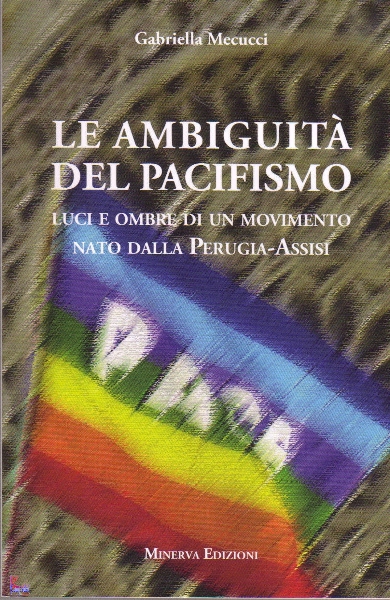




















Trackbacks & Pingbacks
[…] Pinna fu il primo italiano a rifiutare di indossare la divisa, non in nome di una fede, ma per le sue convinzioni etiche, […]
[…] (foto: serenoregis.org) […]
[…] L’oggi ottantasettenne Pietro Pinna, primo obiettore condannato alla reclusione nel 1948, pronunciò queste parole durante il processo: […]
I commenti sono chiusi.