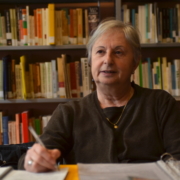Che cosa è il giornalismo di pace? – Jake Lynch
 Questo è il primo editoriale di Jake Lynch di una serie settimanale in esclusiva per Transcend Media Service. Jake è professore associato e direttore del Centro Studi Pace e Conflitti all’università di Sidney. In precedenza ha passato quasi vent’anni nel giornalismo, compresi periodi come lettore e presentatore alla televisione BBC World, corrispondente politico per Sky News e Corrispondente da Sydney per il quotidiano Independent. Ha riferito su conflitti in Medio Oriente, Asia sud-orientale ed Europa sud-orientale, nonché su innumerevoli incontri politici e diplomatici e successivi sviluppi in Gran Bretagna e altrove in Europa. E’ coautore, insieme ad Annabel McGoldrick, di Peace Journalism (Hawthorn Press, 2005) ed è appena uscito – da Sydney University Press e TRANSCEND University Press – il suo nuovo libro Debates in Peace Journalism. Insieme ad Annabel McGoldrick e Johan Galtung è anche autore di Reporting Conflict (in spagnolo Reporteando Conflictos-Una Introducción al Periodismo de Paz (Ariete, TRANSCEND México, Respuestas para la Paz, 2006).
Questo è il primo editoriale di Jake Lynch di una serie settimanale in esclusiva per Transcend Media Service. Jake è professore associato e direttore del Centro Studi Pace e Conflitti all’università di Sidney. In precedenza ha passato quasi vent’anni nel giornalismo, compresi periodi come lettore e presentatore alla televisione BBC World, corrispondente politico per Sky News e Corrispondente da Sydney per il quotidiano Independent. Ha riferito su conflitti in Medio Oriente, Asia sud-orientale ed Europa sud-orientale, nonché su innumerevoli incontri politici e diplomatici e successivi sviluppi in Gran Bretagna e altrove in Europa. E’ coautore, insieme ad Annabel McGoldrick, di Peace Journalism (Hawthorn Press, 2005) ed è appena uscito – da Sydney University Press e TRANSCEND University Press – il suo nuovo libro Debates in Peace Journalism. Insieme ad Annabel McGoldrick e Johan Galtung è anche autore di Reporting Conflict (in spagnolo Reporteando Conflictos-Una Introducción al Periodismo de Paz (Ariete, TRANSCEND México, Respuestas para la Paz, 2006).
Si fa giornalismo di pace quando redattori e inviati compiono scelte – su che cosa riferire e come – che creano per la società nel suo complesso opportunità di considerare e valutare risposte nonviolente ai conflitti.
Se i lettori e il pubblico, pur muniti di tali opportunità, decidono di preferire la guerra alla pace, non c’è altro che il giornalismo possa fare, rimanendo tale. Peraltro, non c’è impegno uguale all’assicurare un equo ascolto alle reazioni violente, non foss’altro perchè di rado si disputano lo spazio nell’agenda degli elaboratori di notizie.
Come mai? Riferire è scegliere. “Riferiamo solo i fatti” dicono i giornalisti, ma i fatti sono una categoria di dimensioni praticamente infinite. Perfino in questi tempi di media a profusione, bisogna restringerla per ridurla a notizie. Il giornalista è un portinaio che dà accesso ad alcuni aspetti della realtà, affinché emergano lampeggianti allo sguardo pubblico; e lascia il resto nel buio.
Neppure è tale processo casuale. I pezzi lasciati fuori sono sempre o per lo più gli stessi o della stessa specie. Le notizie generalmente preferiscono le fonti ufficiali a qualsiasi di quelle alla “base”; preferiscono l’evento al processo; e come modello base per i conflitti una battaglia da due parti per la supremazia.
Queste preferenze, o preconcetti, si sono cristallizzati in convenzioni professionali allorché il giornalismo cominciò a essere venduto come prodotto di serie nella società consumistica e si trovò di fronte alla pressione di proporsi come “tutto quanto per tutti”, in grado di essere commercializzato a potenziali lettori/ascoltatori/spettatori di ogni visione politica e di nessuna.
Citare funzionari – una categoria sovrastata dal capo politico del proprio paese – è una scelta e una preferenza, con però un alibi incorporato. Non è “colpa” nostra se il/la tale è diventato/a capo del governo: semplicemente lo è. Seguire un indice, ossia l’inveterata usanza giornalistica di restringere la portata del dibattito alle differenze fra governo e opposizione ufficiale – discordia d’élite – ha lo stesso effetto, di camuffare le scelte da fatti.
E in quanto al rapporto evento/processo? Le notizie che si nutrono, diciamo, dei dettagli di morte e distruzione causati da una bomba, evitano la controversia: l’ordigno è indiscutibilmente saltato, ci sono cifre comprovate sulle vittime, da fonti affidabili come ospedali e polizia. Quello che è automaticamente più controverso è sondare perché gli autori lo abbiano fatto, quale sia stato il processo che ha condotto a quell’esito, quali siano state le loro angustie e motivazioni.
In quanto al dualismo, beh, quand’ero corrispondente alla BBC, ci si rendeva tutti conto che una carriera di successo poteva basarsi sulla seguente formula: ‘da un lato … d’altro canto … alla fin fine solo il tempo potrà stabilire’. Avere “equilibrio”, “sentire tutt’e due le campane” è un modo affidabile per isolarsi da lamentele di unilateralità o settarismo.
Il giornalismo di guerra e il suo antidoto
Ci sono ragioni situate in profondità, allora, per cui siano queste le convenzioni dominanti nel giornalismo, ma, prese insieme, significano che la sua cornice di dibattiti pubblici su conflitti e derivati è generalmente incline alla reazione violenta, meritando la definizione di “giornalismo di guerra”.
Come mai? Per cominciare, il dualismo. Se si inizia col pensare un conflitto come un tiro alla fune fra due grandi avversari, ogni mutamento nel loro rapporto, ogni mossa, finisce per aver luogo su un solo asse, come in un tiro alla fune, guadagnare un metro da una parte corrisponde a perderlo dall’altra; sicché ogni sviluppo in un conflitto così concepito comporta senz’altro la sua valutazione nell’ambito di una partita a somma zero. Qualunque cosa non sia inequivocabilmente un vincere rischia di essere riferito come un perdere. Costituisce un incentivo bell’e fatto a insistere negli sforzi di vittoria, o a un’escalation. I coinvolti in un conflitto parlano duramente, e sovente agiscono duramente, recitando per uno scenario che hanno creato i media.
Se si tolgono dal contesto atti di violenza politica si lascia solo ulteriore violenza come reazione possibile. Ecco perché ci sono così poche notizie su iniziative di pace: se non si vedono in filigrana cause di sorta, allora non c’è nulla da sistemare. Solo in questa forma di reportage ha un qualche senso, per esempio, vedere il “terrorismo” come qualcosa cui è possibile o sensato fare la “guerra”.
E se invece si aspetta a riferire delle cause soggiacenti quando farà comodo ai capi politici parlarne od occuparsene, può darsi che si debba aspettare un bel po’. Stimoli verso la pace quasi invariabilmente cominciano dal basso. C’è inoltre in mano al governo una leva che non ha nessun altro: l’uso “legittimo” della forza militare. Per tutte queste ragioni, il primato delle fonti ufficiali, in coppia con il perdurante orientamento nazionale di gran parte dei media, è proclive alla rappresentazione forzosa del conflitto a favore di una pronunciata ricettività dei promotori di violenza.
Da qui il giornalismo di pace, come rimedio strategico e tentativo di aggiungere nuove convenzioni alle vecchie per dare un’opportunità alla pace.
Giornalismo di pace:
esplora i retroscena e i contesti del formarsi del conflitto, presentando cause e opzioni per ogni parte (non solo “entrambe le parti”);
dà voce alle opinioni di tutte le parti rivali a ogni livello;
offre idee creative per la risoluzione del conflitto, la sua maturazione, il peacemaking e il peacekeeping;
espone bugie, tentativi di agire sottobanco e colpevoli di ogni parte e rivela gli eccessi commessi da e le sofferenze inflitte a chiunque da parte di chiunque;
presta attenzione alle storie di pace e agli sviluppi post-bellici.
Realtà e rappresentazione
Il giornalismo di pace è più realistico, nel senso di fedele a una realtà già esistente, indipendentemente dalla nostra conoscenza o rappresentazione di essa. Riferire la violenza senza uno sfondo o un contesto è rappresentarla malamente poiché ogni conflitto è alla radice una relazione di parti che si pongono e perseguono obiettivi incompatibili. Ometterne una trattazione è una distorsione.
Al tempo stesso tale giornalismo riconosce che non c’è una versione corretta di tale realtà sulla quale ognuno concorderebbe. Il mondo circostante si capisce assumendone messaggi e immagini – ivi comprese quelle ammanniteci dai media – e inserendoli in codici mentali che sviluppiamo nel corso della nostra vita. Il senso non si crea unicamente all’atto della produzione, o codifica; nessun atto di rappresentazione è completo finché non sia ricevuto, o decodificato. La decodifica è qualcosa che facciamo spesso automaticamente, dato che molto di ciò che leggiamo, udiamo o vediamo ci è familiare: Su questo si basa la propaganda – stabilire Saddam Hussein come cattivo o le armi di distruzione di massa come una minaccia, e ciò forma un prisma attraverso il quale si tende a vedere tutta la realtà, sia previa che successiva.
Il giornalismo è sovente facile preda di tali sforzi in quanto generalmente non ci incoraggia a riflettere sulle scelte che compie, per i motivi suddetti. Il famoso conduttore di dibattiti televisivi USA Walter Cronkite concludeva ogni sera il suo Notiziario Serale CBS con la sua formula “è così che va”. Sarebbe stato interessante conversare su come fosse giunto ad essere “così”, ma non è qualcosa cui le notizie generalmente tengano.
Gli studenti di comunicazione riconosceranno o negli ultimi paragrafi una versione abbreviata della teoria della ricezione.. Scrivendo questa introduzione ho evitato le fonti accademiche perché, ebbene sì, i cliché sono veri, gli studiosi dei media spesso si vestono effettivamente in nero (cosa che non gli verrà contestata) e masticano polisillabi a colazione (cosa che invece gli potrebbe essere contestata), ma vale la pena citare un famoso aforisma coniato da una ricercatrice brava e originale, Gaye Tuchman: “l’accettazione delle convenzioni rappresentative come fattualità rende la realtà vulnerabile alla manipolazione”.
Quindi il giornalismo di pace è a favore della verità, come dev’esserlo qualunque sua specie. Ovviamente i corrispondenti dovrebbero riferire, fedelmente quanto possono, i fatti in cui s’imbattono; solo dovrebbero chiedersi come ci s’imbattono e come questi fatti s’imbattono in loro stessi. Se sono sempre i soliti fatti o della solita specie, si adotti come prassi la ricerca di storie importanti e loro dettagli importanti, che altrimenti sfuggirebbero alla gamma di notizie, escogitando modi per ricondurvele. E si tenti di lasciare gli altri intenti al processo. Il giornalismo di pace è quello che abbonda in cenni e bandoli per suggerirci e metterci in grado di negoziare le nostre letture, di aprirci a significati molteplici, d’ispezionare la propaganda e altre rappresentazioni auto-appaganti dell’esterno
. Possono i giornalisti effettivamente farlo, e lo fanno? Ultimamente, i ricercatori si sono proposti di misurare la quantità di giornalismo di pace in atto. Non c’è probabilmente neppure un pezzo con tutt’e cinque le caratteristiche sopra elencate e che contemporaneamente eviti un linguaggio demonizzante e l’apposizione di etichette e quant’altro. Ma esistono pur sempre distinzioni, che sono state appunto misurate. Il modo di riferire nelle Filippine, specialmente da parte del quotidiano principale del paese, il Philippine Daily Inquirer, è interessante per fornire un contrasto efficace ai tentativi del governo di importare l’ideologia della guerra al terrorismo per applicarla a una sedizione da tempo in atto. Il giornale per cui lavoravo, l’Independent di Londra, svolge parecchio giornalismo di pace.
Poi ovviamente stanno proliferando media indipendenti, che si stanno strutturando, sulla base di piattaforme web, su tradizioni nutrite a lungo da giornali alternativi e stazioni radio comunitarie. C’è un certo giornalismo di pace, quindi potrebbe essercene di più. Che cosa ci vorrebbe, e come potremmo tutti partecipare nel farlo avvenire, saranno oggetto di futuri articoli di questa serie.
Titolo originale:
WHAT IS PEACE JOURNALISM?
http://www.transcend.org/tms/article_detail.php?article_id=400
Traduzione di Miky Lanza per il Centro Studi Sereno Regis